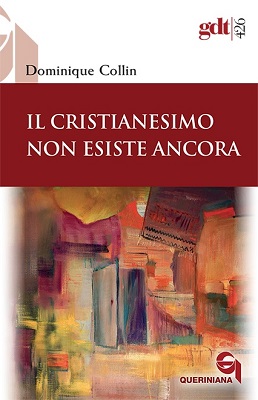
«Cristiani non si nasce, ma si diventa»: già ne era convinto Tertulliano (Apologeticus, XVIII, 4). Per Gregorio di Nissa (Homiliae in Canticum, 8), la vita cristiana è un ricominciare sempre, di inizio in inizio, attraverso inizi che non hanno mai fine.
Negli Atti degli Apostoli i cristiani sono chiamati «gente della Via» (At 9,2), cioè uomini e donne in cammino, alla sequela di Gesù che di se stesso dice «io sono la via, la verità e la vita» (Gv 14, 6). L’immagine del cammino ricorda che la relazione con il Signore Gesù non può continuare per inerzia, ma ha bisogno di un rinnovato impulso e del coraggio della perseveranza.
In Ora prima (Edizioni Qiqajon 1997, p. 7) Erri De Luca scrive che «credente non è chi ha creduto una volta per tutte, ma chi, in obbedienza al participio presente del verbo, rinnova il suo credo continuamente».
Nella bella Lettera ai cercatori di Dio del 12 aprile 2009 i vescovi italiani giungono a definire il credente come «un ateo che ogni giorno si sforza di cominciare a credere» (cap. I, § 5).
Francesco Cosentino (in Immaginare Dio. Provocazioni postmoderne al cristianesimo, Cittadella Editrice 2010, p. 90) scrive: «Il cristiano autentico vive la condizione esodale dell’inquieto cercatore delle tracce di Dio, senza ritenere mai un possesso acquisito i piccoli traguardi della fede; egli è un viandante e un pellegrino luminoso impegnato, pur attraverso il dubbio e la ferita del dover imparare quotidianamente a credere, a fuggire ogni sterile staticità e ogni fissazione sulle tradizioni umane».
Avverto di essere molto a mio agio con questo genere di riflessioni. Mi sono tornate alla mente nel corso della lettura di un saggio del teologo e filosofo belga, già priore della comunità domenicana di Liegi, Dominique Collin: Il cristianesimo non esiste ancora (Editrice Queriniana 2020).
Nella scelta del titolo l’autore afferma di essersi ispirato ad un passo decisamente corrosivo del Diario di Søren Kierkegaard: «Il cristianesimo del Nuovo Testamento non esiste assolutamente».
Il filosofo e teologo danese della prima metà del XIX secolo, padre dell’esistenzialismo cristiano, riteneva infatti che un cristianesimo senza Vangelo fosse solo un simulacro inventato dai cristiani per non dover conformare la loro vita alla Parola di Cristo. Era convinto che un cristianesimo della domenica, superficiale e leggero, non fosse conforme al Vangelo del Regno annunciato da Gesù di Nazaret (p. 7).
In che senso «il cristianesimo non esiste ancora» ?
Per Dominique Collin il titolo del libro non è sinonimo di «cristianesimo che non esiste o non esisterà più». Al contrario, l’attuale epoca di scristianizzazione può costituire un’opportunità per l’insieme dei cristiani, a condizione che essi ritrovino l’inaudito (il sorprendente, l’inatteso, l’incompiuto, l’inascoltato) del Vangelo, che sostanzialmente significa accogliere la forza di richiamo del Regno di Dio, come ci invitano a fare le parole inaugurali del vangelo di Marco (p. 13): «Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo» (Mc 1,15). «Il cristianesimo può essere compreso solo attraverso la testimonianza del modo in cui il Vangelo diventa il motore della nostra esistenza» (p. 152).
Il cristianesimo non esiste ancora perché nessuna persona, nessun gruppo, nessuna cultura, nessun sistema di pensiero, nessuna Chiesa può dirsi cristiana senza riconoscere che deve ancora diventarlo relativamente al «Regno di Dio» (p. 20) che del cristianesimo è la forza di richiamo e l’apertura insuperabile (p. 13).
Dire che il cristianesimo non esiste ancora significa pensare che l’evento-Cristo che gli ha dato origine procede «da un a-venire che non può mai essere confuso con il presente, altrimenti questo evento diventerebbe esso stesso un fatto passato» (p. 35).
Il cristianesimo non esiste ancora «perché ciò che lo renderà possibile dipende da noi», nella consapevolezza «che ciò che dipende da noi è già l’effetto di un dono di cui non siamo padroni, ma che siamo invitati ad accogliere nella fede, nell’amore e nella speranza» (p. 36).
Il cristianesimo non esiste ancora perché «l’evento-Cristo non è ancora perfettamente compiuto nelle nostre vite» (p. 40) e «non è ancora stato sperimentato in tutta la sua estensione e profondità (p. 35).
Il cristianesimo non esiste ancora vuol dire che «il cristianesimo non è un fatto avvenuto, ma un evento il cui senso definitivo avverrà solo quando tutta l’umanità sarà messa in relazione con tutti i possibili che il Vangelo rende possibile» (p. 47)».
Che fare, dunque, perché il cristianesimo, distinguendosi dall’insulsaggine e verbosità del «blabà» (p. 56), possa essere «parlante» (p. 15) anche in una società che sembra l’averlo condannato alla peggiore delle sventure, cioè all’insignificanza (p. 16)?
Nell’opera di Dominique Collin, che non è di agevole lettura, mi sembra che si possano cogliere almeno tre risposte.
Passare da un cristianesimo di appartenenza ad un cristianesimo di esperienza
In primo luogo, è necessario transitare da un cristianesimo di appartenenza (cristianità) ad un cristianesimo di esperienza (cristicità).
Mentre nel cristianesimo di appartenenza è paradossalmente possibile dirsi cristiani senza credere e senza vivere la propria fede (p. 22), il cristianesimo di esperienza rimanda sempre ad un eccesso, ad una ulteriorità costituita dal Regno di Dio (p. 23) che è il valore supremo dl cristianesimo (p. 132).
Un cristianesimo di appartenenza vende identità e sicurezze; un cristianesimo di esperienza «non smette mai di invitare al rischio della fede» (p. 25).
Il cristianesimo di appartenenza «chiede al Cristo solo di essere il suo fondatore»; per un cristianesimo di esperienza «il Cristo è colui che ci precede sul cammino di una vita nuova» in quanto fondamento vivente e orizzonte insuperabile (p. 28) della nostra fede.
Oggi ad essere necessaria non è l’affermazione del cristianesimo come appartenenza, ma «solo la proclamazione del Vangelo come Vangelo e l’esperienza di vita nuova che questa proclamazione rende possibile» (p. 30). «Se non è verificato nell’esistenza, il cristianesimo perde la condizione che l’ha reso possibile un tempo. Il cristianesimo non è bell’e fatto, ci resta da inventarlo pensando in modo diverso ciò che lo ha reso possibile» (p. 34). La vocazione del cristianesimo non è quella di «conservare il Vangelo, ma di inventarlo come parola capace di dire all’essere umano di oggi a quale vita vivente egli è promesso» (p. 36).
Se – come attestato da At 9,2 – i cristiani sono «gente della Via» e Gesù è «la Via» (Gv 14,6), va detto che l’evento-Cristo è davanti a noi perché egli ci precede doppiamente: come «origine assente» è prima di noi sulla via che va verso la Galilea del mondo e, come «a-venire mancante», è davanti a noi – «là lo vedrete, come vi ha detto» (Mc 16,8) – come figura di chiamata e di promessa (p. 42).
Conclusivamente, le pagine di Dominique Collin segnalano e motivano l’urgenza di un cristianesimo come esperienza di vita autenticamente vissuta, «come esperienza di vita vivente» (p. 49).
Si può dire che il significato ultimo del cristianesimo sia la “cristicità”, come qualità di chi è “cristico”, non nel senso delirante di credersi Gesù di Nazaret e nemmeno nel senso scimmiottesco di voler imitare Cristo, ma nel senso di essere talmente «ghermiti da Gesù Cristo» (Fil 3,12) da condurre uno stile di vita che incarna nell’oggi la Parola del Vangelo, «potenza di vita buona capace di salvarci dalle nostre propensioni nichiliste» (p. 48) e indurci ad una conversione/metanoia che – come da At 11,18 – ci apre alla Vita (p. 45).
Passare da una religiosità bigotta al Vangelo detto con parresia
Un altro passo da compiere perché il cristianesimo possa esistere consiste, secondo Dominique Collin, nel transitare da una religiosità bigotta ad un modo di dire e testimoniare il Vangelo – «potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede» (Rom 1,16) – con parresia, cioè con coraggio e franchezza. Intendendo per «religiosità bigotta» non «le cosiddette devozioni popolari, come il rosario o i pellegrinaggi, ma una forma di religiosità narcisistica che può benissimo coesistere all’interno di ogni cristiano», dal momento che in ogni uomo o donna cristiana, «il credente sta a fianco del pagano» (p. 64).
Bigotta è la devozione che dà troppa importanza alle forme esteriori di religiosità, ai suoi aspetti più tradizionali e più sentimentali. Bigotta è la religiosità sdolcinata, insipida e banale che finisce con l’essere comoda e inoffensiva e con l’esaltare idee vuote per dispensarci dalla fatica di accogliere nella nostra esistenza la Parola di vita presente nelle Scritture Sacre (p. 63).
Il linguaggio bigotto, abbondantemente presente nello spazio pubblico, nei media, nella politica e persino nell’economia, è la tentazione permanente del cristianesimo (p. 139) e ha a che fare con ogni discorso che non è prodotto dalla parresia (p. 66). È un linguaggio verboso e chiacchierone (p. 138). È la contraffazione del linguaggio evangelico perché ne offre «una versione fiacca ed edulcorata» che, scimmiottando la grazia, «afferma grossomodo che (…) la salvezza consiste essenzialmente nel trovare armonia e benessere nel quotidiano» (p. 140).
La bigotteria deve lasciare spazio alla parresia. Termine restio ad essere tradotto, la parresia «è il parlato giusto e vero, in una sicurezza solida che viene dalla fede e dalla speranza e non da una convinzione o da un sapere» (p. 65).
La Parola del Vangelo è detta e testimoniata con parresia se è «significativa» e «veridica» (p. 67). Il linguaggio cristiano è “significativo” se entra in relazione con la vita o l’esistenza di qualcuno, se parla di me e a me per farmi non vivacchiare ma vivere in modo diverso. Ed è “veridico” se è detto in modo tale da impegnare chi lo dice a qualcuno (p. 68), se parla e non recita (p. 71). La Parola del Vangelo è significativa e veridica quando, rivolta a me, dà alla mia vita un orientamento e uno stile che si ispira al Vangelo, evitando la tendenza a snocciolare banalità astratte (p. 72). Il linguaggio della parresia vivifica e ispira speranza (p. 173).
Non è sufficiente – ricorda Dominique Collin – tradurre il messaggio cristiano nel linguaggio degli uomini e delle donne di oggi. Il messaggio cristiano è «un evento di parola che bisogna dire con parresia», e «ciascuno è convocato personalmente da una parola che lo motiva a parlare, non come un ripetitore, ma come un creatore» (p. 178). Invece di parlare del Vangelo, i cristiani dovrebbero «imperativamente far parlare il Vangelo» (p. 179) con la loro vita. E lo potranno fare solo se il Vangelo diventerà – secondo l’immagine di Ger 20,9 – come un inestinguibile fuoco interiore.
Anteporre la fede alla credenza
Un terzo passo da compiere per ovviare al cristianesimo incompiuto richiede che alla credenza sia anteposta la fede.
Anteporre la fede alla credenza è di decisiva importanza perché non sappiamo più che cosa sia la fede, avendola «sostituita con un assenso più o meno convinto a una dottrina o a quella che chiamiamo, senza convinzione, la spiritualità o, ancora, più pigramente, la ricerca di senso» (p. 15).
La credenza non cerca tanto di essere vera quanto di essere creduta, mentre la fede non cerca tanto di essere creduta quanto di essere vera (p. 121). La fede è contraria alla rassegnazione; non è né fiacca né oziosa (p. 114). Per la credenza Dio è un’idea; per la fede Dio è Vita, Vita vivente, Parola che chiama l’essere umano a esistere (pp. 184-185).
La vitalità del cristianesimo non si misura con l’inflazione di parole pronunciate sui più vari argomenti, ma con il cambiamento che essa conferisce a tutta la vita (p. 139): «Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli» (Mt 7,21). La credenza s’interroga sull’esistenza di Dio, la fede su chi siamo noi davanti a Dio (p. 187).
Dal momento che la fede sembra essere «divenuta un’opinione teorica più o meno convinta, che si recita con più o meno restrizioni mentali dicendo il Credo la domenica a messa» (p. 116), va detto che il contenuto della fede cristiana e la sostanza della vita dei cristiani e delle cristiane, più che il catechismo o il Credo, è il Regno di Dio. La metafora del Regno «è il solo oggetto della fede che non la fa scadere in credenza» (p. 180).






Dovremmo e dovremo leggere il libro di Collin per capire come stanno le cose, perché se quanto esposto dall’ottimo Lebra (leggo sempre le sue recensioni, complimenti!) enuclea correttamente la tesi di fondo dell’autore, occorre dire francamente che con l’antica distinzione fede-credenza non facciamo molta strada. Il cristianesimo è certamente fede, ma esso non sussisterebbe se non fosse avviluppato alla credenza – che significa, comporta, implica anche dogma, istituzione, rito…
Siamo sicuri di ricevere da simili approcci nuove sollecitazioni a pensare la fede, o non ci ritroviamo di nuovo in quell’esercizio retorico raffinato ma inconcludente – di cui il parlare cristiano-teologico da diverso tempo dà prova – senza mai entrare nella TRAGEDIA della fine della credenza e del darsi di una fede esistenziale che si fa fatica a dire cristiana, perché non coinvolta né con il dogma né con l’istituzione?
Sarà mai possibile una fede cristianamente ispirata quando viene meno la credenza nel dogma cristiano e in tutto quello che esso comporta? Questo è quello che occorre pensare. Senza ghirigori retorici.