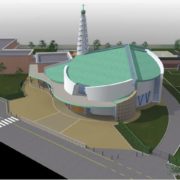Nel discorso che ha rivolto ai delegati della Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl) il 28 giugno 2017, papa Francesco ha affermato: «Certo, la persona non è solo lavoro… Dobbiamo pensare anche alla sana cultura dell’ozio, di saper riposare. Questo non è pigrizia, è un bisogno umano. […] La persona non è solo lavoro, perché non sempre lavoriamo, e non sempre dobbiamo lavorare».
Ovviamente – sostiene il pontefice in altri passaggi del discorso – questo ozio non significa non fare nulla, ma sospendere l’attività lavorativa per dedicarsi ad altri aspetti altrettanto importanti della vita, soprattutto alle relazioni interpersonali. Insomma, anche il tempo del riposo può e deve essere fruttuoso.
Oltre il lavoro
Queste parole del papa sono molto importanti nel nostro tempo, nel quale non di rado, in nome dell’efficienza e della necessità di competere, si rischia di vedere il lavoro come un bene assoluto e il riposo come meramente funzionale ad esso.
In altre parole, secondo questa logica, ci si dovrebbe riposare solo per poter ricominciare a lavorare.
In realtà, sia l’ozio che l’attività lavorativa sono funzionali ad un’esistenza umana sana, in cui ci deve essere l’operare per far crescere questo mondo, ma anche il tempo in cui si esce dalla logica della produttività per gustare semplicemente la bellezza della propria vita e, inscindibilmente, di quella degli altri.
Per chi è cristiano, ambedue questi momenti non possono che essere vissuti per il Signore, che ci chiama sia a collaborare con la sua azione a beneficio della creazione che a fermarci per poterla godere insieme a lui.
Accanto a questo, poi, il riposo svolge un’importante funzione di purificazione interiore da un modo sbagliato di lavorare. Anche il lavoro, infatti, può diventare un idolo, cioè divenire la dimensione fondamentale della vita e finire per prendere il posto di Dio. Questo avviene quando si sente di valere qualcosa nella misura in cui si riescono a svolgere molte attività, si guadagnano tanti soldi o si esercita un certo potere su altre persone. Come tutte le esperienze umane, però, anche il lavoro finisce, e fa crollare quella fallace stima di sé che è fondata unicamente su di esso.
Il lavoro pastorale
Se queste considerazioni possono sembrare abbastanza scontate, forse non lo è il ritenere che anche il lavoro pastorale rientri a pieno titolo in queste dinamiche. In altre parole, proprio quelle attività ecclesiali che riempiono l’agenda dei pastori della Chiesa, e a cui anche molti laici e consacrati dedicano ampie porzioni del loro tempo, possono diventare un idolo, cioè qualcosa che lentamente prende il posto di Dio. In effetti, si possono svolgere con dedizione ed efficacia molti servizi, ma non per il Signore, quanto per l’affetto che si riceve, per la soddisfazione di fare delle cose importanti o, peggio, per esercitare una sorta di potere su altre persone. A quel punto la vita si riempie di tantissime attività, non però per vera necessità pastorale, ma perché non se ne può fare a meno.
Per questo, si possono assumere molti più incarichi di quelli che si riescono effettivamente a svolgere in modo adeguato, per poi viverli in modo rapsodico e mediocre: ad esempio, mettendo lo zampino un po’ dovunque in modo superficiale senza dare mai un contributo realmente significativo, o limitandosi ad incarnare in modo sbrigativo dei ruoli decisionali distaccati dalla prassi che, alla fine, non incidono affatto su di essa.
Nei nostri contesti ecclesiali derive del genere possono essere favorite dal fatto che non abbiamo molti strumenti per verificare la qualità delle attività pastorali, anche per il fatto che esse dipendono primariamente dalla grazia, la cui azione non è misurabile da parte nostra. In questo modo, però, non suona alcun campanello di allarme se si affidano ad una persona più compiti di quelli che può realmente svolgere, lasciandole parimenti la più totale libertà di decidere che cosa realmente fare e con quali modalità. Se manca una verifica sulla qualità del lavoro pastorale, infatti, vengono meno anche i segnali che dicono che qualcuno sta lavorando male, e forse perché sta facendo troppe cose.
Certo, questa logica favorisce una grande operosità, che però con gli anni rischia di diventare ciò che dà senso alla vita. Questo rende fortemente traumatico il farsi da parte quando l’età o le condizioni di salute lo richiedono, con pesanti conseguenze per se stessi e per le comunità cristiane. Dopo che, per molti anni, si è vissuti per il lavoro pastorale, il fare un passo indietro diventa quasi impossibile.
Generosi sì, ma pronti a lasciare
Alcune Chiese locali hanno messo in campo soluzioni specifiche a questo problema. Ad esempio, per quanto riguarda gli incarichi dei presbiteri, l’arcidiocesi di Chicago da tempo ha stabilito che ogni parroco lasci il proprio incarico a 70 anni, pur potendo godere di un’eventuale deroga su base annuale fino ai 75, e che quindi abbia la possibilità di andare in un’altra parrocchia come collaboratore, con la libertà di svolgere i servizi che ritiene di poter fare. Ovviamente opzioni di questo genere non possono essere introdotte nella nostra realtà italiana perché porterebbero ad una drastica diminuzione del numero dei parroci e quindi alla necessità di una riprogettazione complessiva della pastorale.
Ovviamente, opzioni di questo genere non possono essere introdotte nella nostra realtà italiana perché porterebbero ad una drastica diminuzione del numero dei parroci e, quindi, alla necessità di una riprogettazione complessiva della pastorale.
Quello che si può fare fin da ora è prepararsi personalmente alla fine del proprio lavoro, e il riposo indicato da papa Francesco, se viene vissuto come un’anticipazione di tale condizione, diventa una via di purificazione interiore molto utile.
Non si tratta, ovviamente, di diventare pigri o poco disponibili, ma di vigilare che uno specifico servizio non prenda il posto di Dio nel proprio cuore, che cioè non diventi il senso della propria vita, in modo da essere pronti a lasciarlo quando si sarà richiesti da farlo.
Ci si prepara così a dare quella bella testimonianza che i più giovani vorrebbero vedere nei credenti più anziani, siano essi presbiteri, diaconi, consacrati o laici: il mostrare che si è spesa la vita nel servizio pastorale per amore di Dio, e che, per la stessa ragione, si è capaci di fare un effettivo passo indietro e di favorire chi subentra nel proprio ruolo.