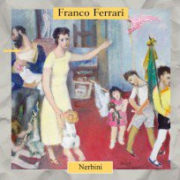Quando, dopo la fine della seconda guerra mondiale, cominciò a emergere la consapevolezza che una delle tragedie che si erano verificate in quel periodo era stato il massacro di quasi sei milioni di ebrei, si parlò di deportazione e di sterminio, successivamente di genocidio. Nel mondo ebraico orientale e tra gli abitanti del nascente Stato d’Israele, di hurban, poi di shoah. Oggi molti storici si riferiscono a quell’evento definendolo metaforicamente soluzione finale o Auschwitz; gli inglesi, gli americani e i mass media lo chiamano olocausto.
Che significato ha questo proliferare di nomi? Quale importanza può avere il nome con cui definiamo quest’immane tragedia? E perché essa deve avere una denominazione che la identifichi tra tutte quelle avvenute nei secoli?
Risponde a queste domande il libro I nomi dello sterminio. Definizioni di una tragedia della storica della lingua italiana Anna-Vera Sullam Calimani, pubblicato da Marietti 1820 e in libreria il 17 gennaio. Anticipiamo un brano dall’Introduzione.
Anna-Vera Sullam Calimani
Nella Bibbia è scritto: «Il Signore Dio, che aveva formato dalla terra tutte le bestie dei campi e tutti i volatili del cielo, li portò all’uomo per vedere come li avrebbe chiamati; qualunque nome l’uomo avesse dato agli esseri viventi sarebbe stato il loro nome». Fa parte cioè delle facoltà dell’uomo essere “padrone della lingua” e decidere attraverso quale significante indicare un oggetto o esprimere un concetto, anzi, è mediante l’imposizione del nome che egli si impadronisce della realtà. Dare un nome significa compiere un’estrema sintesi della nostra visione di un evento, apporvi un sigillo, dotarlo di un titolo che ne riassuma il significato. Da sempre «l’uomo ha dato il nome alle cose tracciando corrispondenze con una realtà superiore, un soprannaturale incombente, una magia sottostante, e instaurando delle nette opposizioni che classificano il mondo circostante nei poli positivo/negativo, ordine/disordine, paradiso/inferno» (G.L. Beccaria).
Affermare che un avvenimento come lo sterminio è “indescrivibile”, poiché non paragonabile a nessun’altra esperienza del passato, ma è tuttavia “nominabile”, cioè dotarlo di un nome, è un’aporia argomentativa poiché «il nome è la sostantivizzazione di una narrativa implicita», come sostiene Peter Haidu in un saggio contenuto in un volume dedicato ai “limiti della rappresentazione”.
Lo studioso ricorda come una certa teologia abbia fin dai tempi passati riconosciuto l’inadeguatezza della lingua a rappresentare il divino: la concezione dello sterminio quale mistero inspiegabile, sostiene Haidu, ricorda il concetto di divino che oltrepassa i limiti della comprensione umana, caratteristico delle società pregiudaiche. Non solo, ma questa religione del silenzio ci rammenta il famoso discorso di Himmler a Potsdam, nel quale egli impose ai generali nazisti il silenzio sullo sterminio che stavano compiendo, e ricordò la strategia nazista secondo la quale non bisognava lasciare traccia di ordini scritti (forse un modo per evitare i giudizi del mondo esterno sulla base di prove documentarie).
Haidu, tuttavia, è contrario ai nomi più comunemente usati per definire lo sterminio degli ebrei, in quanto essi hanno implicazioni per lui inaccettabili dal momento che propongono un’interpretazione precostituita della storia. Suggerisce perciò di adottare il termine “Evento”, il quale si sottrae al problema del “punto di vista” da assumere nella narrazione. “Evento”.
Egli si oppone, comunque, al culto del silenzio, all’insistenza sull’unicità dell’“Evento”, alla sua sacralizzazione, pratiche che finiscono per decontestualizzarlo, per renderlo incomprensibile e quindi addirittura irrilevante: se un avvenimento è infatti unico e del tutto avulso dalle vicende umane, quale rilevanza storica può avere?
La conclusione di Haidu è che ciò che conta, in ultima analisi, non è lo scrivere o meno la parola “evento” con l’iniziale maiuscola, rendendola cioè un nome proprio o un nome comune, o evitare o meno di adoperare i nomi più comunemente usati preferendo perifrasi che sono ulteriori forme di reticenza, ma accettare di rappresentarlo sia pure attraverso una lingua imperfetta e imprecisa.