Sandra Manzella è autrice del libro L’Oasi delle Rose. Il lebbrosario del Cairo, pubblicato per i tipi delle Edizioni Dehoniane di Bologna (Bologna 2020). Docente di lingua Inglese e scrittrice, è interessata al dialogo interreligioso e a temi storici e sociali del Vicino Oriente. Giordano Cavallari ha raccolto le sue risposte ad alcune domande sul volume recentemente uscito.
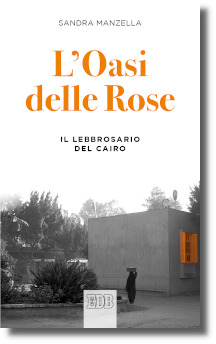
- Sandra, per iniziare a parlare del tuo libro vuoi partire dal titolo?
Il titolo è come un ossimoro, vuole esprimere l’unicità di un luogo in cui speranza e dignità sono legate al dolore di una malattia devastante, antica, ma che ancora sfigura volti e arti. L’oasi-lebbrosario è un luogo nel quale si può essere positivamente contagiati dalla speranza, incredibilmente viva in un luogo di sofferenza.
- Quali sono le motivazioni che ti hanno portata a scriverlo?
Come tutti, avevo letto e sentito parlare della lebbra, ma non mi ero mai confrontata direttamente con la realtà della malattia. Quando, inaspettatamente, mi è stata fatta la proposta, è venuto da sé accoglierla. Forse, nulla avviene per caso. Il primo incontro con le suore alla basilica cattolica del Cairo, nel quartiere elegante di Heliopolis, aveva uno scopo, in seguito confermato da ulteriori esperienze: arrivare alla scrittura di questo libro. Ricordo che, al termine della messa, bastò uno scambio di sorrisi con suor Attilia – la suora scomparsa a cui ho dedicato il libro – per stabilire un contatto, a cui seguì l’invito al lebbrosario per il giorno seguente. A quel “domani”, risposi subito “sì”. Avevo timore, ma più forte era l’interesse per l’esperienza.
Volevo vedere e capire. Nel mio immaginario ero, probabilmente, alla ricerca di una umanità ricoperta dalla sabbia dei millenni, ma ancora viva nel mondo contemporaneo. Non posso dire che si sia trattato di una motivazione esplicitamente religiosa: direi, piuttosto, umana. Da allora, era il 2004, il pensiero del lebbrosario di Abu Zaabal non mi ha mai abbandonata. Sono tornata ancora e ancora, con missionarie diverse.

- Puoi ricostruire la storia del lebbrosario e dire della sua attualità?
Il lebbrosario si trova nel piatto deserto alle spalle del Cairo, a circa quaranta chilometri, in una località chiamata Abu Zaabal. La struttura, ad amministrazione governativa, è oggi organizzata in tre plessi a distanza di pochi chilometri l’uno dall’altro: la sezione femminile, quella maschile e il cosiddetto “Centro”, che comprende ambulatori e sale operatorie non solo per i malati di lebbra, ma anche per tutti gli abitanti poveri dei villaggi della zona. Sono presenti pure un asilo gestito dalla Caritas egiziana e altri servizi educativi e di assistenza.
Le missionarie comboniane ed elisabettine svolgono un ruolo prezioso nell’ organizzazione, aiutate da tanti volontari europei e locali. Ho trovato un ambiente in cui, oltre alle cure fisiche, si promuove il senso del bello come, appunto, in un’oasi. Lo studioso norvegese Hansen fu il primo a isolare il bacillo, a fine Ottocento, affermando la non ereditarietà della malattia. Sin da tempi antichi, l’isolamento – ovvero la segregazione – era la sola medicina. In Egitto, il lebbrosario di Abu Zaabal fu fondato negli anni Trenta, ma sino agli anni Settanta non cambiò granché; una svolta accadde quando la missionaria libanese di cui parlo nel libro – suor Helen – si avvicinò coraggiosamente a quello che era allora un luogo di reclusione, più che di cura.
Da quel momento un contagio positivo di solidarietà cominciò a diffondersi. Le suore iniziarono ad andare volontariamente. Alle elisabettine si unirono le comboniane. È stato bello, per me, poter raccontare la storia di una comunità religiosa composta da due ordini: insieme ricevettero il permesso, dal governo egiziano, di potersi occupare di tutto il lebbrosario. Le suore si adoperarono anche per far conoscere, sensibilizzare e richiamare sostenitori locali e dall’Europa.
Le prime missionarie di allora, invecchiando, dovettero lasciare i loro incarichi. Sono andata ad Alessandria d’Egitto ad intervistarne alcune rimaste in vita, perché hanno più di novant’anni. Una giornata indimenticabile: mi hanno accolta con affetto, mostrandomi moltissime fotografie nella condivisione dei loro ricordi. La profondità della memoria mi ha fatto rivivere i primi anni del loro impegno: avevano pochissimi sussidi, dovevano lavare – ovviamente a mano – le bende già usate sulle ferite; non avevano guanti a sufficienza e, a volte, svenivano per l’odore della carne in putrefazione. Sono state delle vere e proprie eroine: forse non è il termine che loro gradirebbero, ma mi sembra adeguato.
- Nel corso del tempo di solito le cose cambiano: ad Abu Zaabal?
È straordinario che lo spirito di servizio sia rimasto quello degli inizi, nonostante le dimensioni accresciute e le condizioni ben diverse di Abu Zaabal. È lo stesso spirito che anima medici, infermieri e volontari che si occupano un po’ di tutto, comprese le rose che restano fiorite per un lungo periodo dell’anno e a cui suor Vincenza teneva tanto. Lei è convinta che un luogo bello, insieme a relazioni umane significative, sia una cura efficace ad accompagnamento delle medicine.

- Quali rapporti interreligiosi intercorrono nel lebbrosario del Cairo?
Questo aspetto è davvero interessante. Al centro dell’Oasi ci sono le persone, indipendentemente dal credo religioso. Ricordiamo, però, che l’Egitto è a maggioranza musulmana e possono sembrare strane queste suore: donne, quasi sempre straniere (qualcuna è egiziana) senza famiglia, presenti per scelta. Credo che il lebbrosario del Cairo sia una realtà straordinaria anche dal punto di vista interreligioso.
- Le suore missionarie annunciano Cristo?
Ad Abu Zaabal, la testimonianza cristiana è l’annuncio stesso, che vive nella presenza: non si tratta, perciò, di proselitismo. La maggioranza dei malati è musulmana, con una minima presenza di cristiani ortodossi. Il legame che si è creato tra tutti è semplicemente e profondamente umano, il che non vuol dire a-religioso: le ricorrenze vengono celebrate insieme, perché ogni occasione è buona per fare festa e per alleviare la monotonia.
- Gesù toccava e guariva. San Francesco ha baciato il lebbroso. Cosa hai visto nel lebbrosario?
Per curare le piaghe prodotte dalla lebbra si deve necessariamente toccare. Le ferite vanno pulite, cosparse di unguenti, bendate. Molto è cambiato dai primi tempi, quando i dispositivi di sicurezza erano meno che essenziali. Se diagnosticata per tempo, con una adeguata e costante profilassi, il corso della malattia si può arrestare: una volta guariti, i malati non sono più contagiosi. Le lesioni e le deformazioni, però, sono irreversibili. La lebbra aggredisce le estremità: “mangia” le dita delle mani, dei piedi, il naso, le palpebre… può colpire anche gli organi interni, compreso il cervello, fino alla pazzia. Il rischio di contagio sussiste; mi sono spesso interrogata sulle precauzioni delle suore: hanno sempre risposto che si sentivano protette dalla Provvidenza e dallo Spirito.
Per quanto apparisse strano anche a me, non hanno mai avuto paura ad avvicinarsi e a toccare i corpi dei malati. Certo, stavano attente, ma senza paura. Io mi sono sempre attenuta ai suggerimenti delle suore, ad esempio quello di tenere in mano degli oggetti per non invogliare gli abbracci. È davvero difficile – emotivamente – sottrarsi: come si fa ad evitare l’abbraccio di un bambino che ti viene incontro? Ho riscontrato che, tra i malati, le deformazioni non sono un problema: semplicemente, sono accettate come inevitabili: tra loro, il contatto fisico viene spontaneo. Probabilmente, viene in gioco la nozione culturale di prossemica – come in molti paesi mediorientali – molto diversa dalla nostra “occidentale”, ed è naturale la vicinanza fisica e la stretta condivisione di spazi ristretti.
- Una parte del tuo libro raccoglie storie di persone malate. Di che cosa sei andata alla ricerca?
Non è stato semplice strutturare il mio libro, ecco perché ho utilizzato tre forme letterarie diverse: il reportage, in cui racconto le storie di alcuni malati; il racconto, per spiegare gli inizi, e il saggio storico, per ciò che riguarda la scoperta della lebbra. Ho ascoltato, semplicemente, le vicende di varie persone, diverse per età e background, e mi sono lasciata trasportare, con commozione. In particolare, mi hanno colpito tre sorelline, arrivate una dopo l’altra al lebbrosario e provenienti da una famiglia molto povera di un villaggio nell’Alto Egitto.
Essendo la lebbra una malattia della povertà e della mancanza di igiene, al suo manifestarsi in famiglia sarebbe bastato poco per limitare il contagio e guarire. Eppure, non fu così. Ricordo bene una delle tre bambine conosciuta in passato: era allegra e vivace, si vantava della gonna a ruota del suo abitino; poi, nel 2018, l’ho ritrovata in carrozzina con i piedi amputati…

- Nei lebbrosi hai visto disperazione o qualche gioia di vivere?
I lebbrosi non si percepiscono come malati senza speranza: forse, alcuni comprendono più di altri il loro stato di isolamento rispetto alla società o soffrono il rifiuto e l’abbandono da parte delle famiglie di origine. Mi ha colpito, con sorpresa, la voglia di farsi fotografare: inizialmente ero imbarazzata, eppure mi veniva chiesto di scattare fotografie, senza dare importanza alla cartilagine del naso mancante o ai moncherini delle mani. Ricordo una signora che inizialmente non voleva, seppur spinta dalle amiche: scoprii invece che il motivo era l’abito.
Dopo aver indossato una splendida tunica ricamata, non smetteva di stare in posa. È straordinaria la naturalezza di queste persone, il loro ritrovarsi in una comunità umana dove si condivide una situazione terribile con accettazione e dignità, forse con un certo fatalismo, tipico nella cultura islamica. Non so se si possano definire persone felici. Sicuramente, per me il lebbrosario ha costituito la scoperta di un luogo di affermazione della vita, nonostante tutto.
- Ho letto che ti è stata posta la domanda se vale la pena di spendere la vita con i lebbrosi. La tua risposta, qual è?
Certamente, non c’è bisogno di andare in un lebbrosario per scoprire e confrontarsi con la fragilità che accomuna gli esseri umani. Dedicarsi agli ultimi non è perdere la propria vita. Vengono facilmente in aiuto le citazioni evangeliche. Ma a me sta a cuore recuperare innanzi tutto la domanda di Caino in Genesi 4,9: «custode di mio fratello, io?». Penso che ciascuno di noi avverta il senso di questa domanda e che debba dare, in ogni momento, una sua risposta, semplicemente per essere umani.
- Vieni dal lebbrosario del Cairo in Egitto e ora sei in Italia, a casa, costretta come tutti noi dal Coronavirus. Vedi qualche correlazione tra le due esperienze?
Quel che posso capire dalle due esperienze è che, mentre nel 21° secolo possiamo attraversare l’universo, restiamo esseri umani radicalmente deboli. Ora siamo segregati in casa ma, per quanto sia pesante, possiamo usare la tecnologia per rimanere in contatto con i nostri affetti; al contrario, i malati di lebbra erano isolati e rifiutati. Riflettendo, la nostra è un’occasione in più per interrogarci su cosa conti davvero nella vita.






Molto interessante.
I miei migliori complimenti! E’un’esperienza che ti ha coinvolto emotivamente…