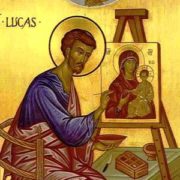Al centro della liturgia odierna c’è quello che comunemente si chiama il “comandamento dell’amore”.
Confesso che, quando mi trovo a dire qualche parola su questo brano evangelico, mi sento vagamente imbarazzato. Soprattutto quando si discorre di “norme” che riguardano la vita di fede, da parte di persone che hanno abbandonato la pratica religiosa perché in dissenso con la “struttura Chiesa”, giustificando la loro scelta dicendo che tutto è relativo, quello che conta è “amare”, dove è implicito il riferimento alla parola che è il cuore del vangelo letto oggi.
Temo che tale risposta celi un presupposto di “vaghezza” che non porta molto lontano, quasi un alibi per non affrontare seriamente il problema, che, alla fine, è quello dei “valori”, chiari e indubitabili, e delle “pratiche” che li incarnano. Il termine “amore”, come “libertà” e altri consimili, ha uno spazio di significato che può voler dire tutto e il contrario di tutto.
Peraltro, proprio questa esigenza ha portato alla creazione di norme concrete chiamate “comandamenti”, che servissero almeno a dare delle indicazioni più precise su come dare forma all’amore, che è e resta l’anima della Legge.
Quelle norme Gesù ha detto di non volerle abolire, neanche le più piccole (Mt 5,17-19), ma ha fatto subito seguire una serie di dichiarazioni dove ha dato chiaramente a intendere che c’era modo e modo di leggerle. E la sua spiegazione, a mezzo di esempi, insegna che il loro “orizzonte” è molto più vasto di quello che appare a tutta prima. Se si dimentica questo, si cade facilmente nel “legalismo”, governato dalla legge del minimo sforzo che basta a mettersi in pace con Dio.
L’amore come “orizzonte”
È importante, a questo proposito, ricordare che l’amore, più che una legge o un comandamento, è un orizzonte, che segna un orientamento, una direttrice di marcia, e l’orizzonte, come si sa, non ha confini. Come ha detto Thomas Traherne (1637-1674), uno degli autori più significativi di quella grande corrente di scrittori e poeti che formò nel ’600 la gloriosa spiritualità della Chiesa d’Inghilterra nota come Pietas anglicana, ebbe a dire in uno splendido aforisma: «L’amore non è mai troppo, può solo essere sbagliato». Ecco cosa significa amore come orizzonte.
Trovo utile, a proposito, ricordare una grande svolta nella prassi penitenziale della Chiesa, quella che partì da un decreto del Concilio Lateranense IV (1215) che stabiliva il precetto per i fedeli di confessarsi una volta all’anno e di comunicarsi almeno a Pasqua.
Per la felice coincidenza dello sviluppo in quegli anni dei nuovi ordini mendicanti, in particolare francescani e domenicani, si andò producendo un’abbondantissima letteratura che intendeva insegnare ai fedeli come fare l’esame di coscienza e ai confessori come trattare i penitenti.
Era stata in voga, fino ad allora, la cosiddetta «penitenza tariffata», avviata a partire dall’uso della confessione frequente importato dal monachesimo celtico, che consisteva nell’imporre qualche opera buona a prescindere dal tipo di peccati commessi. Tale prassi, forse perché più facile e più spiccia, ha resistito ed è arrivata fino a noi, e forse dura ancora da qualche parte, dove la penitenza era standardizzata nelle tre Ave Maria o nel Pater, Ave, Gloria suggeriti prima dell’assoluzione.
Quali erano la novità portate dai frati del XIII secolo? Ne posso parlare con cognizione di causa per aver studiato e fatto studiare molti manuali penitenziali dei secoli XIII-XIV, una letteratura sterminata che sarebbe utilissimo conoscere.
Le principali novità sono tre: l’esame di coscienza non era condotto sui comandamenti, che apparivano spesso in brevi appendici, ma sui sette vizi capitali; la penitenza era di riflesso legata alla letteratura dei “rimedi” che descrivevano le virtù opposte ai vizi; infine, al confessore si raccomandava saggezza ed equilibrio nel proporre il modo di riparare il peccato commesso.
Che differenza fa? Mentre i comandamenti che, in gran parte, sono “azioni” da fare o da evitare, i “vizi” e le “virtù” sono il fondo emotivo che sta dietro le azioni, una zona più difficile da “cosificare”, conteggiare e controllare (onde il rischio di legalismo), un territorio più ambiguo e nebuloso, che esige un’abitudine coltivata al discernimento.
Peraltro, anche nei comandamenti ce ne sono alcuni che lasciano largo spazio all’esplorazione e alla realizzazione, tipo «onora il padre e la madre», o ancor più i due finali che chiedono di fare attenzione alla cura del “desiderio”!
Comunque, già il Concilio parecchi anni fa suggeriva, tra l’altro, di condurre l’esame di coscienza non su una schedina prefabbricata sulla lista dei comandamenti, ma su un testo della Scrittura. Il mio favorito è Romani 12, usato anche solo in parte.
Mi rendo conto che tale “digressione” può sembrare eccessiva, ma mi importava che si capisse cosa intendo quando definisco il duplice precetto dell’amore un “orizzonte di senso” che deve orientare le nostre scelte.
Tanto per cominciare, la prima lettura (Es 22,20-26) offre non tanto norme generiche ma una serie di comportamenti pratici dietro i quali è facile vedere atteggiamenti di attenzione e di benevolenza che devono essere coltivati nel fondo del cuore.
Li elenco: l’attenzione al «forestiero», mettendosi nei suoi panni, magari facendo riferimento ad esperienze analoghe; il rispetto per chi vive una condizione di fragilità, come «l’orfano e la vedova», categorie tipo che, insieme a quella dello «straniero», percorrono tutta la Bibbia, in particolare i Salmi; l’aiuto all’indigente che chiede un prestito in denaro, che non va trattato con mentalità da usuraio, o ancora più se è costretto a dare in pegno un mantello, questo gli deve essere restituito «per la notte», perché non ha altro con cui coprirsi. Non sono “precetti” particolari, ma sono esempi di come l’orizzonte dell’amore deve gettare la sua luce sul nostro quotidiano, da misurare sui bisogni degli altri.
Se noi adoriamo un Signore che è descritto nel Salmo 17 come «forza, roccia, fortezza, liberatore, rupe, rifugio, scudo, potente salvezza, baluardo», che sono le forme in cui egli manifesta il suo “amore” nei nostri riguardi, il nostro amore non può percorrere strade diverse da questa.
L’esempio della comunità cristiana di Tessalonica (Ts 1,5c-10) che, «avendo accolto la Parola in mezzo a grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo», è diventata un «modello per tutti i credenti della Macedonia e dell’Acaia», reca un messaggio in linea con quanto stiamo dicendo: l’amore che ispira i discepoli di Gesù diventa una forza contagiosa, e una forma di amore del prossimo, se non la prima, può essere proprio il bisogno di dare buon esempio e, all’opposto, la necessità di non creare difficoltà alla fede di chi è debole a causa di cattivi comportamenti dei cristiani.
Il grande comandamento
«Qual è il grande comandamento?» chiede un fariseo, dottore della Legge, per mettere alla prova Gesù (Mt 22,34-40). La domanda è nella serie dei tentativi, uditi nelle ultime domeniche, di cogliere Gesù in fallo.
Il problema esisteva, e prevedibilmente non era di facile soluzione: i rabbini contavano fino a 613 comandamenti nella Torà, 248 positivi (tu devi) e 365 negativi (non devi)! Pane per i denti dei fedeli zelanti, che forse avrebbero anche potuto utilizzare meglio il loro tempo piuttosto di faticare ad enumerarli.
La risposta di Gesù è troppo nota: «“Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”». Radicale semplificazione, che non è una riduzione ma, al contrario, una dilatazione senza confini.
Alla fine restano due, anzi, uno solo con due facce interdipendenti. L’amore, nella sua forma duplice, è il «grande e primo comandamento» perché costituisce ciò che li deve irrorare tutti con la sua forza, così che ogni comando, o norma, o precetto deve avere come primo requisito quello di essere manifestazione dell’amore in tutti i gradi che esso può rivestire, dall’offrire un bicchiere di acqua fresca al dare la vita per gli altri. Perché Gesù ha pure detto: «Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».
Non bastava la Legge? No, perché le figure e i libri dei Profeti mostrano a più riprese come l’osservanza puntuale della Legge, che riduce i comandamenti a un “confine” entro il quale ripararsi, che può essere la regola del minimo sforzo o varie forme di alibi, rischia di strozzarne il senso fino a contraddirlo.
Tra i tanti ricordo solo il caso di Geremia 7,9-11, che denuncia come il tempio, luogo del culto al Signore, si è trasformato in una spelonca dove i ladri si rifugiano dopo i loro furti credendosi al sicuro, parole che Gesù, “il” Profeta per antonomasia, ha già utilizzato nella cacciata dei mercanti dal tempio (Mt 21,12).
Per non parlare del fariseo della parabola, che va al tempio, dove, stando eretto, ringrazia Dio per l’elenco puntiglioso delle opere compiute, persino con qualche aggiunta, in rispetto della Legge (Lc 18,9-14), concluso con uno sguardo sprezzante al pubblicano, che invece confessa il suo peccato. Ma è il fariseo che torna a casa con un peccato in più, perché ha dimenticato il «grande comandamento», quell’amore che gli doveva suggerire di render grazie a Dio e di avere misericordia per il fratello peccatore.
È poco concludere che il suo amore per Dio, se anche poteva sembrare persino “troppo”, era però certamente “sbagliato”?