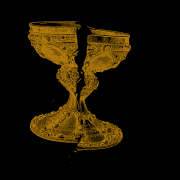Questa mia riflessione è guidata dall’attesa di una umanità riconciliata nella ricerca di ciò che unisce, di una universalità senza gerarchie e senza guerre, senza oppressori e senza oppressi.
Infatti, non riesco ad arrendermi cinicamente al realismo dialettico hegeliano in cui la storia c’è solo perché c’è la guerra. Preferisco seguire la descrizione di un’alterità irriducibile anche al discorso – il volto e la traccia dell’Altro – proposta da Levinas, il maestro dell’etica come ontologia, che attacca frontalmente il paradigma aristotelico dell’identità e l’orrore occidentale per l’alterità.
Ulisse rappresenta esistenzialmente il principio di identità e non contraddizione: nel suo viaggio che abbraccia il mondo, entra in confronto con ogni tipo di seduzione umana, magica, divina, ma riesce a ritornare ad Itaca, incontaminato, per nulla cambiato o scalfito nella sua identità. Ossessivamente, compulsivamente uguale a sé stesso.
E così viviamo in un mondo assolutamente incapace di contemplazione, di ascolto silenzioso e disarmato dell’altro, nella vita domestica, nelle società e nei rapporti tra stati nazionali, ultima e letale affermazione paranoica dell’identità. Una umanità che raramente mostra che si può lottare senza odiare e senza uccidere.
Mi accompagna anche la lettura di Renè Girard, che vede la mimesi speculare tra umani, nella disputa che contende un oggetto, sconfitta dall’attitudine sensata dei cani, che, istintivamente si sottraggono al conflitto mimetico, per evitare di uccidersi. Uno dei due contendenti mostra all’altro le spalle, riconoscendo la propria debolezza e così la guerra finisce. Istintività che troviamo diffusa nel regno animale, ma non tra gli umani, nonostante religioni e umanismi.
Intersezioni
Mi sento interpellato, quindi, dagli identitarismi, etnicismi e tribalismi attualmente fortemente presenti nelle lotte di emancipazione di innumerevoli movimenti politici, normalmente considerati progressisti e antiautoritari.
Percepisco, però, che, salva l’assoluta e indiscutibile libertà e legittimità di affermarsi come popolo, etnia e genere, esiste il pericolo di identità, che, costruendo la molteplicità, possa, in nome della propria differenza, annullare qualunque determinazione sociale comune, inclusa l’ormai limitatissima categoria unitaria di classe e – decisione che reputo ben più pericolosa – l’inserzione nel processo di costruzione dell’universalità.
Certamente non possiamo ignorare l’apporto correttivo proposto dalla recente teoria intersezionale – importata dagli USA e reinterpretata da femministe nere, in Brasile; intersezionalità che contribuisce a smantellare identità assolutizzate, complessificando e intersecando i diversi ambiti che costituiscono l’oggetto della disuguaglianza, della dominazione, dell’oppressione e della discriminazione.
Al razzismo, sessismo, classismo, patriarcalismo, maschilismo, omofobia e transfobia, colonialismo, xenofobia, si aggiungono altre discriminazioni in base alla casta, al luogo di nascita, alla collocazione geografica, alla nazionalità, alla religione, all’educazione, alla cultura, all’abilità, all’età, all’obesità, al linguaggio: linee e vettori che si intrecciano, si incrociano – e a volte si annodano – nell’unico soggetto.
Servendoci dell’analisi intersezionale, potremmo scoprire che una persona, variamente discriminata, per esempio, perché nera, donna e omo-affettiva, termina identificandosi con tre diversi movimenti politici identitari. Così la frammentazione non accade solamente in ambito sociopolitico, ma attinge lo stesso soggetto articolato in tre diverse identità.
E non è prudente dimenticare un’ulteriore frattura che questo tipo di catalogazione permette quando, eventualmente, scopre nello stesso soggetto la coesistenza di identificazioni che lo rivelano simultaneamente vittima per alcuni aspetti e oppressore per altri. Come, per esempio, il caso di donne bianche, discriminate in quanto donne, ma privilegiate perché bianche.
Per una lotta comune
Inoltre, è necessario ricordare che questa multidimensionalità rizomatica sembra aver espulso la inderogabile urgenza di fissare, con discernimenti politici contestuali, un’agenda minima di priorità, a meno che il permanere “in una notte in cui tutti i gatti sono grigi” sia la decisione definitiva.
E, a volte, pare davvero che questi collettivi si sottraggano alla sfida della costruzione di programmi comuni di lotta. Infatti, come è possibile costruire un’alternativa politica a partire da una realtà sociale così atomizzata e frammentata? E non considero una strategia sensata l’appello che alcuni movimenti rivolgono allo stato perché provveda a politiche pubbliche adeguate a questa molteplicità identitaria.
Né mi convincono insorgenze che mirano semplicemente a garantire legittimità sociale alle differenze, accettando supinamente il potere e il controllo del sistema egemonico. Si tratta, senza dubbio, di equivoci, per due ragioni: perché si rinuncia a un minimo protagonismo politico e perché lo stato e il capitale sono da sempre costitutivamente nemici delle minoranze stigmatizzate ed escluse.
Cannibalizzare l’Occidente pervasivo
Recentemente questo dibattito si è arricchito con il contributo del paradigma del lugar de fala, il luogo del discorso. È soprattutto la filosofa Djamila Ribeiro che cannibalizza questa figura, importandola dalla Francia di Foucault. Il discorso è sempre luogo di potere e appropriarsi della parola significa disputare potere in termini etici, critici e politici.
Positivamente, si tratta del riscatto di esistenze oppresse, silenziate e occultate, che, a partire dal luogo sociale occupato, finalmente tessono discorsi autonomi, liberi dalla tutela bianca, patriarcale, eterosessuale ed eurocentrica. Insomma, non si affronta la piaga del razzismo in termini astratti, ma a partire dal vissuto dei collettivi che lottano quotidianamente contro la discriminazione e la violenza a partire dalla propria pelle.
Questa affermazione sempre si rese necessaria nei conflitti della nostra storia e sempre sarà indispensabile riconoscere e costruire identità definite per l’azione politica dei discriminati e degli oppressi.
Pensiamo, per esempio, al tempo in cui identità e coscienza di classe costituivano un’alternativa forte al sistema capitalista. Se, però, al contrario, ci accontentiamo con la mera affermazione dell’identità, escludiamo categoricamente la possibilità di contribuire alla costruzione di un processo politico collettivo.
Senza dubbio è necessaria, in questa lotta, anche la battaglia epistemologica con il discorso egemonico eurocentrato.
Succede, però, che è inevitabile servirsi dei paradigmi del pensiero occidentale, nonostante questo modello si sia sempre posto come superiore, imponendo la sua identità come norma universale e sempre a costo dell´invisibilizzazione e interdizione di altre forme di sapere e di discorrere.
Dipende dalla nostra capacità antropofagica non solo risignificare umanismi e scientificismi bianchi, costitutivamente aporofobi, patriarcali e razzisti, ma anche discernere e assumere valori irrinunciabili elaborati dal nemico.
Lo fece, mirabilmente, Enrique Dussel, quando cannibalizzò tutta la filosofia occidentale, a partire dall’identità dei colonizzati dell’Abya Ayala, inventati, scoperti, uccisi, dominati materialmente e spiritualmente, occultati e silenziati.
È poi possibile che possano verificarsi ulteriori equivoci lungo il cammino di esercizio del potere che nasce dal luogo del discorso: a confidare nella verità del clamore sofferto delle vittime di discriminazione non dovremmo però accettare la possibilità di negare la parola a interlocutori critici, che non sono necessariamente razzisti, sessisti, classisti, maschilisti, patriarcali o omofobici.
Se così fosse adotteremmo il triste e letale argumentum ad hominem, che sancisce la verità o l’errore di una posizione, a partire dall’identità del denunciante. Credo che sia sempre imperdonabile rinunciare alla dimensione critica e cessare di fare domande alla realtà e all’esperienza, quando bisogna invece costruire argomenti critici in un ambiente etico. Questa attitudine garantisce infatti processi pedagogici e di formazione politica che qualificano positivamente l’organizzazione, l’articolazione e la mobilitazione degli oppressi.
Minoranze
Accadde anche a chi scrive, negli anni ‘80, quando in dibattiti politici sorti all’interno di processi di lotte contadine per la conquista della terra, gli argomenti critici da me proposti erano ignorati e si sottolineava esplicitamente che non potevo capire, perché ero straniero. E non avrei dovuto intervenire nel dibattito perché non ero “un figlio della terra”.
Ovviamente anche oggi vedo con chiarezza e senza risentimento che questo mio essere vittima di xenofobia coesisteva con i privilegi di una pelle bianca ed europea. O come quando con le compagne femministe degli anni 60, dovevo chiedere scusa per essere nato maschio: una maniera radicale, ma semplificatrice, di lottare contro il sistema del potere maschile e patriarcale. Insomma, lottare per fraternità e uguaglianza in questo labirinto di difficile percorso non può essere fatto a costo di riduzioni, semplificazioni e antiintellettualismi.
La mera affermazione dell’identità si fa sempre a costo di inimicizie inutili e dialoghi negati, rende complicate anche le relazioni interne dei movimenti e, a lungo andare, si rivela povera e inconcludente nei processi di insorgenza.
Sto riflettendo intorno a identitarismi di minoranze, normalmente oggetto di discriminazioni e razzismi, senza, però, ignorare che il suprematismo bianco, di matrice nazifascista, continua egemonico ed è la colpa più grave dell’occidente. Insomma, l’identitarismo ha origini nel pensiero e nelle pratiche belliciste, coloniali e genocide dell’Europa ed è possibile, purtroppo, che questa radice possa influenzare negativamente anche gli attuali movimenti identitari.
Quindi, non dimentichiamo che l’insistenza sulla differenza è patrimonio ideologico della destra. Deve comunque restare saldo il discernimento delle rivendicazioni identitarie, per poter squalificare le pretese, per esempio, della Lega Padana o dei separatisti del Rio Grande del Sud. E la cartina di tornasole per discernere è la persistenza dell’oppressione coloniale, che separa identitaristi autoritari e neofascisti da popoli e gruppi umani secolarmente discriminati e perseguitati.
Un esempio di un drammatico errore storico fu il sionismo, strategia per risolvere il ciclo secolare e interminabile delle persecuzioni cristiane, processo identitario del popolo eletto portato alle ultime conseguenze, in cui l’identità religiosa si sposa con la costruzione e la difesa di uno stato nazionale, destinato, però, inevitabilmente a sottomettersi alle logiche e alla prassi di guerra e oppressione statali.
Non possiamo tuttavia dimenticare gli orrori dell’antisemitismo cattolico, che ha insanguinato secoli e secoli della storia europea, ben prima della shoah, e il permanere dell’odio antisemita nelle società attuali.
Le Chiese e la politica
Così è bene soffermarsi a pensare anche all’esistenza dello Stato del Vaticano, che, nonostante non sia indubbiamente uno stato nazionale in termini militari, non può però essere semplicemente considerato come una parodia dello stato, nella misura in cui ne ripete fedelmente gli statuti giuridici e burocratici, costituendo un modo di tutelare l’identità cattolica carico di equivoci e contraddizioni, soprattutto per l’inevitabile e irriflessa appartenenza al campo politico occidentale.
E inoltre pensiamo alle gravi prese di posizione del Patriarcato di Mosca, con l’appoggio di Kirill e dell’episcopato ortodosso russo alla guerra di Putin, in difesa dell’identarismo panrusso contro il pervertito occidente. Posizione che, specularmente, è imitata dal patriarca di Kiev Epifanio. Ambedue condividendo la tesi “teologica” che la guerra in corso è il conflitto tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre.
Profezia e universalità
Ciò che mi convince e mi conduce sono il sogno e la profezia della Parola. Babele, in un primo momento, che rivela l’opposizione divina ad un mondo di unica lingua e di un’unica maniera di vivere e l’iniziativa di disperdere nuovamente l’umanità in una sinfonia di lingue, culture diverse e irrinunciabili differenze.
E, poi, la Pentecoste di Gerusalemme, quando Pietro annunciava la Buona Notizia e tutti i popoli del mondo allora conosciuto la capivano e l’accoglievano nella loro lingua. Purtroppo, profezie dimenticate dalle Chiese, sia nella cristianizzazione dell’Europa che nelle imprese coloniali.
Infatti, nelle Americhe, la croce arrivò con la spada e Gesù in compagnia dei sovrani iberici o del suprematismo protestante. E in Africa, piú tardi, si ripeté questa tragica confusione tra il militarismo degli stati nazionali e le confessioni cristiane. Insomma, un universalismo imposto con il potere degli stati e delle armi si rivela una drammatica parodia e un radicale tradimento dell’universalità.
Come costruire universalità amorosa, disarmata, pacifica? Come sconfiggere definitivamente l’odio e costruire una sinfonia universale, armonia di irriducibili ma dialoganti differenze?