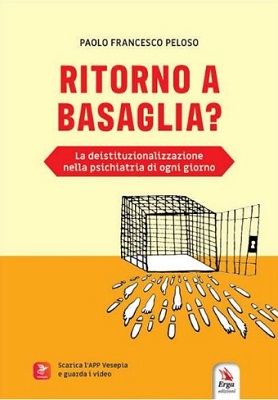
Nel suo recentissimo Ritorno a Basaglia? La deistituzionalizzazione nella psichiatria di ogni giorno, il dott. Paolo Peloso, in modo intenso e appassionato, ripercorre una stagione di motivazioni, culture, ispirazioni, ricerche, studi, scelte politiche, gesti ed esperienze di vita, cambiamenti radicali accaduti nell’assistenza psichiatrica partendo dalla pratica della stessa e quindi dalle relazioni con i pazienti, tutti, uno ad uno, per la pienezza dei diritti di cittadinanza di ciascuno.
Esperienze e associazioni
Paolo in questo libro continua a incalzare, ad interrogare, citare, mettere a confronto i testimoni-protagonisti, in particolare delle esperienze di Gorizia, Parma, Trieste, Genova: esperienze pilota condotte nella seconda metà del secolo scorso e che portarono a definire, dopo la chiusura dei manicomi, gli assetti di un possibile lavoro per la salute mentale.
Molte di tali esperienze, diffuse, appunto, nel territorio nazionale, comportarono spesso vere e proprie scelte di vita degli operatori, grandi quantità di tempo impiegato, profusione di intelligenze e passione per alimentare una vera e propria rivoluzione nelle pratiche professionali, insieme alla continua verifica di quanto si andava producendo: parlo non solo di forti “vocazioni”, ma anche di disponibilità al sacrificio e ad una disciplina individuale e di gruppo quasi monastica. Tutto questo è stato rappresentato benissimo, con grande eloquenza ed efficacia, da Paolo Peloso.
Se “la rivoluzione che ha chiuso i manicomi” ha avuto successo è perché, a partire proprio da Franco Basaglia, non ha mai snobbato né la politica né gli psichiatri italiani e la loro organizzazione scientifica, la Società Italiana di Psichiatria (SIP); anzi, ha perseguito una continua, serrata interlocuzione col Parlamento, i partiti, i sindacati, le amministrazioni locali, le associazioni professionali, i mass media[1].
Questo impegno ha consentito il primo grandissimo successo storico dell’uscita dell’assistenza psichiatrica pubblica dalla separatezza gestionale rispetto al resto della Sanità – ricordo che i manicomi erano affidati al governo delle amministrazioni provinciali – e della sua piena integrazione nel Servizio sanitario nazionale (Ssn), dentro la più larga mobilitazione per il diritto alla salute che comprendeva anche quella mentale. Fu questa scelta strategica a portare alla ricezione della legge 180 nel maggio 1978 nella legge 833 istitutiva, nel dicembre dello stesso anno.
Aggiungo che senza il lavoro dell’AMOPI – l’associazione dei medici che lavoravano in manicomio -, quindi senza la legge stralcio 431 del 1968 che introdusse il ricovero volontario e restituì i diritti civili a migliaia di persone internate e senza la correlata diffusione delle pratiche antimanicomiali e la serrata interlocuzione con i critici e gli oppositori, la legge non sarebbe mai arrivata in Parlamento e Bruno Orsini non ne avrebbe mai potuto esserne il relatore.
Una controriforma
Il titolo Ritorno a Basaglia? si chiude con un punto di domanda, interrogandoci sui problemi che si incontrano, ancora oggi, nel lavoro di attuazione della “deistituzionalizzazione nella psichiatria”. A mio avviso, i blocchi o gli ostacoli vanno fatti risalire, in gran parte, sia alle indubbie difficoltà del progetto, sia al successo di alcune operazioni “strutturali” di contro-riforma e di re-istituzionalizzazione che hanno de-potenziato, deviato, svigorito l’impianto della 180 e della 833. Al riguardo, esplicito le seguenti considerazioni.
La legge ebbe buona e diffusa sperimentazione nella varietà delle realtà provinciali, ma non nelle grandi città. Basaglia, Pirella, Slavich ne erano consapevoli e per questo scelsero di misurarsi con la dimensione e la complessità dei problemi e dei poteri politici, accademici e professionali proprio nelle grandi città: a Roma, Torino, Genova, mentre Sergio Piro rimase nella sua Napoli. L’esperienza di Basaglia a Roma fu durissima[2].
Aspro terreno di confronto fu quello della formazione: cosa bisognava insegnare, imparare, leggere, sapere per lavorare con efficacia nei nuovi Dipartimenti di salute mentale (Dsm) per perseguire i nuovi obiettivi? Come bisognava diventare come persone per poter essere efficaci nel lavoro di cura? Da ciò l’esplosione dell’offerta di formazione da parte di innumerevoli scuole di psicoterapia e psicoanalisi: cito Pier Francesco Galli e la Scuola di via Ariosto a Milano, il lavoro di Tullio Seppilli antropologo a Perugia, il lavoro di documentazione e ricerca intorno al progetto “Prevenzione malattie mentali” guidato da Raffaello Misiti e Cristiano Castelfranchi presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).
Il cambio radicale delle finalità e delle modalità del lavoro che, da assistenza psichiatrica, diventava di salute mentale richiedeva la rivisitazione e la ridefinizione dei saperi da trasmettere, non solo a medici psichiatri, ma anche a psicologi, infermieri, assistenti sociali, educatori, operatori tecnici dell’assistenza, ausiliari socioassistenziali.
Per questo chi operava sul campo sentì l’urgenza di organizzare i nuovi apprendimenti localmente, presso i luoghi di cura o in centri quasi sempre al di fuori dei circuiti universitari. L’esperienza di Trieste si costituì perciò come luogo privilegiato di apprendimento “sul campo” di ciò che era indispensabile conoscere per operare.
Per anni, quindi, i corsi di laurea di Psicologia e Medicina e le Scuole di specializzazione dell’Università italiana hanno continuato a rilasciare lauree e diplomi, rimanendo ai margini di una enorme opportunità di aggiornamento e di formazione permanente dentro i nuovi luoghi di lavoro e le nuove istituzioni della riforma sanitaria e psichiatrica.
Questo fino a che l’Università riprese la titolarità esclusiva della formazione con il DPR 10 marzo 1982, n. 162 Riordinamento delle Scuole dirette a fini speciali e dei corsi di perfezionamento, con la legge 19 novembre 1990, n. 41 Riforma degli ordinamenti didattici universitari, la legge 15 marzo 1997, n. 12 Ordinamento degli studi dei corsi universitari– artt. da 95 a118: questo per dire che il movimento che accompagnò la chiusura dei manicomi e l’istituzione del Servizio sanitario nazionale, avendo come maestri persone come Basaglia, Maccacaro, Giovanni Berlinguer, non riuscì a conquistare le Università, che anzi rafforzarono il monopolio della loro formazione su infermieri professionali, assistenti sociali, educatori.

Franco Basaglia
Malattia mentale e università
Gli psichiatri accademici, che avevano conquistato la separazione delle proprie Scuole di specializzazione da quelle di Clinica delle malattie nervose e mentali, continuarono (e continuano) in grandissima parte ad ispirarsi all’approccio clinico della malattia mentale e pretesero posti letto per la formazione, separati da quelli dell’assistenza psichiatrica riformata.
Fra le eccezioni ricordo Dario De Martis a Pavia e Michele Tansella a Verona. Gli ambienti psichiatrici universitari, in particolare quello della Clinica di Pisa, continuarono ad alimentare una campagna pressante contro il movimento riformatore accusato di essere ideologico, non-scientifico, velleitario, arrivando ad ispirare orientamenti politici in partiti di governo, dal PSI al PLI al PRI.
Le Università, insieme all’esclusiva della formazione, ottennero così l’adozione del “numero chiuso” nei corsi, una scelta forse giusta in funzione dell’ottimizzazione della didattica, ma disattenta alle esigenze del Ssn, così come oggi stiamo drammaticamente verificando.
La responsabilità dell’attuale disastro al riguardo è attribuibile al Servizio sanitario nazionale e soprattutto alle Regioni che da molti anni hanno abbandonato il metodo della programmazione, che comporta una precisa conoscenza delle esigenze dei servizi, per saper provvedere per tempo mettendo a disposizione le risorse di personale necessarie. Certamente l’Università non si è proprio curata del problema.
Allontanamento dal territorio
Altro intervento strutturale nel “cuore” del Servizio sanitario nazionale fu la decisione politica di estromettere i Comuni dal governo del Ssn per affidarlo alle Regioni. Tale scelta è risultata particolarmente infausta per il lavoro dei Dsm che pone al centro della cura le persone con le loro relazioni sociali e affettive, nella dimensione locale e quindi con una stretta integrazione fra la dimensione sanitaria e quella sociale, ossia appunto l’ambito comunale nel quale l’autorità di riferimento è il sindaco.
Così i sindaci hanno cessato di contare nella gestione del Servizio sanitario che si svolge nel territorio da loro stessi amministrato, a parte, comunque, il dover firmare i trattamenti sanitari obbligatori (t.s.o.) in quanto – in teoria – massima autorità sanitaria locale. Mentre le scelte di governo del Ssn sono state appaltate ad Aziende sanitarie di dimensioni sempre più grandi che hanno favorito e sostenuto, nella maggior parte dei casi, quasi esclusivamente, la sanità ospedaliera a danno del lavoro capillare di promozione della salute nei territori e nelle comunità locali, come la pandemia da Covid – e la sua gestione – hanno drammaticamente disvelato, impoverendo e ostacolando lo svolgersi delle relazioni vitali per la salute mentale e integrale delle persone.
Perciò avverto l’urgenza di una riforma legislativa che restituisca la partecipazione del governo del Servizio sanitario nazionale al livello dei Comuni, anche sotto forma di Aziende di servizi comunali, contrastando decisamente il regionalismo differenziato.
Tornare a Basaglia?
Concludo con una mia risposta all’interrogativo Ritorno a Basaglia?. Il Servizio sanitario nazionale – ossia di fatto le Regioni – dal 2008 è divenuto titolare del lavoro per la salute nelle carceri, ad oggi certamente il luogo di maggiore sofferenza – anche mentale -, oltre che di massima penuria di attenzioni e di risorse.
Osservo che il carcere, ma anche le comunità locali, hanno da tempo in comune il compito di gestire la sofferenza mentale delle persone immigrate e migranti che non si riconoscono nelle declinazioni “scientifiche”-“atlantiche”-“bianche”, e nelle idee e nei trattamenti attorno al concetto di salute e di malattia.
Questa è una sfida grande per le culture che hanno alimentato il movimento antiistituzionale psichiatrico italiano e innervato la riforma. Ritengo che sia giunto il momento di integrare il paradigma bio-psico-sociale di riferimento per il lavoro nei Dsm con quelli dell’antropologia medica e culturale.
La rivisitazione del Servizio sanitario nazionale nelle direzioni indicate consentirebbe – è mia opinione – di procedere ad una co-costruzione dei servizi a partire da chi li abita in modo diretto: la comunità di operatori, la comunità territoriale, la comunità di utenti. Ciò aiuterebbe a rifondare i servizi su base antropologica, riconsiderando i luoghi della cura in cui diffondere i sintomi della salute, al di là dell’aggiustamento farmacologico dei sintomi della malattia, in una continua ricombinazione tra ciò che è locale e ciò che è globale.
Solo le comunità territoriali e quindi i luoghi deputati alla cura territoriale e alla attuazione del processo terapeutico – fisico, psichico, spirituale – sono sensibili ai valori ed ai significati culturali complessi della “persona malata” e possono allargare l’azione anche attorno alle appartenenze religiose dei migranti.
[1] Per parlare dello stato delle relazioni fra movimento per la salute mentale e SIP nel nostro tempo, ricordo che l’ultima Conferenza nazionale per la salute mentale è stata disertata per protesta dalla SIP il cui presidente Masssimo di Giannantonio ha dichiarato: “Non condivido il metodo autoreferenziale di scelta degli argomenti che sono stati “trapiantati” dal Tavolo tecnico nel programma senza confronto né discussione”.
[2] A Roma, le parole d’ordine anti-istituzionali furono usate da amministratori regionali per ridurre fin oltre al minimo la dotazione di posti letto in SPDC in una città in cui transitano, vivono, lavorano, ogni giorno, centinaia di migliaia di persone, pellegrini compresi. Questo per favorire e continuare ad alimentare l’occupazione di posti letto della enorme rete di cliniche private, i cui proprietari portano voti e consensi.





