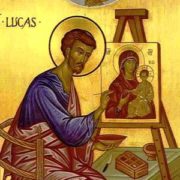Elia, servitore di YHWH
Le storie del profeta Elia di 1Re 17–19 sono organizzate secondo uno schema geografico, che abbraccia oltre al regno di Israele, la Transgiordania a est (17,2-7), la Fenicia a nord (17,8-16), il Negev a sud (19,1-18), «il mare» (18,43-44) a ovest.
Il comando che chiude il cielo alla pioggia (17,1) è una sfida portata direttamente a Baal e ai suoi seguaci, che lo invocano dio della tempesta e “padrone” dei cicli naturali della fecondità, sul suo stesso terreno di competenza, dentro il suo stesso territorio (fino a Sidone!); la sfida culminerà al capitolo 18 con il dono da parte del Dio vero, il Dio di Israele, YHWH, sia del fuoco dal cielo (18,38), sia della pioggia (18,45).
La sfida tocca direttamente anche il re, che dovrebbe esercitare la sua autorità in nome di YHWH, e invece si è appoggiato al dio straniero (16,31) sposando la figlia del re di Tiro, Ittobaal, ed erigendo a Baal un altare e un tempio a Samaria, «in modo da irritare il Signore, Dio d’Israele, più di tutti i re d’Israele che l’avevano preceduto» (16,33).
Ma il tema teologico cui tutto è appeso, anche la rettitudine del culto che dev’essere rivolto al vero Dio, è quello dell’obbedienza alla parola di YHWH, che guida sovrana la vita del profeta e fonda la sua libertà e autorità di fronte alle potenze mondane. Elia, infatti, non è presentato immediatamente con il titolo di “profeta” (nabî’, che compare in 18,22 per la prima volta), ma come un servitore di YHWH, «alla cui presenza egli sta ritto» (17,1), che reclama un potere incontrastato per la propria parola («Quando lo dirò io!»).
Tuttavia, la sorgente della sua autorità si rivela subito nella docilità del profeta alla parola di YHWH, che lo invia al di là del Giordano.
Il sostentamento del profeta è disposto e realizzato «per comando» del Signore (17,4), attraverso i corvi (cf. Lc 12,24: «Guardate i corvi: non seminano e non mietono, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutre»).
«Pane e carne al mattino, e pane e carne alla sera» (17,6) ricorda la cura provvidente del Signore per il suo popolo nel deserto (Es 16,8.12) e, al contempo, la manifestazione della sua signoria, della sua “competenza” sull’ordine cosmico e sulla vita del suo popolo: «Saprete che io sono il Signore, vostro Dio» (Es 16,12).
Il dono del cibo al popolo già nel libro dell’Esodo prende i colori di uno scontro di competenze, di giurisdizione, di sovranità, nei confronti di faraone e dell’intero Egitto. Come il faraone era il padre dell’Egitto, incaricato del suo sostentamento, e a lui si rivolge il suo popolo (cf. Gen 41,29-36.53-57), così il Signore si prende cura di Israele, fino allo scontro con faraone (cf. Es 4,21-23), che non vuole “riconoscere” il Signore come vero Dio e vero Re, anche dell’Egitto: «Chi è il Signore, perché io debba ascoltare la sua voce e lasciare partire Israele? Non conosco il Signore e non lascerò certo partire Israele!» (Es 5,2). La risposta al capitolo 15 dell’Esodo: «Il Signore è un guerriero, Signore è il suo nome. […] Il Signore regna in eterno e per sempre!» (Es 15,3.18); e lo riconoscerà tutto il popolo sul Carmelo: «Il Signore è Dio! Il Signore è Dio!» (18,39).
Anche per Elia, la sua esperienza di questa sovrana, divina regia degli eventi, dipende dal fatto che egli agisca «secondo la parola del Signore» (17,5). La complessità delle vicende successive di Elia e della sua figura di profeta dipenderà da questo semplice criterio; la crisi del capitolo 19 e il suo esito drammatico – e perfino paradossale – sono segnati dal suo distacco dalla parola («Che cosa fai qui, Elia?», sentirà chiedere per due volte sull’Oreb: 19,9.13).
La donna di Zarepta
La parola di Dio guida non solo le vicende dei re, dei grandi della storia. Essa mostra la sua forza invincibile anche nelle vicende dei piccoli, soprattutto di quelli che si affidano a lui, e hanno il coraggio di appoggiare la propria vita sulla parola del Signore.
Attraverso la parola del profeta, il Signore ha disposto di estendere alla vedova la protezione e il ristoro provvisti al profeta stesso (17,9.13): il ricordo di questa generosità, unito a quello relativo a Eliseo (2Re 4,1-7) farà dire a Gesù: «Chi accoglie un profeta come profeta, avrà la ricompensa del profeta» (Mt 10,41).
La donna di Zarepta accetta di portare l’acqua al viandante appena giunto; alla sua ulteriore, pur modesta, richiesta, avanza l’obiezione dell’impossibilità, obiezione “giurata”: «Per la vita del Signore, tuo Dio, non ho nulla di cotto». Ma l’esortazione del profeta: «Non temere!» (17,12) la introduce in una teofania, il segno attraverso il quale il Signore si mostra e agisce, attraverso la sua parola. Il segno si realizza proprio attraverso la fede che si fa ascolto: «Quella andò e fece come aveva detto Elia» (17,15), accettando di mettere “prima” l’obbedienza e “dopo” le ragioni di una disperata economia domestica (17,13).
Questo “ordine” contiene tutto il paradosso della fede, la “follia” del Vangelo che osa dare il primo posto a Dio e a Gesù anche a costo della vita: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo» (Lc 14,26).
A differenza dei prodigi del Carmelo, la teofania di Zarepta si compie al buio, dentro la giara della farina e dentro l’orcio dell’olio (cf. Gv 2,9), secondo una dimensione domestica e quotidiana, che costituisce l’ordinarietà dell’esperienza della presenza di Dio e del suo dono di vita. Non a caso, la «piccola focaccia» (17,13) preparata dalla donna per il profeta, e poi per sé e per suo figlio, rievoca nei suoi ingredienti il dono della manna, che cotta in focacce, aveva «il gusto del pane all’olio» (Nm 11,8).
La manna era un dono quotidiano, secondo le necessità di ciascuno, da non accumulare in scorte; se no, imputridiva: «Colui che ne aveva preso di più, non ne aveva di troppo; colui che ne aveva preso di meno, non ne mancava. Avevano raccolto secondo quanto ciascuno poteva mangiarne» (Es 16,18). È il pane che Gesù ci ha insegnato a chiedere al Padre: «Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano» (Lc 11,3), come già insegnava la Sapienza di Dio: «Non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo di pane, perché, una volta sazio, io non ti rinneghi e dica: «Chi è il Signore?», oppure, ridotto all’indigenza, non rubi e abusi del nome del mio Dio» (Pr 30,8-9).
I due spiccioli della vedova
Questa idea, della vita riassunta nella dimensione del quotidiano, dell’ordinario, di ciò che è piccolo e nascosto, ma che alla fine è tutto, ritorna nel Vangelo odierno.
Il racconto di oggi ci porta a sedere con Gesù di fronte alla sala del tesoro del Tempio di Gerusalemme, dove i devoti potevano depositare le loro offerte, gettando delle monete in un contenitore, all’esterno.
Marco ci dice che Gesù «osservava come la folla vi gettava monete». Per noi abituati alla cartamoneta, o alle tessere elettroniche, non è immediato pensare al fatto che tutte le monete fossero di metallo, e che le «molte monete» delle offerte dei «tanti ricchi» dovessero fare molto rumore.
In mezzo a quel frastuono, certamente ostentato, in un ambiente affollato come il tempio in occasione delle feste pasquali imminenti, Gesù si accorge della piccola e quasi silenziosa offerta di una donna, vedova e povera, che getta nel tesoro due monetine di bronzo, del peso di circa due grammi!
Queste monete erano il taglio più piccolo (leptòn, plur. leptà = lett. «sottile») messo in circolazione. La spiegazione – «cioè un quadrante» – è indirizzata ai lettori greco-romani, per i quali costituiva la quarta parte di un asse, 1/64 del sesterzio. Il leptòn attico o “spicciolo”, di bronzo, del peso di circa due grammi, era considerato 1/7 del chalkòs, che a sua volta era 1/96 del didramma o mezzo siclo che era richiesto come tassa annuale per il tempio (cf. Mt 17,24).
Secondo Mt 10,29 con un asse (in greco assarion, cioè 8 leptà) si potevano comprare al mercato due passeri, mentre secondo Lc 12,6 cinque passeri si potevano comprare con due assi. L’equivalenza indicata («due spiccioli, cioè un quattrino») non è esatta, ma esprime bene che si tratta di una cosa da nulla.
Sul gesto della donna, Gesù richiama l’attenzione dei discepoli, invitandoli a uno spettacolo: la vedova, povera, «ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri» (12,43). Quelli hanno dato «dal loro superfluo», lei ha preso «dal suo bisogno» e ha gettato tutto quanto aveva, «tutta intera la sua vita» (12,44).
Gesù aveva appena lodato lo scriba che sosteneva che amare Dio con tutto il cuore e il prossimo come se stessi «vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici» (12,33). Nel gesto della vedova, Gesù riconosce la stessa sapienza, quella di chi trova il tesoro nel campo e vende tutto per averlo (Mt 13,44ss).
Nell’ultima settimana della sua vita, pochi giorni prima di consegnare ai discepoli – «nella notte in cui veniva tradito» (1Cor 11,23) – il gesto profetico sul pane «donato» e sul vino «versato» come memoriale perenne del dono di sé stesso al Padre e ai fratelli, Gesù “si accorge” del gesto della donna anche in mezzo alla confusione, perché lo “riconosce” simile al suo atteggiamento di amore totale e di donazione senza riserve.
San Paolo ci esorta a seguire l’esempio di Gesù, nel servizio dei fratelli: «Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. […] Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia» (2Cor 8,9; 9,7).
«Da questo abbiamo conosciuto l’amore: Egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli» (1Gv 3,16).