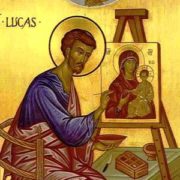La frase chiave di questa domenica non è un invito, ma un’affermazione! Il verbo non è nel modo del congiuntivo esortativo, e neanche di un imperativo, che sarebbe “siate”, ma esprime con chiarezza una situazione di fatto, perché il modo del verbo è “indicativo”, dice ciò che “siamo”, indica una realtà di cui occorre avere coscienza, perché diventa ipso facto una responsabilità.
Il digiuno che Dio gradisce
Il brano profetico (Is 58,7-10) si colloca nel solco della tipica denuncia di una religione ridotta a formalismo rituale e di una conseguente proposta di tradurre la fede nel Dio di Israele in comportamenti che si immagina siano i suoi.
I versetti che precedono il brano proposto nel Messale, e che forse non sarebbe male riprendere anche nell’omelia, descrivono tutta una serie di modi di intendere il digiuno che hanno come regola anzitutto il bisogno di essere visti da Dio: «Perché digiunare, se tu non lo vedi, mortificarci, se tu non lo sai?», contro cui Gesù stesso avverte invece di fare penitenza senza essere visti (Mt 6,18); viene poi il digiunare «tra litigi e alterchi e colpendo con pugni iniqui», per non dire di quella messa in scena mirata a raccogliere l’applauso, che si fa «piegando come un giunco il proprio capo, usando sacco e cenere per letto»!
Certo, la spettacolarizzazione della propria fede, con gesti e atteggiamenti tutti esteriori che si possono calcolare e infilare in maniera vistosa su un «pallottoliere» della fede possono dare l’illusione di far vedere a tutti come si è bravi, ma non è questa la via. Questo è gettare fumo negli occhi, mentre quello che Dio si attende da noi è «una luce che sorge come l’aurora»!
Si noti la stupenda gentilezza dell’immagine. Si è mai avuto la fortuna di osservare il nascere della luce nel silenzio di un mattino in alta montagna? Il vangelo di oggi ci ricorderà che siamo anche chiamati, per vocazione, ad essere «luce che risplende davanti agli uomini, perché vedano le nostre opere buone e rendano gloria al Padre nostro che è nei cieli», ma – come dice Isaia – questa non è la luce degli abbaglianti che accecano e uccidono, ma luce delicata, quasi un sussurro, che ha la sua forza nel mettere in primo piano anzitutto il Dio invisibile piuttosto che l’ingombrante presenza del nostro io.
Il “digiuno” che Dio apprezza consiste nel «dividere il pane con l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i parenti». Possiamo tradurre questi comportamenti in virtù quali la condivisione, l’ospitalità, il dono che arricchisce chi ne è privo, per concludere con l’attenzione caritatevole ai parenti, che si rischia di trascurare magari facendo appello proprio a un amore “universale”, che tale non può essere se non comincia dai vicini.
I benefici di “questo” digiuno sono magnificamente riassunti nei quattro effetti che seguono: diventare luce aurorale che infonde speranza e coraggio, guarire le nostre ferite guarendo quelle degli altri, procedere nel cammino della vita come avvolti da una giustizia che ci precede e dalla gloria del Signore che ci segue.
E, per finire, la meravigliosa prospettiva che si apre in un rapporto familiare e gioioso con il Signore: lo invocherai ed egli ti risponderà! E per non dimenticare, il profeta riprende i comportamenti virtuosi esposti sopra per concludere con uno squillo di fanfara che riprende il tema della luce: «la tua tenebra sarà come il meriggio»!
La sapienza umana davanti al mistero
La seconda lettura (1Cor 2,1-5) ci presenta un Paolo che, in certo senso, si tira indietro; a differenza dei digiunatori bollati da Isaia, si toglie dal proscenio e si colloca sul fondo scena, quasi si auto-cancella: ai cristiani di Corinto dichiara di non essersi presentato ad «annunciare il mistero di Dio con l’eccellenza della parola o della sapienza… ma nella debolezza e con molto timore e trepidazione».
Si dice che, quando arrivò a Corinto, gli scottava ancora la sconfitta subìta dopo il discorso dell’areopago (At 17,32), nel quale aveva fatto un tentativo di “inculturare” il messaggio cristiano in categorie filosofiche, peraltro tipiche della propaganda monoteistica del giudaismo ellenistico.
L’insuccesso di quella proposta, anche se non totale, lo portò a un atteggiamento radicalmente opposto: «Io ritenni di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso».
Certo, la fede ha bisogno anche della ragione, almeno per concludere alla sua ragionevolezza, ma l’atto di fede non è la pura conclusione di un “ragionamento”! La croce resta pur sempre, da qualsiasi parte la si guardi, scandalo e stoltezza (1Cor 1,22-23), realtà irriducibili a qualsiasi tentativo di razionalizzazione. La croce, in se stessa, rimane un grosso punto interrogativo, come rimane tutto il male che c’è nel mondo.
L’unica risposta a quell’interrogativo è il corpo di Gesù che vi è morto sopra, e la risposta decisiva è la sua risurrezione, che è la firma messa da Dio sul senso di quella morte. È importante che Paolo riassuma il senso del suo discorso ricordando che ciò che egli intende e desidera è che «la nostra fede non sia fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio».
La croce, con tutto ciò che questo significa, resterà sempre un problema, e la fede richiederà sempre un “salto” di fiducia che chiama in questione la nostra libertà di decisione. Così come la fede, in quanto adesione a Gesù Cristo, e a Cristo crocifisso, che è e rimane stoltezza e scandalo rispetto al buon senso di una visione tutta mondana delle cose, resterà sempre aperta al dubbio e agli interrogativi che tale prospettiva continuerà a porre.
La “sapienza umana” la conosciamo bene, la “potenza di Dio” possiamo solo intravederla, ma in modo tale da porre in essa la nostra speranza. Non è facile, e però un “tuffarsi” nell’amabilità di un Dio che si è rivelato nella figura umana di Gesù, ha l’effetto liberatorio di toglierci da un eccesso di attenzione a noi stessi, il che ci rende più disponibili e aperti verso gli altri, gioiosi di condividere con tanti lo stesso affidamento.
Sale, luce e città sul monte
Il vangelo (Mt 5,13-16) ci presenta tre modi di presenza nel mondo del discepolo di Gesù: il sale della terra, la luce del mondo, la città sopra un monte; aggiunge poi che queste tre figure rispondono all’esigenza che la fede “si veda”, precisando che questa visibilità è mirata a visualizzare e celebrare la “bontà del Padre”. Questo rimane il vero e unico obiettivo del “mostrare” quale effetto faccia sulla vita del discepolo ciò che egli afferma di credere.
All’opposto, le visualizzazioni di un “digiuno” tutto esteriore e formale cui non segue alcun effetto di una vita virtuosa, già denunciate da Isaia, costituiscono non un aiuto a questa epifania della bontà, ma sono piuttosto un ostacolo, diventano un sale insipido, una lampada che irradia fumo e tenebra, una città che sprofonda nel nulla.
Vorrei collegare le tre figure al «piccolo granello di senapa» e al «lievito» di cui parla Mt 13,31-33, che con la loro natura di “piccolezza e di nascondimento” aiutano a leggere in modo non vacuamente trionfalistico le tre metafore presentate nel vangelo odierno.
Tenendo ben chiaro nella mente che la missione del discepolo nel mondo è quella di rivelare con trasparenza la bontà di Dio, è possibile evitare il rischio di una sorta di narcisismo spirituale, o di autoreferenzialità, che rimane sempre nel desiderio di una visibilità della fede vissuta.
La posizione radicale di Paolo, che mette al centro dell’annuncio cristiano Cristo, e Cristo crocifisso, mira proprio a battere in breccia tale illusione.
Comincio dal sale, circa il quale ricordo un’affermazione di padre Sorge, che, in anni in cui da qualche quartiere cattolico si criticava la “scelta religiosa” dell’Azione cattolica come un rintanarsi nelle catacombe, ebbe a dire: «Gesù ci chiede di essere sale del mondo, non di trasformare il mondo in una saliera»!
Quanto alla luce poi, mi è capitato di riflettere che ai tempi di Gesù, e per moltissimo tempo dopo, questa parola aveva un senso ben diverso dal nostro, abituati ormai a un eccesso di illuminazione (si parla in proposito di “inquinamento”) che ha i suoi rischi. Fino a neanche un paio di secoli fa, credo che la luce prendesse tutto il suo significato in riferimento al buio e alla notte: era la luce di una candela o di una lanterna, la luce prodotta da un fuoco, una luce viva, cioè, che nasceva da qualcosa che si consumava: la cera, l’olio o la legna. Applicato a noi, questo fatto ci ricorda che non basta un clic su un pulsante perché le nostre opere diventino luce, e se pensiamo che l’opera di fede per eccellenza è il dono di sé, è necessario che qualcosa in noi bruci e si consumi perché questo appaia; detto in altri termini, qualcosa deve morire perché si manifesti la vita, perché si accenda una luce.
Circa la città sul monte, sempre pensando ai tempi del vangelo, penso che si possa dire che una vista del genere è possibile solo da lontano, qualcosa cioè che non si può toccare con mano, ma è piuttosto un traguardo che si intravede, un ideale da raggiungere, del quale le nostre opere “buone” sono solo una visione parziale, appunto perché la visione totale è solo la bontà di Dio.
Non so quanto tale interpretazione possa trovare consensi, ma ritengo che in tale lettura ci sia una sua coerenza, soprattutto se si pensa al regno paragonato alla sproporzione che esiste tra il granello di senapa e l’albero che ne nasce, e al lievito rispetto alla pasta. Ma ancor più si deve riflettere alla messa in guardia di Gesù, che ci invita a digiunare «nel segreto» (cf. Mt 6,17-18), un avvertimento da tenere in tensione con il «vedano le vostre opere buone».
L’equilibrio – come si sa – non risulta dallo scartare l’una o l’altra delle cose che sembrano opporsi: questo produrrebbe solo l’appiattimento, o l’unilateralità tipica del fanatismo vociante o della timidezza paralizzante: l’equilibrio – come è stato detto – è la sana gestione degli opposti, che, tenuti insieme, arrivano a temperarsi saggiamente gli uni gli altri. È, come si dice, la logica dell’e/e, e non dell’o/o.
Per arrivare a questo traguardo, la pratica della riflessione e della preghiera non è mai troppa.