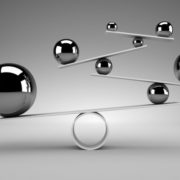Doveva averne fatte di grosse Saulo quando era a Gerusalemme se la sola memoria di lui suscitava paura e incredulità. La figura di Barnaba sarebbe da riscattare dall’oblio, perché sembra che, se non fosse stato lui a recarsi a Tarso a togliere Saulo dal luogo dove aveva dovuto rifugiarsi e a portarlo nella comunità effervescente di Antiochia, forse tutto sarebbe finito.
È utile riassumere, anche se brevemente, i soggiorni dell’apostolo in tre delle prime comunità: Damasco, Gerusalemme, Antiochia, dove colui che ora è Paolo cresce gradualmente nella conoscenza di Gesù e, di conseguenza, nella comprensione e nella predicazione della fede.
I suoi spostamenti non sono passaggi turistici, ma “fughe”, segno e inizio di una vita tormentata ed errabonda, già preannunciata dal Signore ad Anania quando lo invita a incontrarlo (At 9,16). Il suo impeto nel proporre la radicale novità prodotta da Gesù, culminata nella sua morte e risurrezione, aveva di che sconvolgere e irritare.
Le peripezie di Paolo
A Damasco, Paolo aveva incontrato Anania che l’aveva introdotto nel cuore della fede, gli aveva “imposto le mani”, gesto con cui Saulo viene trasformato per servire la comunità in nome di Dio (cf. At 6,6 dove si parla dei primi diaconi), è ricolmato di Spirito Santo (At 8,17), è guarito nella sua cecità (At 8,17) per vedere con occhi nuovi la vicenda di Gesù, così come quando sarà inviato in missione (13,3). Damasco diventa il primo apprendistato del suo futuro apostolato.
Luca stabilisce un’evidente connessione tra Saulo e Stefano, al martirio del quale egli aveva assistito e del quale «approvava l’uccisione» (At 8,1).
Mi chiedo se, nel soggiorno di Damasco, Paolo non abbia a volte, o spesso, ripensato alla figura del protomartire, e forse abbia pure previsto che a lui sarebbe toccato lo stesso destino. Di Saulo è sottolineato il coraggio della testimonianza e la forza della predicazione, con il risultato in ambedue i casi di suscitare ostilità e di far nascere un complotto per metterlo a tacere per sempre. È quanto in effetti succede, e Saulo è costretto, in modo un po’ rocambolesco, a fuggire di notte calato dalle mura in una cesta (At 9,25).
Finisce che torna a Gerusalemme, ma qui non è solo Anania, ma «tutti avevano paura di lui»: è il brano di At 9,26-31 proposto oggi in prima Lettura. Non era certo l’accoglienza che si aspettava. Qui ha la fortuna di incontrare un uomo di Cipro, Barnaba, col quale si legherà in una fortissima amicizia. Costui lo introduce agli apostoli spiegando come sulla via di Damasco egli era cambiato. Così Paolo poteva «stare con loro, andare e venire in libertà, predicando apertamente nel nome del Signore».
Lo stesso Paolo ci farà poi sapere che, tre anni dopo un periodo in Arabia e ritorno a Damasco, si era recato a Gerusalemme anche per fare la conoscenza di Pietro (Gal 1,18), per confrontarsi con gli apostoli e verificare – per così dire – la giustezza della sua predicazione (Gal 1,18-24).
Sembra appaia già la sua futura apertura, perché «parlava con quelli di lingua greca», ma proprio da lì parte un tentativo di ucciderlo. Altro pericolo, altra fuga, perché, vista la malaparata, «i fratelli lo fecero partire per Tarso», la sua città natale.
Segue una annotazione a prima vista sorprendente, perché Luca osserva che, come conseguenza della sua partenza, «la Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria, si consolidava e camminava nel timore del Signore e, con il conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero». Non riesco a sottrarmi all’impressione che, partito il disturbatore della quiete pubblica, tutto torna tranquillo.
Cosa avrà fatto Paolo a Tarso nei dieci anni che vi passò? Mi viene da pensare che siano stati anni di riflessione e di approfondimento, forse quelli in cui ha maturato la sua gigantesca dottrina che apparirà poi nelle Lettere, che avrebbero fatto di lui – come sostiene qualcuno creando confusione – il vero fondatore del “cristianesimo”.
Ma la fede, se pure ha bisogno di nutrirsi di riflessione, per crescere ed essere vissuta ha bisogno di una comunità. E, in effetti, la terza e ultima tappa di preparazione al ministero, matura ad Antiochia, dove Barnaba, stanandolo dal suo rifugio, lo conduce per immergerlo nel fervore di una comunità dai molti colori.
La comunità era nata da quelli che erano “fuggiti” da Gerusalemme in seguito all’uccisione di Stefano, e che predicano Gesù, ma limitandosi ai giudei. Arriva però tra loro gente già cristiana che veniva dall’isola di Cipro, come Barnaba, e da Cirene, nell’attuale Libia. Questi rompono gli argini, e si mettono a parlare di Gesù anche ai pagani di lingua greca: il successo è straordinario. Probabilmente erano persone più aperte, per i quali non era necessario diventare ebrei per essere discepoli di Gesù, perché pensavano che il vangelo era destinato a chiunque.
È in questa comunità antiochena che i discepoli vengono chiamati per la prima volta «cristiani» (At 11,26), il che rivela chiaramente che ciò che univa i “fratelli” era il comune riferimento a Gesù.
Dal fervore entusiasta di questa comunità, Paolo parte ancora una volta, con Barnaba, ma questa volta non si tratta di una fuga, ma di un solenne invio in missione, e da qui nascerà il primo dei quattro viaggi di Paolo.
Dai comandamenti al comandamento
La vita fraterna diventa il tema della seconda Lettura (1Gv 3,18-24), a partire dall’incipit di un’estrema concretezza: «Fratelli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità».
Mi pare che la storia della conversione di Paolo, che è stata sopra inquadrata, trovi il suo migliore commento e la più sicura verità in quanto Giovanni afferma subito dopo la frase citata: «In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa».
Come siamo lontani dal Dio inquisitore che trionfava nella mia infanzia, con quel triangolo con al centro un grande occhio con la scritta “Dio mi vede”, che appariva dappertutto sui muri dell’oratorio, anche nei luoghi più privati! Bisognerebbe imparare ad amare gli altri non con la paura di sbagliare, ma con la memoria costantemente immersa nella benevolenza di Dio, come raccomandano spesso tutti i grandi autori spirituali.
La memoria dei peccati paralizza la voglia di bene, la memoria della gratuità assoluta con cui Dio ci perdona dovrebbe invece dilatare il nostro cuore, aprendolo all’accoglienza e all’attenzione verso le persone.
Poi c’è un’altra affermazione chiave, che merita di essere sottolineata: la nostra fiducia in Dio si basa non solo sulla sua bontà, ma è rafforzata dalla nostra capacità di imitarla, osservando «i suoi comandamenti», che subito diventano uno solo: «il suo comandamento»! Quale? Che «crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato». La verità è la fede, i fatti sono la carità: l’una cosa non può esistere senza l’altra.
Poi appare un verbo che Giovanni ha conosciuto bene: rimanere. Due volte in questo passo della sua lettera, e sette nel brano di vangelo che segue! Si rimane col credere, si rimane col fare.
Siamo in stato di potatura
Dal discorso dell’ultima cena, la liturgia odierna ha tratto la stupenda e commovente immagine della vite e dei tralci, e del rapporto intrinseco che li lega (Gv 15,1-8). Un tralcio è dove la vite genera frutti, a patto di rimanere nella vite, che gli fornisce la linfa vitale. Ma questa generazione, per funzionare, esige che la vite sia “potata”.
Vivo vicino alle colline, e ricordo molto bene la stagione della potatura primaverile, quando la vite sembrava mortificata, ma si sapeva che solo a quella condizione l’avremmo vista poi rigogliosa e carica di grappoli gonfi e numerosi. Il seguito – «Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato» – va forse spiegato, perché se siamo già puri, siamo a posto. Fausti traduce «già mondi», e questo aiuta meglio a comprendere, perché il verbo mondare, che significa togliere escrescenze superflue e dannose, è più vicino al senso del verbo potare, l’azione che si richiede per ottenere una “purificazione”, e che si riferisce più a un mezzo che a un risultato.
E si capisce così che siamo già in stato di potatura grazie al costante rimanere nella parola che ci è stata annunciata. E qui torna utile un passo splendido di Giuliana di Norwich, che appare in quella serie di capitoli dove la mistica illustra la sua teologia della maternità di Dio che si realizza nel Figlio. Ecco quanto scrive: «Dio vuole che aderiamo fermamente alla fede della santa Chiesa, trovando in lei la nostra carissima madre, che ci consola e ci aiuta a capire, in comunione con tutti i beati. Una singola persona, infatti, può sovente spezzarsi se considera solo se stessa, ma l’intero corpo della santa Chiesa non può né potrà mai spezzarsi. E perciò è cosa sicura, buona e amabile, il volere con umiltà e con forza essere legati e uniti alla santa Chiesa, nostra madre, che è Cristo Gesù» (Una rivelazione dell’amore, c. 61, p. 280).
La maternità del Figlio, che qui non è possibile illustrare nei magnifici sviluppi che le dà Giuliana (vedi cc. 58-63), non deve essere una glorificazione trionfalistica della Chiesa – che sappiamo quante volte nella storia, di ieri e di oggi, si è mostrata infedele a questa sua vocazione – ma piuttosto un’indicazione di ciò che la comunità dei fedeli deve fare, in capite et in membris, come si è sempre ricordato in tempi di crisi quando si invocavano “riforme”.
A difetto di spazio, non trovo di meglio che citare una frase della stessa Giuliana, dove tutto è detto in tre sostantivi e quattro verbi: «La misericordia opera in quattro modi: custodisce, sopporta/supporta, ravviva e risana, e tutto viene dalla tenerezza dell’amore» (c. 48, p. 235-36).