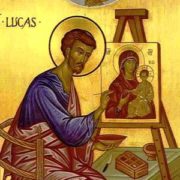La liturgia della domenica di Pasqua permette varie scelte. Vorrei approfittare di questa possibilità per svolgere una riflessione su due paradossi fondamentali che forse, nel luccichio della festa, rischiamo di trascurare: il trionfo dello “scarto” e i “margini” che diventano il centro della rivelazione e del “luogo” dove incontrare il Risorto nel vangelo.
Il primo riferimento si trova nel Salmo responsoriale della messa del giorno di Pasqua (Sal 117,22-23), il secondo è affidato alla conclusione del vangelo di Marco (Mc16,1-7), proclamato nella Veglia pasquale dell’Anno B, e che è possibile scegliere in sostituzione di Gv 20,1-9, previsto per la liturgia della festa.
Già a Betlemme è presente la croce
Cogliere nel ricco materiale utilizzabile questi tema correlati, potrebbe sembrare una civetteria di chi vuole essere a tutti i costi originale, magari con l’intento neanche tanto velato di sorprendere l’ascoltatore o il lettore. Non è il mio caso. Si tratta invece di due principi molto importanti, sui quali basare attenzioni e scelte di rilievo se si vuole entrare nella logica di Gesù.
La teologia dello scarto è diventata moneta corrente ormai, da quando papa Francesco ne ha fatto uno dei pilastri della sua catechesi e delle sue opzioni pastorali. Ma questo serve solo a mettere in primo piano un principio: che, fin dalle sue origini, la Chiesa ha presto capito come questa fosse la strada percorsa dal suo fondatore, Gesù di Nazaret, fin dalla nascita.
La trasfigurazione di due realtà apparentemente negative se giudicate con il senso comune del mondo, è sicuramente un paradosso, termine che significa “qualcosa che va al di là dell’opinione comune”, ma la nostra fede – mi capita di ricordarlo spesso – ha nel suo stesso cuore il paradosso, dalla nascita in una stalla, lontano da casa, alla morte su una croce, il patibolo dei delinquenti. Ed è solo la storia di Gesù, sulla quale getta un fascio di luce rivelatrice la risurrezione, che dà senso a ciò che sembra un non senso.
Con una formula folgorante, il grande predicatore anglicano Lancelot Andrews (1559-1626), in un Sermone per il Natale del 1618, commentando Lc 2,12-14 dove si parla del segno offerto ai pastori, “un bambino in una mangiatoia”, per mostrare come quello sia un segno “adeguato”, esprime così la connessione che lega lo scarto con i margini: «Possiamo anche cominciare con Cristo nella greppia: dobbiamo finire con Cristo sulla croce» (L. Andrewes, Dio è diventato uomo, Qiqajon 2012, p. 212). I corsivi sono nello stesso originale inglese, e l’enfasi sulle tre parole è per di più marcata dell’allitterazione Cr– che le lega con ancora più forza.
La cosa può sorprendere se pensiamo che il Natale, soprattutto il “nostro”, fa a pugni con il Venerdì Santo. Non è così. Molte ninnenanne medievali collegano il pianto del Bambino con la sofferenza del Crocifisso. Ma anche Dag Hammarskjöld, lo svedese segretario dell’ONU, perito nel 1961 in un attentato mentre era in Congo in missione di pace, ha scritto in un suo Diario, scoperto dopo la morte, che lo ha rivelato come un vero mistico: «Per chi guarda davanti a sé, il Golgota è il luogo del presepio, e la croce è già innalzata a Betlemme» (Tracce di cammino, Qiqajon 20052, p. 212 nota 14).
Possiamo evidenziare la sequenza Cratch – Christ – Cross, greppia-Cristo-croce, dove la posizione centrale di Cristo si riverbera sia all’indietro che in avanti, facendo così da perno a un filo continuo che rende logico ciò che sembrerebbe assurdo.
La carità prima della verità
Il Salmo 117, dal quale sono tratti i versetti 22-23 sopra indicati, proprio grazie ad essi è diventato un salmo obbligatorio nella Liturgia delle Ore della domenica, usato all’Ora Media nelle domeniche 1 e 3, e alle Lodi nelle domeniche 2 e 4. È un canto di lode di un perseguitato scampato al pericolo, e prende tutta la sua rilevanza perché aiutò i primi discepoli a capire il senso della morte di Gesù, che non avevano compreso quando lui era in vita, come afferma Pietro che lo cita in At 4,11 a conferma della risurrezione.
«Con quale potere avete fatto questo?» (la guarigione di uno storpio: At 3,1-8), Pietro afferma con chiarezza che quel potere viene loro dalla «pietra che voi avete scartato», una convinzione che ripete due volte nella sua Prima Lettera 2,4.7.
Da questa fede, il cistercense Isacco della Stella (XII sec.) ricava un invito a tutta prima sorprendente. In un sermone, dopo aver detto che, per seguire Gesù, bisogna visitare nella contemplazione la sua immagine «al di sopra di sé» e, attraverso la carità, quella del fratello «accanto a sé», aggiunge una terza visita possibile, così espressa: «Anche quando la carne vedrà la sua immagine che, a causa della debolezza, si trova “al di sotto di sé”, non ne abbia orrore, non rifugga dal servizio, non rifiuti il tocco della pietà. L’anima infatti non riuscirà mai a vedere nella contemplazione la sua immagine al di sopra di sé, se non quando nella carità la carne si piega verso la sua immagine che sta sotto di sé (Sermone 12,8)».
Qual è la ragione di una proposta così contro il buon senso? Presto detto: «La divina sapienza, che è insieme medicina e dottrina, pur potendolo fare con la parola, preferì curare il lebbroso con il tatto, affinché tu ti dia a fare il bene non nel modo più facile, ma nel modo più affettuoso. Compi l’opera della pietà, non aborrire niente, fai sempre attenzione a colui per il quale agisci. Egli è sempre bello (Serm. 12,9)».
Basta questo per vedere quanto è concreta la spiritualità di un grande intellettuale che aveva frequentato le nascenti scuole cattedrali dove si stata elaborando la filosofia dialettica. È forse per essere rimasto deluso da quella “scienza nuova”, tutta impostata sulla ragione, che lasciò una carriera promettente per farsi monaco tra i cistercensi, che amavano chiamarsi «i poveri di Cristo»?
Si rilegga con attenzione. Isacco mette la medicina prima della dottrina, la carità prima della verità, e per guarire considera il tatto più importante della parola (ci pensino tutti i “professori” e i parolai!), e chiede di fare il bene non nel modo più facile, ma nel modo più affettuoso.
Tutto ricomincia dalla Galilea
La riflessione sul significato e il valore dello “scarto”, principio fondamentale nella vicenda della morte e risurrezione di Cristo, si è rivelata ricca di conseguenze. Ma non finisce qui. Venendo al vangelo (Mc 20,1-7), le tre donne partite per ungere un cadavere – chiamate per questo le Mirofore – si sentono dire per bocca di un angelo: «Voi cercate Gesù il Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto».
La Galilea delle genti, luogo “marginale”, del quale a Gerusalemme si aveva un’opinione appena poco migliore di quella riguardante i samaritani, diventa il “luogo” dove incontrare colui che, da scarto, era diventato pietra angolare, e per poco che ci si pensi, la cosa ha una sua logica. In qualche modo dimostra che – come abbiamo sentito la notte di Natale – «il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse» (Is 9,1).
Questo è lo stile di Dio: sembra che le tenebre lo attraggano, così come gli scarti, perché forse questa marginalità li rende più adatti a sentire il bisogno della luce e ad apprezzarla quando arriva. Non vanno forse in questa direzione le figure dei pastori e dei magi, i primi a ricevere l’annuncio di un Salvatore, di pubblicani e prostitute, che precederanno coloro che si sentono “giusti”?
La Galilea è il luogo dove tutto è iniziato, è giusto che venga scelta come il luogo dove tutto ricomincia. Mt 28,5-7 dice la stessa cosa, e con lo stesso intento. Dove può portare una riflessione sui margini? Basta farla partire da dove nasce la categoria della “marginalità”, e si cominciano a vedere alcune conseguenze rilevanti. Per creare una marginalità bisogna avere un centro e una frontiera.
È importante, anzitutto, rendersi conto che il termine marginalità non è un concetto astratto, e nemmeno un’elegante metafora, ma è legata profondamente all’esperienza delle persone: quelle che si sentono al centro, da una parte, e quelle che si sentono escluse o disprezzate, dall’altra. Questa doppia lettura crea mentalmente ed emotivamente una frontiera, quella che separa noi dagli altri.
Non ci vuole molto a fare una lista degli appartenenti alle due zone: i retti e i reprobi, i giusti e gli ingiusti, gli intelligenti e gli ignoranti, i compatrioti e gli stranieri, quelli di una razza, magari ritenuta superiore e la più pura, e quelli di un’altra, i giovani e i vecchi, e via discorrendo. Quante volte Gesù nei vangeli si è scontrato con queste categorizzazioni!
Quale uscita, dunque? Non certo lo sforzo della categoria emarginata di autoesaltarsi fino a capovolgere la situazione: questo, al di là delle possibili, e magari comprensibili, reazioni di chi si sente umiliato, non cambia nulla se non mutando le posizioni: chi sta al di qua e chi al di là della “frontiera”. Si dovrebbe capire che non c’è che una via per superare tali dicotomie: l’abbattimento della frontiera, passare dal “noi/loro” al “noi con loro”, “noi in loro”.
Chi ci guida in questa operazione? Gesù, e nessun altro; Gesù, il quale ci ha rivelato, con il suo stile prima che con le sue parole, che Dio è il Padre di tutti, e dunque che tutti siamo fratelli. È l’unica categoria che vale nel regno di Dio, quello che nasce e cresce quaggiù, s’intende, non nelle nuvole! Per eliminare i margini bisogna farsi margini, lasciare l’idea che noi siamo centro ed entrare in quella “patria” che è davvero tale se “tutti” si ritrovano nei margini, ciascuno cosciente delle sue ombre e delle sue possibilità di essere luce. Questa consapevolezza genera l’accoglienza, cuore della vita cristiana (cf. Rm 15,7).
La seconda lettura, facoltativa e da preferirsi (Col 3,1-4), invita a cercare le “cose di lassù”. Dove? Quaggiù, perché quelle di lassù sono esattamente i comportamenti che nascono dalle riflessioni fatte sopra: la maniera positiva di vivere lo scarto, la scelta di abitare i margini, la capacità di apertura e accoglienza.