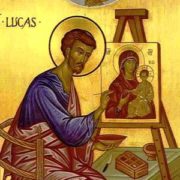La fede è spesso messa a dura prova dall’assurdità di certe situazioni, da avvenimenti che sembrano provare l’assenza di Dio o almeno il suo disinteresse per ciò che accade nel mondo. I salmisti osano rivolgergli accuse quasi blasfeme: “Tu sei lontano dalla mia salvezza… Ti invoco e non rispondi” (Sal 22,2); “Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi?” (Sal 13,2).
È quella che i mistici chiamano la “notte oscura”, quella in cui vacillano ogni certezza e anche la speranza. È il caso – cito un esempio fra i tanti – di Teresina di Lisieux che, al termine della sua vita, udiva nell’intimo una voce beffarda ripeterle: “Tu credi di uscire dalle nubi che ti circondano. No, la morte non ti darà ciò che speri, ma una notte ancora più buia, la notte del nulla”.
Che cosa prova Dio di fronte alle nostre angosce, ai nostri dubbi, ai nostri tormenti? È sensibile al nostro dolore?
A questi interrogativi Dio risponde con una domanda: “Può una madre dimenticarsi del suo bambino?”. Poi, come rendendosi conto che neppure questo paragone riesce ad esprimere il suo amore fedele e la sua premura per l’uomo, aggiunge: “Anche se vi fosse una donna che si dimenticasse, io non ti dimenticherò mai” (Is 49,15). L’immagine materna è efficace, per questo viene ripresa: “Come una madre consola un figlio così io vi consolerò” (Is 66,13). È commovente la promessa del Siracide: “Sarai come un figlio dell’Altissimo, ed egli ti amerà più di tua madre” (Sir 4,10).
Difficile crederlo in certi momenti, eppure un giorno constateremo che era vero.
Per interiorizzare il messaggio, ripeteremo:
“Sono tranquillo e sereno, come bimbo svezzato in braccio a sua madre”.
Prima Lettura (Is 49,14-15)
14 Sion ha detto: “Il Signore mi ha abbandonato,
il Signore mi ha dimenticato”.
15 Si dimentica forse una donna del suo bambino,
così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere?
Anche se queste donne si dimenticassero,
io invece non ti dimenticherò mai.
In Israele, prima di ripudiare la moglie, il marito doveva riflettere a lungo perché si trattava di una scelta irreversibile, non erano ammessi ripensamenti, non gli era più permesso di riprendersela.
In esilio, a Babilonia, Israele si sente una sposa ripudiata. Sa di essere stata infedele, di aver tradito il suo Dio, ha abbandonato ogni speranza di ricostruire il rapporto d’amore infranto e, mestamente, va ripetendo: “Il Signore mi ha abbandonata, il Signore mi ha dimenticata” (v. 14). È il lamento con cui inizia la lettura di oggi ed è l’espressione della dolorosa esperienza di chiunque, caduto nell’abisso del peccato, si rende conto di aver fatto scelte di morte ed è convinto che anche il Signore lo rifiuti.
Questi pensieri sorgono quando vengono proiettati in Dio i nostri criteri di giudizio e le nostre meschinità. Compare allora il Dio suscettibile, permaloso e persino vendicativo. Questa deformazione del suo volto è la più subdola delle astuzie diaboliche e il Signore si premura di cancellarla. Per bocca del profeta dichiara: “Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù? Io ti riprenderò con immenso amore” (Is 54,6-7).
Il suo amore non è una risposta ai meriti o alle dimostrazioni di affetto dell’uomo, è una passione incontenibile che prescinde dalle nostre opere buone, è come l’amore di una madre – ecco la nuova, commovente metafora introdotta dalla lettura di oggi (v. 16) – un amore incondizionato e invincibile. Una madre ama il figlio non perché è riamata, ma perché è suo figlio e lo amerà sempre, qualunque cosa egli faccia.
Quest’immagine ha già in sé una forte risonanza emotiva, tuttavia, per comprenderne tutta la ricchezza, vale la pena ricordare alcune celebri figure di madri bibliche: il sublime eroismo di Rispa che “dal principio della mietitura dell’orzo, fino a quando dal cielo non cadde su di loro la pioggia”, vegliò i cadaveri dei figli consegnati alla morte da Davide (2 Sam 21); il coraggio della madre di Mosè che sfida l’ordine del faraone pur di salvare il figlio (Es 2,2-9); il tormento della meretrice che accetta di essere privata del figlio purché non venga ucciso (1 Re 3,16-17); la forza d’animo della madre che incoraggia i figli ad affrontare la morte per non rinnegare la fede (2 Mac 7).
Tutta questa carica di emozioni e di sentimenti è presente nell’immagine dell’amore di una madre e aiuta a comprendere con quale passione Dio ama e si interessa dell’uomo.
Seconda Lettura (1 Cor 4,1-5)
1 Ognuno ci consideri come ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. 2 Ora, quanto si richiede negli amministratori è che ognuno risulti fedele. 3 A me però, poco importa di venir giudicato da voi o da un consesso umano; anzi, io neppure giudico me stesso, 4 perché anche se non sono consapevole di colpa alcuna non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore! 5 Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, finché venga il Signore. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori; allora ciascuno avrà la sua lode da Dio.
La parola del vangelo è il più grande dono che si possa ricevere, per questo è facile non solo provare profonda simpatia e riconoscenza per chi lo ha offerto, ma anche legarsi fin troppo al messaggero. Accade oggi ed è accaduto anche nella comunità di Corinto dove, a causa dell’attaccamento all’uno o all’altro degli apostoli, erano sorti dei partiti: alcuni si gloriavano di appartenere a Pietro, altri ad Apollo, altri ancora a Paolo (1 Cor 1,12).
Il brano di oggi conclude la lunga trattazione di questo argomento, iniziata con il severo monito: “Cristo è stato forse diviso? Forse Paolo è stato crocifisso per voi, o è nel nome di Paolo che siete stati battezzati?” (1 Cor 1,13).
Paolo impiega il plurale – “Ognuno ci consideri come ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio” (v. 1) – perché non parla solo di sé, si riferisce a tutti gli annunciatori del vangelo. Con due termini espressivi ne definisce il ruolo: sono ministri (hypêrétai in greco) cioè inservienti che liberamente hanno accettato di svolgere un incarico; sono dei subordinati, dei dipendenti a servizio di un signore, Cristo; sono degli amministratori (oikónomoi in greco, economi) non dei padroni, hanno in mano beni che appartengono a Dio, a loro sono stati solo affidati affinché li facciano fruttare.
Agli amministratori si richiede solo la fedeltà (v. 2). Chi annuncia il vangelo – intende dire Paolo – deve avere un’unica preoccupazione: trasmettere il messaggio del Maestro, senza nulla aggiungere e nulla togliere. Il padrone non gli chiederà se è riuscito a convincere molte persone, se si è accattivato la simpatia degli uomini, se ha ricevuto applausi e approvazioni; domanderà soltanto se ha annunciato il vangelo secondo verità, senza cedere agli opportunismi, senza scendere a compromessi, senza rispetti umani.
Nella seconda parte del brano (vv. 3-5) Paolo risponde alle critiche che i corinzi gli muovono. Assicura che non è per niente preoccupato dei giudizi pronunciati su di lui, siano essi di approvazione o di condanna. Non è ai corinzi che deve rendere conto del proprio operato, ma a Dio. Non si fida nemmeno del giudizio della sua coscienza, anche se, onestamente, riconosce che non gli rimprovera nulla (v. 4). Tiene presente questo giudizio, ma non lo considera definitivo, attende quello del Signore che verrà pronunciato al termine della dura “giornata di lavoro”.
Le parole dell’Apostolo non sono un invito a ignorare il giudizio che una comunità pronuncia su chi svolge un ministero. La comunità ha il diritto e il dovere di esprimere il proprio parere sull’operato dei ministri e amministratori e questi non possono arrogarsi il diritto di agire in modo arbitrario e di “comportarsi da padroni” (1 Pt 5,3). Ma non va dimenticato che, solo alla fine, “ciascuno avrà la sua lode da Dio”.
Vangelo (Mt 6,24-34)
24 Nessuno può servire a due padroni: o odierà l’uno e amerà l’altro, o preferirà l’uno e disprezzerà l’altro: non potete servire a Dio e a mammona.
25 Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? 26 Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? 27 E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un’ora sola alla sua vita? 28 E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano e non filano. 29 Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. 30 Ora se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? 31 Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? 32 Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. 33 Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. 34 Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena”.
Il bambino che perde i genitori non può stare solo, ha bisogno di avere qualcuno in cui riporre la sua fiducia, qualcuno che gli dia sicurezza. Egli cerca spontaneamente un modello, un punto di riferimento nella vita.
Capita anche con Dio: non se ne può fare a meno, non si può rimanerne orfani; chi lo rifiuta, lo rimpiazza subito con un sostituto. Il pericolo non è l’ateismo, ma la scelta del dio sbagliato.
Molti credono che, nell’alto dei cieli, ci sia un Padre che si prende cura di loro; costoro sono convinti che egli prova per loro anche sentimenti materni: si interessa, con affetto e sollecitudine, dei loro bisogni. Se egli è padre di tutti, gli uomini non sono dei compagni di viaggio, dei vicini più o meno simpatici, più o meno meritevoli di attenzioni; non sono degli antagonisti con i quali competere o, peggio ancora, dei nemici da combattere, ma dei fratelli da amare e aiutare.
Non tutti accettano questo Padre. A chi lo rifiuta si presenta subito, con tutto il suo incantevole fascino, il più seducente, il più subdolo degli idoli, il denaro. Il vangelo di oggi inizia con una denuncia della pericolosità di quest’idolo (v. 24).
Matteo ci ha conservato il termine aramaico – mamônâ – usato da Gesù. È significativo: deriva dalla radice ’aman che vuol dire offrire sicurezza, essere solido, affidabile. Il denaro, come Dio, garantisce ogni bene a chi gli presta culto: dona cibo, bevande, salute, piaceri, divertimenti; ma cosa chiede in cambio? Come ogni dio, esige tutto.
Dio è il punto di riferimento dei pensieri, delle azioni, della vita dell’uomo e vuole essere amato “con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze” (Dt 6,5). Anche il denaro pretende il coinvolgimento totale dei suoi devoti. Per amor suo bisogna essere disposti a rinunciare alla propria dignità, a ingannare, a rubare, a rovinare gli altri, a perdere le amicizie, a trascurare persino moglie e figli (per loro non ci sarà più tempo!), bisogna essere pronti anche a uccidere. Coloro che adorano il denaro hanno tutto, ma non sono più uomini, divengono schiavi. “L’attaccamento al denaro – scrive l’autore della lettera a Timoteo – è la radice di tutti i mali; per il suo sfrenato desiderio alcuni hanno deviato dalla fede e si sono, da se stessi, tormentati con molti dolori” (1 Tm 6,10) ed è un’idolatria (Ef 5,5).
La prima follia in cui trascina l’adorazione di mamônâ è l’accumulo. Chi accumula si illude di aver trovato un obiettivo concreto e gratificante che dia un senso alla vita, ma ha solo scoperto un vano ripiego per esorcizzare il pensiero della morte. “Lasciare in eredità” è un palliativo.
Il Padre che sta nei cieli si colloca agli antipodi: invita alla rinuncia all’uso egoistico del denaro. Non chiede di “non rubare”, di fare elemosine, ma di instaurare un rapporto completamente nuovo con i beni; propone la condivisione, l’attenzione ai bisogni dei fratelli. Qualunque forma di accumulo egoistico è una violazione del primo comandamento: “Non avrai altro dio all’infuori di me” (Es 20,3).
Nessuno può servire a due padroni; o odierà l’uno e amerà l’altro, o preferirà l’uno e disprezzerà l’altro. Non è possibile servire Dio e mamônâ.
Noi vorremmo tenerceli buoni tutt’e due, convinti che quello che non ci concede l’uno ce lo darà l’altro. Ma i due non sono soci in affari, sono antagonisti, non possono stare insieme nel cuore dell’uomo, danno ordini opposti. Il Padre che sta nei cieli ripete: “Ama, aiuta tuo fratello, dà cibo a chi ha fame, vesti chi è nudo, offri la tua casa a chi è privo di casa”. Il denaro ordina invece: “Sfrutta il povero, non dare nulla gratuitamente, non preoccuparti di chi è nel bisogno, stima e apprezza le persone in proporzione di ciò che possiedono”.
Il distacco dai beni è uno dei temi ricorrenti nel vangelo ed è uno dei più difficili da assimilare. L’uomo infatti si affeziona ai tesori di questo mondo, è portato ad idolatrarli fino a dimenticare l’eredità “che non si corrompe, non si macchia e non marcisce, quella che è conservata nei cieli” (1 Pt 1,4).
Fin dal suo primo discorso – quello della montagna dal quale è tratto il brano di oggi – Gesù mette in guardia i discepoli: “Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano; accumulatevi invece tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non scassinano e non rubano. Perché là dov’è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore” (Mt 6, 19-21). A chi lo vuole seguire chiede di dare anche il mantello e raccomanda di non volgere le spalle a chi chiede un prestito (Mt 6,40.42).
Le richieste di Gesù sono paradossali e sconcertanti. Prima di decidersi ad accettarle, non si può non chiedersi: Che ne sarà della mia vita? Che cosa mangerò, che cosa berrò, come mi vestirò? Chi mi assicura che avrò poi il sufficiente per vivere? Non mi pentirò di aver rinunciato alla sicurezza che offre il denaro accumulato e goduto? Non sarà meglio limitarsi ad elargire qualche elemosina?
È a questi interrogativi che Gesù risponde nella seconda parte del vangelo di oggi (vv. 25-34) dove invita alla fiducia nel Padre che sta nei cieli, che si prende cura dei figli e che non lascerà mancare il necessario a chi ha creduto in lui.
Le immagini con cui è presentata la premura di Dio nei confronti delle sue creature sono deliziose: “Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? Osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro” (vv. 26-29). Dà quasi l’impressione di essere un ingenuo sognatore, di proporre una vita spensierata, giuliva, ma completamente staccata dalla realtà.
Non è così. Gesù non suggerisce il disimpegno, l’ozio, il disinteresse o la rassegnazione, propone un rapporto nuovo con i beni: non l’accaparramento, ma la condivisione fondata sulla fiducia nella provvidenza di Dio.
Il richiamo è all’esperienza dell’esodo: Israele era un popolo in cammino, non poteva accumulare, piantava tende provvisorie, non costruiva magazzini solidi e inamovibili; la manna non poteva essere raccolta in quantità maggiore a quella necessaria per un giorno, altrimenti marciva e si riempiva di vermi (Es 16,17-20); la terra non era proprietà di nessuno, ciascuno possedeva solo, per un momento, quella piccola superficie che calpestava, poi, quando muoveva in avanti il suo piede, quella terra non gli apparteneva più, diveniva proprietà di chi lo seguiva. In questo modo Dio aveva educato il suo popolo al distacco dai beni che, pur necessari alla vita, sono corruttibili e passeggeri, ma seducono, incantano e fanno distogliere lo sguardo dalla meta.
I rabbini notavano che gli israeliti avevano seguito Mosè nel deserto senza mai chiedergli: “Come potremo attraversare il deserto, senza portare con noi provvigioni per il viaggio”.
Gesù non condanna la programmazione, la previdenza, ma la preoccupazione per il domani, l’ansia che fa perdere la gioia di vivere e porta inevitabilmente ad accumulare e a trasformare in idoli disumanizzanti i beni di questo mondo.
Non affannatevi, non inquietatevi: sono verbi che nel brano di oggi vengono ripetuti per ben sei volte. Sono un’eco delle sagge riflessioni del Siracide: “Molti ne uccide la preoccupazione e non c’è utilità nell’affanno. La preoccupazione per il sostentamento fa perdere il sonno, lo allontana più di una malattia” (Sir 30,23-31,2).
L’affanno è comune tanto al povero quanto al ricco; il denaro non solo non elimina le inquietudini e le preoccupazioni, ma le acutizza e le esaspera. Conosciamo le notti insonni dei padri di famiglia disoccupati, senza soldi, con moglie e figli da mantenere; tuttavia sappiamo che le ansie non servono a nulla, non aiutano a risolvere i problemi del cibo e del vestito, sono un inutile dispendio di energie.
Gesù suggerisce il suo rimedio a questa malattia: sollevare lo sguardo verso l’alto, verso il Padre che sta nei cieli. Questo non significa rimanere con le mani in mano, ma affrontare la realtà con cuore nuovo. Alle parole di Gesù fa eco l’autore della Lettera agli ebrei: “La vostra condotta sia senza avarizia, accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: Non ti lascerò e non ti abbandonerò mai” (Eb 13,5).
Anche di fronte alle difficoltà più gravi, Gesù invita a mantenere la pace interiore perché la vita dell’uomo è nelle mani di Dio che non abbandona i suoi figli, li accompagna in ogni istante, benedice i loro sforzi ed il loro impegno.