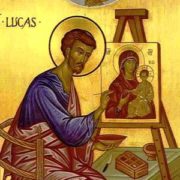“Vecchiaia veneranda non è la longevità, né si calcola dal numero degli anni. Divenuto caro a Dio, fu amato da lui e poiché viveva fra peccatori fu trasferito. Giunto in breve alla perfezione ha compiuto una lunga carriera. La sua anima fu gradita al Signore; perciò egli lo tolse in fretta da un ambiente malvagio” (Sap 4,8-14). Questa è la pagina, presa dal libro della Sapienza, che viene letta al funerale di un giovane.
Troviamo parole simili anche tra i pagani che ritenevano amato dagli dèi chi moriva giovane. Non confortano, non leniscono il dolore di una madre che ha perso il figlio.
Nella Bibbia i racconti di risurrezione riguardano sempre persone giovani. Ne abbiamo due esempi nelle letture di oggi. Cosa prova Dio di fronte a una vita stroncata “a metà dei suoi giorni” (Is 38,10)?
Gesù mostra i suoi sentimenti: si commuove. Non pronuncia parole di consolazione, non invita la madre a rassegnarsi, le ridona il figlio vivo.
Quando Dio “visita il suo popolo” (Lc 7,16) segna sempre il trionfo della vita, perché egli è “il Signore amante della vita” (Sap 11,26).
Sarebbe però ben fragile la sua vittoria se questa si riducesse alla rianimazione di un cadavere. Passati alcuni anni la morte tornerebbe a riprendersi la sua preda.
Dio restituisce ogni figlio alla madre e glielo ridà con una vita nuova, una vita non più soggetta alla morte. Il figlio non è rapito per lidi lontani – come pensavano i pagani e l’autore del libro della Sapienza – ma è collocato per sempre vicino, non ci lascia più, neppure un istante e la fede in Gesù risorto ce lo fa vedere.
Per interiorizzare il messaggio, ripeteremo:
“Hai mutato il mio lamento in danza, Signore, ti loderò per sempre”.
Prima Lettura (1 Re 17,17-24)
In quei giorni, 17 il figlio della vedova di Sarepta si ammalò. La sua malattia era molto grave, tanto che rimase senza respiro. 18 Essa allora disse a Elia: “Che c’è fra me e te, o uomo di Dio? Sei venuto da me per rinnovare il ricordo della mia iniquità e per uccidermi il figlio?”.
19 Elia le disse: “Dammi tuo figlio”. Glielo prese dal seno, lo portò al piano di sopra, dove abitava, e lo stese sul letto. 20 Quindi invocò il Signore: “Signore mio Dio, forse farai del male a questa vedova che mi ospita, tanto da farle morire il figlio?”. 21 Si distese tre volte sul bambino e invocò il Signore: “Signore Dio mio, l’anima del fanciullo torni nel suo corpo”. 22 Il Signore ascoltò il grido di Elia; l’anima del bambino tornò nel suo corpo e quegli riprese a vivere. 23 Elia prese il bambino, lo portò al piano terreno e lo consegnò alla madre. Elia disse: “Guarda! Tuo figlio vive”. 24 La donna disse a Elia: “Ora so che tu sei uomo di Dio e che la vera parola del Signore è sulla tua bocca”.
Un giorno il profeta Elia parte dalla sua terra e va a Sarepta, vicino a Sidone, dove viene benevolmente accolto da una vedova che gli offre ospitalità nella sua casa. Passano pochi giorni ed ecco che il figlio di questa signora si ammala gravemente e muore.
Una domanda angosciante tormenta la donna, la stessa domanda che anche oggi molti si pongono quando sono colpiti dalla sventura: cos’ho fatto di male? Perché Dio mi ha punito in questo modo?
La donna riflette, si interroga, si esamina e giunge alla conclusione che la colpa è dei peccati che ha commesso in gioventù. Rivolgendosi al profeta, dice: è la tua presenza nella mia casa che ha provocato la morte di mio figlio; è la tua santità che ha fatto ricordare al Signore le mie colpe (v.18).
Questa vedova tanto buona e generosa è afflitta per due ragioni: perché ha perso il figlio e perché si sente responsabile della sua morte.
Elia non le risponde. Le prende il bambino dal seno, lo porta al piano superiore, prega il Signore e gli comunica nuovamente il calore della vita. Poi scende e lo restituisce a sua madre.
Di fronte al bambino morto, Elia e la donna ragionano e si comportano in modo completamente diverso. In questa diversità va colto l’insegnamento principale dell’episodio.
La donna ha perso ogni speranza, si sente sconfitta, beffata dalla morte e l’unica cosa che sa fare è cercare un colpevole. Il suo tentativo di superare l’angoscia non fa altro che accrescere il suo dolore.
Il profeta invece capisce che la morte – anche quella drammatica di un figlio – è un evento naturale. Le malattie e le disgrazie sono fatti che accadono nel nostro mondo, sono dovuti alla casualità, alle coincidenze, a fattori biologici, non sono un castigo del Signore.
Dio dà la vita, non la morte ed Elia lo prova ridonando il figlio alla madre.
Seconda Lettura (Gal 1,11-19)
11 Vi dichiaro dunque, fratelli, che il Vangelo da me annunziato non è modellato sull’uomo; 12 infatti io non l’ho ricevuto né l’ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo.
13 Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo, come io perseguitassi fieramente la chiesa di Dio e la devastassi, 14 superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com’ero nel sostenere le tradizioni dei padri. 15 Ma quando colui che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia si compiacque 16 di rivelare a me suo Figlio perché lo annunziassi in mezzo ai pagani, subito, senza consultare nessun uomo, 17 senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco.
18 In seguito, dopo tre anni andai a Gerusalemme per consultare Cefa, e rimasi presso di lui quindici giorni; 19 degli apostoli non vidi nessun altro, se non Giacomo, il fratello del Signore.
“Troppo comoda la religione predicata oggi! – dice qualcuno – Parla di un Dio che non condanna nessuno e che salva tutti, insegna che siamo tutti fratelli, che dobbiamo condividere i beni, ma poi non si insiste, come si dovrebbe, su pratiche importanti come il rosario, le novene, la via crucis, le ore sante, le processioni, i digiuni e le mortificazioni… Per piacere agli uomini, per aumentare il numero dei simpatizzanti viene annunciato un Vangelo facile”.
Queste critiche – che oggi sentiamo rivolgere a qualche predicatore o a qualche catechista – sono le stesse che i mestatori che turbavano le comunità della Galazia muovevano a Paolo. Egli – dicevano – parla di Cristo, ma pone da parte i duri precetti imposti dalla tradizione.
Per difendersi da questa accusa, l’Apostolo afferma che egli non ha imparato dagli uomini il Vangelo che insegna: lo ha ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo (v.12). Non si deve pensare che egli abbia appreso in visione tutti gli insegnamenti e tutti i fatti della vita di Gesù, senza che nessuno glieli abbia mai raccontati. Con la parola Vangelo qui si intende la scelta di non imporre ai cristiani le norme dell’AT.
Paolo dichiara che non sono stati gli uomini, ma il Signore stesso a rivelargli che la salvezza non dipende dalla pratica delle norme dell’antica Legge, ma dalla fede in Gesù.
A conferma di questa sua affermazione, ricorda ai galati la storia della sua vita. Egli era un religioso fanatico, attaccato più di ogni altro alle tradizioni degli antichi e deciso a perseguitare coloro che le violavano. Il suo cambiamento radicale – spiegabile solo con una rivelazione dall’alto – è avvenuto perché si è comportato con lealtà, è stato aperto alla rivelazione di Dio e agli impulsi dello Spirito. Non è rimasto testardamente aggrappato alle sue convinzioni, ma ha accolto la novità del Vangelo.
Vangelo (Lc 7,11-17)
11 In seguito Gesù si recò in una città chiamata Nain e facevano la strada con lui i discepoli e grande folla.
12 Quando fu vicino alla porta della città, ecco che veniva portato al sepolcro un morto, figlio unico di madre vedova; e molta gente della città era con lei. 13 Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: “Non piangere!”. 14 E accostatosi toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: “Giovinetto, dico a te, alzati!”. 15 Il morto si levò a sedere e incominciò a parlare. Ed egli lo diede alla madre. 16 Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: “Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo”.
17 La fama di questi fatti si diffuse in tutta la Giudea e per tutta la regione.
Leggendo il racconto della risurrezione del figlio della vedova di Nain, è facile notare i numerosi particolari che questo episodio ha in comune con quello narrato nella prima lettura: ambedue i racconti parlano di una donna vedova che perde l’unico figlio e di un uomo di Dio che lo riporta in vita e lo riconsegna alla madre.
Più che le evidenti somiglianze, importa tuttavia rilevare alcune differenze significative: mentre Elia è solo un profeta e, per ottenere il miracolo, ha bisogno di invocare l’aiuto del Signore della vita, Gesù è più che un profeta, è lo stesso Signore della vita. Egli non ricorre a nessuno, attua con la forza prodigiosa che è presente in lui.
Il modo con cui Elia risuscita il figlio della vedova è diverso da quello di Gesù. Elia compie molti sforzi – ed Eliseo farà lo stesso con il figlio della donna di Sunem (2 Re 4,29-37). Gesù invece ridona la vita al giovane di Nain con la sola forza della sua parola.
Come siamo soliti fare, nella spiegazione del brano non ci soffermeremo tanto sul fatto in sé quanto sui messaggi teologici che Luca ci vuole proporre.
In un villaggio vicino a Nazaret muore il figlio unico di una donna che ha già perso anche il marito ed è rimasta sola, senza protezione e senza chi le sia si sostegno nella vecchiaia.
Nain deriva da na‘im che, in ebraico, significa delizioso. Un nome ben scelto per un villaggio adagiato sul fertile clivo di una montagna che, nell’antichità, era coperta da querce e terebinti, salici e tamerici. E’ – questo villaggio – il simbolo di tutti i luoghi ameni e ridenti dove la vita scorre spensierata e allegra, finché un giorno la gioia finisce, le feste si tramutano in lutti, i sorrisi in lacrime, i canti in lamenti.
Inarrestabile come un fiume, giunge a prendere tutti il corteo della morte: con violenza crudele strappa dalle case le persone care e le trascina verso l’ultimo destino.
Gesù, accompagnato dai discepoli e da una gran folla, giunge alla porta di questa città proprio nel momento in cui da essa sta uscendo molta gente che accompagna un morto al luogo della sepoltura. Sono due gruppi molto numerosi che si incontrano, che procedono in direzioni opposte: uno – guidato da Gesù – arriva, un altro – preceduto da un cadavere – esce. Difficile immaginare due situazioni più contrastanti: è un fiume di tristezza e di disperazione quello incontrato da Gesù.
Su Nain sta calando il buio della notte – è di sera che in Israele si portano i defunti al cimitero – e l’oscurità che avvolge la folla in lutto, è il simbolo della tenebra in cui sono immersi tutti coloro che non hanno ancora incontrato la luce di Cristo. Di fronte alla morte si sentono impotenti, si stringono l’un l’altro, sono uniti da un comune dolore e dal pensiero che un giorno quel corteo passerà a prendere anche loro.
A questo punto che entra in scena il Signore (v.13). Luca lo chiama così per la prima volta. Nell’AT questo titolo era riservato a Dio. Applicandolo a Gesù, l’evangelista lancia un messaggio teologico chiaro ai cristiani delle sue comunità: Gesù non è uno dei tanti profeti che hanno parlato e agito in nome di Dio, egli è il Dio della vita presente in mezzo agli uomini che si trovano in balia della morte.
Poi continua sottolineando la reazione umana del Signore: vedendo la vedova si commosse.
Il verbo greco impiegato – splagchnizein – indica un sentimento così vivo e così intenso che gli evangelisti lo riservano per indicare le emozioni di Dio e di Gesù. Il Signore non solo non è estraneo ai drammi e ai dolori dell’uomo, ma nessuno – sembra dire Luca – li sperimenta in modo intimo e profondo quanto lui. Egli comprende ciò che l’uomo prova quando la morte rompe i legami affettivi, segna il distacco drammatico dalle persone care, provoca solitudine, smarrimento e a volte anche disperazione. Capisce che, quando perde un amico, l’uomo sente una rivolta interiore e vorrebbe che Dio glielo restituisse.
Questa reazione e questo desiderio sono dettati dall’amore, ma non sono illuminati dalla fede. Se accondiscendesse a questa richiesta, Dio, riportando i defunti in questo mondo, li costringerebbe soltanto a ripetere l’esperienza della morte che finirebbe per avere comunque l’ultima parola.
La vittoria che il Signore ha riportato sulla morte non consiste nel ritardare di qualche anno l’uscita da questo mondo.
Egli ha vissuto l’esperienza umana fino in fondo, è passato attraverso il sepolcro, non per ritornare a questa vita, ma per entrare definitivamente in quella del Padre.
Il gesto da lui compiuto in favore del figlio della vedova è il segno di questo prodigio immensamente maggiore che egli compie per ogni uomo che muore.
Vediamo di cogliere il senso di quanto è accaduto quella sera a Nain.
La vedova è il simbolo dell’intera umanità triste, disperata. Il “Signore” sente compassione per lei, si fa avanti e le dice: “Smetti di piangere!”. Si accosta alla bara, la tocca e dice al morto: “Alzati!”, o meglio: risorgi! (vv.13-14).
Il suo gesto di toccare la bara provoca, secondo l’AT, una grande impurità (Cf. Nm 19,11.16) e l’impurità – insegnano i rabbini – è più contagiosa della santità. Un oggetto che è venuto in contatto con il lembo del mantello di un sacerdote non viene santificato, benché abbia toccato una persona santa; ma se il medesimo oggetto è sfiorato da un cadavere diviene immondo (Ag 2,12-13).
A Nain questa legge viene infranta. La purità di Gesù ha la meglio sulla impurità della morte, anzi, per il Signore la morte non ha nulla di immondo. Lavarsi, prendere delle misure igieniche è senz’altro saggio e doveroso.
Ma, se la morte è una nascita, se segna l’entrata nel mondo di Dio e l’inizio della festa, del banchetto di nozze nella casa del Padre, essa non può essere causa di alcuna forma di impurità. Per questo non c’è nulla da temere dalle persone morte, esse vivono con Dio e possono fare solo del bene a coloro che sono rimasti in questo mondo.
A volte Gesù cede all’insistenza di chi lo prega e compie un miracolo. Altre volte compie un prodigio perché è quasi costretto a farlo dalla grande fede delle persone bisognose che ricorrono a lui. A Nain egli compie il suo gesto e pronuncia la sua parola di salvezza senza aver ricevuto alcuna richiesta. Agisce in modo completamente gratuito e incondizionato, non presuppone nemmeno la fede. Si comporta così perché la risurrezione è un puro dono suo.
La sua parola provoca un capovolgimento della situazione: il giovinetto che era adagiato nella bara, avvolto in bende – simbolo dei legacci con i quali la morte lo teneva schiavo per sempre – ecco che si pone a sedere. E’ la posizione che caratterizza il vincitore. La assumerà, nel giorno di Pasqua, l’angelo che farà rotolar via la pietra dal sepolcro, vi si porrà a sedere sopra (Mt 28,2).
Di fronte alla vittoria di Cristo sulla morte il pianto si tramuta in canto di festa, il figlio viene riconsegnato alla madre, l’umanità esplode in un grido di gioia, tutti glorificano il Signore dicendo: “Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo!” (v.16).
E’ curiosa la ragione per cui le folle si meravigliano: non lodano Dio per il ritorno alla vita del ragazzo, ma per il fatto che il Signore ha fatto sorgere un profeta la cui parola sconfigge la morte.
Ecco il vero prodigio che, per mezzo di Cristo, Dio continua a compiere per ogni fratello che muore: lo riconsegna risorto alla madre, alla comunità. Non lo riporta nella condizione di vita effimera, caduca, breve di questo mondo, un mondo dove ci si ammala, si soffre, si invecchia, si sperimenta la solitudine e l’abbandono. Ridona alla madre un figlio risorto, libero, felice per sempre.
Il luogo in cui la comunità abbraccia i fratelli che il Signore riconsegna vivi per sempre non è il cimitero, ma il banchetto eucaristico. E’ lì che tutta la comunità si ritrova unita attorno al Risorto: alcuni fratelli sono già nella vita definitiva, altri sono in attesa che questa vita si manifesti in loro, ma tutti cantano insieme: “Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo” (v.16).
Le comunità cristiane sono chiamate a rendere nuovamente presente nel mondo il gesto di Gesù e la sua parola che fa risorgere. Deve ripetere ad ogni persona che piange accanto ad una bara ciò che il Maestro ha detto alla vedova di Nain: “Smetti di piangere!”, il Signore ha vinto la morte per sempre.
Accanto a questo messaggio centrale, Luca – l’evangelista dei poveri e dei bisognosi – vuole anche richiamare l’attenzione delle sue comunità su chi è rimasto solo.
Nella chiesa primitiva c’erano molte vedove che piangevano perché erano state abbandonate e nessuno si prendeva cura di loro (Cf. Gc 1,27). Luca dice ai cristiani: è necessario farle smettere di piangere; bisogna restituire loro i figli che hanno perso. Ogni membro della comunità deve considerarle come madri da amare, rispettare e accudire. Nessuna vedova deve sentirsi senza figli.