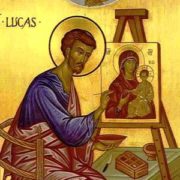A te ho presentato la mia causa
Dopo un capitolo programmatico (1,1-19) e la predicazione iniziale (2,1– ,30), il libro di Geremia (ca. 650 a.C. – 580 ca?) riporta i suoi primi interventi (7,1–10,25) sotto Yoyaqim (609-597 a.C.) e poi i suoi interventi in conflitto con il popolo sotto il regno di Yoyaqim (11,1–20,18).
Il brano letto nella liturgia fa parte della quinta e ultima delle “confessioni” di Geremia (20,7-18), brani in cui il profeta apre il suo cuore a YHWH per esprimere tutta la sua amarezza e lo sconforto per gli esiti scoraggianti della sua predicazione (cf. 11,18–12,6, 15,10-21; 17,14-18; 18,18-23; 20,7-18). Gli effetti della sua denuncia dei mali e idolatrie perpetrati dal popolo di Israele e dai suoi capi lo hanno portato alla solitudine, all’emarginazione e alla minaccia della sua soppressione violenta.
Il profeta si sente quasi “violentato”, sedotto con forza dal Signore (20,7) e tentato di smettere con la sua denuncia profetica. Ma il suo non è un mestiere. Lui non è un funzionario (come esorta spesso a non esserlo papa Francesco, parlando ai sacerdoti…) o un profeta di corte venduto ai potenti.
Geremia si sente accerchiato e guardato a vista anche dagli “amici/uomini della mia pace/’anšê šelômî”. Essi non aspettano altro che un suo passo falso per denunciarlo all’autorità religiosa e civile e sbarazzarsi con violenza di lui, mettendo fine alle sue denunce fastidiose quanto veritiere…
Geremia compie il gesto simbolico della brocca spezzata nella valle della Geenna, nel Tofet, cimitero e luogo dove sale in perpetuo il fumo dell’immondizia bruciata di Gerusalemme. È un’azione simbolica che annuncia plasticamente il destino inglorioso e fallimentare che Giuda e Gerusalemme dovranno affrontare andando in esilio a Babilonia (Ger 19,1–20,6).
All’interno del gesto vi è anche il violento alterco con Pascur (20,1-6), il sacerdote e sorvegliante capo nel tempio di YHWH, che lo mette immediatamente in ceppi in prigione. Liberato il giorno dopo, Geremia non ha paura di affrontarlo a viso aperto. Pascur sparge terrore all’intorno, ma sarà a sua volta oggetto di terrore, condannato all’esilio, alla spogliazione di tutti i propri beni e alla morte ingloriosa in terra straniera. Non soddisfatto di essere sacerdote, sorvegliante capo del tempio di YHWH, egli ha anche profetizzato “nella falsità”, ingannando il popolo e inducendolo all’idolatria (20,6).
A questo punto il libro di Geremia inserisce la sua ultima “confessione” desolata e sconfortata, il suo lamento (20,7-13).
Per amore di YHWH Geremia ha rinunciato a sposarsi (caso unico nell’Antico Testamento) e ha affrontato una vita ai margini del suo clan e della società intera (cf. 15,17 e tutta la terza “confessione”, 15,10-21). Ha dovuto annunciare che, attorno a sé, vedeva solo “violenza, oppressione” (20,8). La parola di Dio è diventata per lui causa di vergogna e di scherno da parte di tutti, tutti i giorni. Una realtà insostenibile.
Ma Geremia riconosce, nello stesso tempo, il fuoco violento della passione per Dio che arde nelle sue ossa, e che non può tenere dentro di sé il fuoco dell’annuncio della parola di Dio. «Ero stanco/nil’êtî (più che “mi sforzavo”, v. 9) di reprimere (lo) / non (vi) riuscivo» (tr. Lopasso).
Geremia è innamorato pazzo del suo Signore e ha solo una certezza ferrea che lo tiene in piedi: «Il Signore è con me come un guerriero temibile, perciò i miei persecutori non inciamperanno, non prevarranno» (v. 11) e saranno loro a essere coperti di vergogna perenne, che non verrà dimenticata.
Il lamento di Geremia si fa ora preghiera accorata a YHWH degli eserciti, a colui che esamina il giusto, che vede l’intimo (lett. “le reni/kelāyôt) e la mente (lett. “il cuore/lēb”). Solo YHWH può dirimere la lite giudiziaria (rîb – la mia lite giudiziaria/rîbî) – lite bilaterale e non giudizio triangolare – nella quale Geremia fa corpo unico con la parte lesa – YHWH – contro la falsità dei nemici, pur sacerdoti, profeti e “amici” che siano…
E Geremia torna a ripetere – con perfetta inclusione – le stesse parole espresse nella prima “confessione” (11,20): «Voglio vedere la tua vendetta contro di loro, / perché a te ho presentato la mia causa” (tr. Lopasso). Geremia si sbarazza della tentazione di farsi vendetta da solo, con l’omicidio o altri mezzi. Toglie il peso dal suo cuore e lo mette nel cuore di Dio. La sua “vendetta” sarà “giusta”. YHWH saprà ristabilire la verità delle cose, non necessariamente uccidendo le persone o punendole direttamente.
Il corso della storia dirà chi avrà avuto ragione e farà emergere le buone ragioni di Geremia, la sua “giustizia”, la sua fedeltà a YHWH, anche nel pesante e ingrato compito di dover continuamente rimproverare il suo popolo di infedeltà religiosa e di violenza sociale.
Affidare “il nemico” a Dio è il primo passo per evitare e superare la pura legge del taglione, primo argine alla vendetta privata e alla violenza spropositata. Geremia affida a YHWH la sua vita, la verità del suo agire, il destino dei suoi violenti interlocutori. In fondo, Geremia “prega” per i suoi nemici” e, affidandoli a Dio, fa il primo passo verso l’“amore dei nemici” chiesto da Gesù nel vangelo (cf. Lc 27-28).
Geremia grida la Parola, ma non invoca la vendetta privata. Chiede a YHWH che sveli a tutti i cuori la verità delle cose, apra gli occhi di coloro che non vedono la rovina verso la quale stanno trascinando il popolo intero. La “vendetta” di YHWH sarà il ristabilimento della verità e della “giustizia”, riportare tutti cioè al patto di allenza che li lega al loro Signore. La vendetta di Dio sarà il suo “perdono riconciliatore e redentore/espiatore/bekāpperî lāk” (cf. Ez 16,59-63; 20,42-44). Geremia è certo che Dio farà vincere la causa del giusto, lo dà per avvenuto (perfetto profetico?) e invita tutti alla preghiera per il povero (ma anche per i malvagi…) (v. 13).
Annunciate dalle terrazze
 «Colui che è, che era e che viene»(Ap 1,4) è anche l’«Io Sono il Primo e l’Ultimo» (Ap 1,7). Gesù risorto è l’antico e il nuovo, è l’Ultimo che viene prima. Lui è il “passaggio” tra Antico e Nuovo Testamento. Egli è colui che, in persona, li riassume e li riesprime facendoli integrare nell’eccedenza della realizzazione rispetto alle promesse stesse di Dio. Dio è semper maior, anche rispetto a se stesso, e le categorie di “promessa” e di “compimento” vanno integrate con quelle di “anticipazione”. Ma, in fondo, sono categorie, differenziazioni o progressioni temporali che sono soltanto relative (cf. M. Naro, Le vergini annunciate. La teologia dipinta di Antonello da Messina, EDB, Bologna 2017, pp. 57-62).
«Colui che è, che era e che viene»(Ap 1,4) è anche l’«Io Sono il Primo e l’Ultimo» (Ap 1,7). Gesù risorto è l’antico e il nuovo, è l’Ultimo che viene prima. Lui è il “passaggio” tra Antico e Nuovo Testamento. Egli è colui che, in persona, li riassume e li riesprime facendoli integrare nell’eccedenza della realizzazione rispetto alle promesse stesse di Dio. Dio è semper maior, anche rispetto a se stesso, e le categorie di “promessa” e di “compimento” vanno integrate con quelle di “anticipazione”. Ma, in fondo, sono categorie, differenziazioni o progressioni temporali che sono soltanto relative (cf. M. Naro, Le vergini annunciate. La teologia dipinta di Antonello da Messina, EDB, Bologna 2017, pp. 57-62).
Gesù sovraeccede nel compimento la promesse di YHWH, ma anche la sua opera è solo l’inizio del compimento, anticipo della pienezza definitiva, escatologica. Antico e Nuovo Testamento si intersecano in dialogo strettissimo, di illuminazione e di “presenza” reciproca l’uno all’altro. La vita e il destino di Geremia sono “ripresi” nella persona e nel compito dei discepoli di Gesù.
YHWH si “vendica” dell’infedeltà del suo popolo inviando il suo Figlio, il Verbo incarnato, ad assumere tutte le ferite dei popoli e sanarle riportando tutti alla riconciliazione filiale con il Padre.
Dopo il racconto di dieci “miracoli/potenze/dynameis” (Mt 8–9), l’evangelista Matteo riporta il secondo dei cinque grandi discorsi presenti nel suo scritto, il Discorso missionario (Mt 10).
Dopo aver chiamato i primi quattro discepoli (Mt 4,18-22), ora improvvisamente “chiama a sé” in elezione dodici fra i suoi discepoli per inviarli in missione di annuncio della Parola e di guarigione degli infermi da ogni tipo di malattia. Indica loro le linee essenziali dell’annuncio, ma annuncia loro chiaramente anche le difficoltà e i rifiuti che incontreranno, tradimenti da parte perfino dei parenti (come accadde proprio a Geremia).
Gesù invia i Dodici nella loro missione pre-pasquale, limitata per ora alla raccolta di Israele, alla ricerca e al raduno delle «pecore perdute della casa di Israele» (10,6). Niente missione ai samaritani e ai pagani, per ora. Verrà in seguito il tempo della missione pasquale universale, nella potenza del Risorto sempre presente nella sua comunità (cf. Mt 28,16-20).
Gesù incide nel particolare per giungere poi all’universale. L’elezione inclusiva e la raccolta di Israele è in funzione della raccolta di tutti i popoli nella famiglia di Dio. «Non temete», ripete Gesù per ben tre volte nel brano letto nella liturgia (vv. 26.28.31). Nell’annuncio non bisogna temere gli uomini, prolungando esattamente il comportamento di Geremia. Ciò che è stato ricevuto da Gesù nell’intimità del discepolato, deve ora essere ora annunciato chiaramente e apertamente. Dall’alto delle terrazze deve scendere come pioggia che feconda la terra dei cuori degli uomini.
Gli apostoli annunceranno, ma la “rivelazione” – nella sua realizzazione completa – non potrà che essere opera di Dio che tocca “le reni e il cuore/l’intimo e la mente” (cf. Ger 20,12). “Sarà rivelato” sembra esprimere un passivum divinum, che allude al protagonista principale dell’annuncio e della sua fecondità.
Non bisogna temere chi uccide la vita umana (“il corpo”), preziosissima ma penultima – e tanti fratelli cristiani e uomini di varie religioni, “veri” “martiri” in Africa e in Medio Oriente, in questo tempo lo testimoniano alla lettera… Va onorato con ossequio religioso, invece, colui che ha potere sulla vita vera, profonda (“l’anima”), che abbraccia la vita fisica vissuta integralmente alla luce della fede, della carità della grazia divina.
Il discepolo che annuncia fa corpo unico con la parola divina che lo possiede dal battesimo, e testimonia con “delicatezza d’animo/dolcezza (meta prautētos)” e “rispetto/phobou” (1Pt 3,15-16), con “amabilità/epieikes” (Fil 4,5).
Il Padre ha cura dei discepoli di Gesù, come e più di tutte le altre sue creature che popolano la faccia della terra. Annunciare il Vangelo è annunciare Gesù. È “riconoscere/confessare/homologein” Gesù per quello che è, il Figlio di Dio amante degli uomini, il Salvatore del mondo (cf. Gv 4,42). Confessare Gesù nella vita e nella lode, nella preghiera e nella persona del povero. Confessare e non rinnegare la sorgente del fuoco interiore che muove il discepolo di Gesù, il “cristiano”.
Potremo, purtroppo, rinnegarlo “per rispetto umano”, affermare di non conoscerlo (cf., dolorosamente, Pietro in Mt 26,70.72), vergognarci di lui, vivere come se lui non esistesse e non avesse dato la sua vita per noi. Gesù prenderà atto del nostro venir meno, ma da parte sua rimarrà “fedele/pistos” nella nostra infedeltà «perché non può rinnegare se stesso» (2Tm 2,12).
Questo è il terreno solido che mantiene custodita la nostra professione di fede, ci rassicura oltre i rimproveri del nostro stesso cuore (cf. 1Gv 3,19-20) e che riaccende ancora più forte in noi il fuoco ardente del suo amore (cf. Ger 20,9).