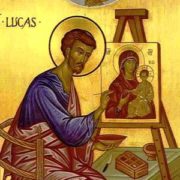Dopo il racconto dell’uscita dall’Egitto (Es 1,1 – 15,21), comprendente la descrizione della schiavitù e della missione di Mosè (1,1 – 10,29), il racconto della Pasqua (11,1 – 13,16) e l’evento del Mar Rosso (13,17 – 15,21), nella seconda parte (15,22 – 18,27) il testo si sofferma sulla sfida del deserto. Dopo aver ricordato la protesta del popolo a Mara (15,22-27) e prima di descrivere quella avvenuta a Massa e Meriba (17,1-7), l’autore del libro ricorda il dono della manna e delle quaglie (16,1-36). Anche in questa riflessione ci avvaliamo del valente commentario all’Esodo approntato dal biblista piemontese Michelangelo Priotto (Bagnolo Piemonte [CN] 18/11/1945) docente allo Studio teologico Interdiocesano di Fossano (CN).
Mormorò
L’autore raccoglie qui la ricca meditazione della tradizione che ricordava come, dopo quella della sete, il popolo si trovi ad affrontare l’altro grande nemico del deserto: la fame. Il 15 giorno del secondo mese dall’uscita dall’Egitto, “tutta la comunità dei figli di Israele/kol-‘ădat benê Yiśrā’ēl” si trova nel deserto di Sin. La localizzazione è incerta anche per l’assonanza fra le varie denominazioni: sîn/sînay (Sinai), sîn/ṣîn (Zin). Spesso il deserto di Sin è stato identificato con la distesa di sabbia detta Debbet er-Ramleh (dune di sabbia), tra Serabit el-Khadim e le propaggini dell’altopiano di Tih. Ma l’itinerario della comunità più teologico che geografico. Le date ricordate, l’espressione liturgica “comunità degli israeliti”, le riflessioni sul sabato, sulla manna e la sua conservazione liturgica mostrano come il redattore sacerdotale intenda ricordare soprattutto il protagonista della storia: la presenza di YHWH fra il suo popolo. Alla luce della liturgia, egli sta rivivendo l’epopea di liberazione di Israele, ricordando l’evento del liberazione con un ritmo che segue il calendario liturgico e che ha visto celebrazioni in vari luoghi ben determinati.
La comunità (liturgica) degli israeliti giunge al deserto di Sin un mese esatto prima della celebrazione della Pasqua, il 15 del secondo mese (= adar). In modo compatto celebra però una liturgia laica di mormorazione (wayyallînû/wayyallō[ô]nû < lûn/lîn). I destinatari delle critiche sono le due guide visibili del cammino, i fratelli Mosè e Aronne. Dopo Es 12,50, ricompare anche Aronne, probabilmente perché connesso al clima sacerdotale del brano, incentrato sulla manna e al sua conservazione. Il bersaglio ultimo della mormorazione è però la guida invisibile, YHWH. Egli non è manipolabile; è oggetto di pura fede, sostenuta però da segni concreti di amore e di interesse concreto per il suo popolo.
Il popolo celebra una liturgia laica antiesodica, che torna all’indietro non per magnificare e rendere presente una liberazione, ma per rivivere con nostalgia i pasti assicurati, pur in regime di schiavitù. YHWH è ricordato com un sospirato agente che avrebbe dovuto dare la morte anziché permettere che i suoi rappresentanti conducessero il popolo allo stesso risultato facendo patire inutilmente le pene dell’inferno e differendo solamente nel tempo lo stesso risultato finale.
Il popolo ha appena vissuto e cantato l’epopea del passaggio del mar Rosso (Es 14,5 – 15,21), eppure già rimpiange la schiavitù, pur senza nominarla. Celebrazione laica di morte, celebrazione negatrice della libertà, avvitamento smemorato e ingrato sulle sicurezze umane, senza la percezione della schiavitù che inquina e avvelena tutto con la mancanza di libertà, di dignità, della coscienza acquisita nel cammino di essere il popolo scelto da YHWH come sua “proprietà particolare/segullāh” (cf. Es 19,5; Dt 14,2) sulla terra che tutta appartiene a lui. Delle tre dimensioni di cui vive l’uomo e la comunità, celebrate e rese presenti nella liturgia, gli israeliti amputano la profondità del presente e l’insondabile ma sicura prospettiva contenuta nel futuro. Del passato si ricordano solo i pasti (nella schiavitù), del presente si vede solo la povertà della crosta superficiale (ignorando la profondità della libertà acquisita), il futuro nemmeno è menzionato, mentre la spinta dinamica della speranza dovrebbe essere invece sempre la molla che sostiene e spinge in avanti il cammino di ogni uomo e di un popolo intero. Memoria avvelenata, memoria monca e ingrata. Memoria di “pancia” scollegata dal cervello. La sazietà in Egitto faceva dimenticare la schiavitù, appiattiva sul presente senza orizzonti liberanti di futuro.
Pioggia di pane
“Eccomi/hinenî” ribatte YHWH al suo agente in campo Mosè, eccomi a “far piovere/mamṭîr”, dopo la grandine punitrice dal cielo (9,18.23), anche del pane di vita per il popolo affamato e senza fede. Mangiavano pane di schiavitù (v. 3), mangeranno un pane sconosciuto agli uomini (cf. Dt 8,3), che viene direttamente dal mondo provvidenziale di Dio. Farò piovere pane, avranno pioggia che nutre, pane e acqua assicurati, vita certa nel deserto. “Colui che cammina nella giustizia e parla con lealtà, che rifiuta un guadagno frutto di oppressione, scuote le mani per non prendere doni di corruzione, si tura le orecchie per non ascoltare proposte sanguinarie e chiude gli occhi per non essere attratto dal male: costui abiterà in alto, fortezze sulle rocce saranno il suo rifugio, gli sarà dato il pane, avrà l’acqua assicurata. (Is 33,15-17).
Lākem laḥem, per voi pane. È l’amore personalizzato e sollecito di YHWH, che da Mosè rivolge la parola direttamente agli israeliti ingrati e sfiduciati.
L’amore di YHWH è presente, gratuito verso gli ingrati, indiscriminato verso cattivi e giusti (cf. Mt 5,45), misericordioso verso i recriminatori, memore verso gli immemori. Gli israeliti tornano a compiere il peccato originale, il peccato di sempre: “dimenticare/šākaḥ”. La riflessione dell’autore è teologica, non un resoconto cronachistico. E il peccato divora ciò che sta sotto la crosta dell’apparire. La mormorazione corrode i rapporti, rovina la relazione di alleanza, con l’amore preveniente e asimmetrico che lega YHWH agli israeliti
La prova
Il primo dei due comandi dato da YHWH è quello di “spigolare/raccogliere/lāqaṭ (e non qābaṣ)” (il verbo tornerà 9 volte nel capitolo). Gli israeliti spigoleranno come i poveri difesi dal diritto di YHWH nel racimolare i resti della mietitura (cf. Lv 19,9; 23,22; Rt 2,2.3.7.8.15.16.19.23). Spigoleranno giorno per giorno il dono “dall’immenso campo di grano del cielo” (M. Priotto). Dovranno spigolare come poveri che dipendono dal dono immeritato. Porranno un limite alla loro voracità e allo spirito di accumulo accaparratore egoistico e incredulo nei confronti della presenza quotidiana provvidente di YHWH. La vita nasce non dall’accumulo, ma dall’accoglienza di un dono. La logica vincente della pace deriva dall’accoglienza del gratuito, non dalla pianificazione ragionieristica dell’accaparramento prometeico. Io vivo grazie al dono dell’altro, dal dono del suo sguardo, dalla luce dei suoi occhi, dal perdono delle sue lacrime. Deve essere sradicato anche l’altro peccato originale, quello di voler mangiare e arraffare tutto, senza lasciar spazio all’altro e al mistero. Questo il peccato della prima umanità e di quella di sempre.
Questa è la prova a cui YHWH sottoporrà gli israeliti (’ănaśśennû). In questo modo egli potrà non tanto provocare il male della fame per vederne gli effetti nel popolo, ma “testare” la loro dipendenza dal dono e l’osservanza del sabato, in cui non si potrà spigolare, avendo raccolto una doppia razione doppia il venerdì. L’osservanza del sabato sta a cuore al redattore sacerdotale. Essa è segno dell’imitazione di YHWH che riposò al settimo giorno (cf. Gen 2,2-3), chiamando l’umanità a essere sua immagine e somiglianza nel riposo filiale che partecipa dell’esistenza “gratuita” di YHWH e della gioia che dà la sua esistenza celebrata nella comunità. Figli che riposano liberi. Figli senza ossessione. Gratuitamente hanno ricevuto il dono del pane (pur col lavoro che esalta la dignità dell’uomo). Nella gratuità celebreranno la festa del Donatore e della comunità dei suoi figli.
Manna e quaglie
YHWH ha ascoltato le “mormorazioni/telunnôt” degli israeliti. Egli è il Dio dell’esodo, che ha osservato, ha ascoltato e conosce le sofferenze del suo popolo ed è sceso per liberalo (cf. Es 3, 7.8). Il popolo sperimenterà l’essere pro-esistente del suo Dio godendo del pane e della carne grazie al fenomeno provvidenziale (non “miracolo contro natura”) che appare allo svanire della rugiada mattutina. Una rugiada di pane, coriandoli commestibili. Pane che piove dal cielo di Dio. “La manna proviene dalla secrezione di due insetti parassiti (trebutina mannipara e najacoccus serpentinus) di una pianta, la tamarix mannifera, che cresce nella zona centrale del Sinai. Si tratta di una sostanza resinosa, di sapore dolciastro, che si forma sui rami come goccia di rugiada, si scioglie al calore del sole e poi cade a terra, da dove viene setacciata e fatta seccare; i beduini della zona se ne servono come di un pane (cfr. G. Boschi, Esodo, pp. 164-165”) (M. Priotto). L’autore “ne dà un’etimologia popolare, che corrisponde alla domanda spontanea che sorge negli israeliti di fronte a un elemento sconosciuto: ‘Che cosa è quello [/mān hû’]?’” (M. Priotto). Il dono provvidenziale fornito dalla natura che si esprime nel deserto va letto a un livello più profondo: è segno di un Dio creatore che offe in cibo all’uomo i frutti della terra (cf. Gen 1,29). Così sarà del dono delle quaglie, che cadono sfinite dal vento contrario che soffia a scadenze regolari nella zona mentre sono in viaggio per trasmigrare verso nord. “Questo è il pane che diede YHWH a voi come cibo/leḥem ’ăšer nātan YHWH lākem leoklāh”, interpreta l’evento Mosè, l’agente plenipotenziario di YHWH. Un’indigestione di l e di ḥ si potrebbe dire…
Pane povero, pane dei poveri. Pane essenziale, pane donato.
Pane dal cielo, pane degli angeli (cf. Sal 78[77],24-25: “fece piovere su di loro la manna per cibo e diede loro pane [lett. “grano”] del cielo: l’uomo mangiò il pane dei forti [gr. LXX: “pane di angeli (aggelōn) mangiò l’uomo”]; diede loro cibo in abbondanza [lett. “provvista a sazietà]”.
Pane del Donatore.
Pane di YHWH, di “Colui-che-è-in-quanto-è-vicino-a-te-per-salvarti” (cf. Es 3,14).
Il cibo che rimane
Alla folla, massa indistinta di persone che a Tabgha/Magadan avevano preso parte e goduto del grande segno della “moltiplicazione” dei pani, si aggiungono altre persone su “barchette/ploiaria” giunte dalla vicina Tiberiade. Tutti insieme si dirigono a nord-est, verso la vicina Cafarnao, distante solo alcune insenature delle lago. La gente ha visto una sola barca rimasta, e una partita con i discepoli di Gesù, ma senza di lui. Tutti si “pongono alla ricerca/zētountes” di Gesù. Da dove egli venga, chi sia, dove vada è il grande mistero che attraversa tutto il Vangelo di Giovanni. Per questo motivo Gesù compie dei “segni/sēmeia”, di cui Giovanni ne riporta solamente sette.
Dopo “il segno del pane” Giovanni fa seguire un lungo “discorso sul pane” (Gv 6,22-59), che però di fatto è un “dialogo sul pane” fra Gesù e la folla e, in seguito con “i giudei”. Sei domande (vv. 25.28.30-31.42.52) costellano il “discorso”, articolando il dialogo in diversi quadri discorsivi.
Con una solenne dichiarazione che introduce un’affermazione decisiva per gli ascoltatori, “Amen, Amen” – non pronunciata come al solito dai giudei alla fine di un discorso per avvalorarne il contenuto, ma all’inizio, per sottolinearne il suo valore rivelativo – Gesù illumina con carità ma anche con la rudezza della verità, la radice errata della ricerca della gente. Il segno della “moltiplicazione” dei pani avrebbe dovuto essere un trampolino di lancio per andare oltre la superficie, e dal significante giungere al significato. La gente si è fermata al segno del cibo che nutre materialmente la vita, calmando provvisoriamente i bisogni impellenti relativi alla conservazione della vita umana, breve e precaria. Calmati i sogni della “pancia” la gente aveva cercato di crearsi un “re” che desse sempre ai suoi sudditi panem et circenses (cf. Gv 6,15).
Gesù invita a “darsi da fare/lavorare/operare/ergazeste” che non si ferma alla superficie, ma un “fare” che giunge alla profondità del reale. Il pane “che perisce/apollymenēn” non è la realtà a cui fermarsi. Ad esso Gesù contrappone il cibo “che rimane/menousan” per la vita eterna. Esso infatti sarà dato dal Figlio dell’uomo, colui che è disceso dla cielo, dal Padre, per dare “il pane dal cielo”. Gesù, Figlio dell’Uomo, lo darà in futuro (futuro modale) a chi crederà in lui (cf. 6,29)? Lo darà in futuro (futuro cronologico), dopo il compimento della rivelazione sulla croce e alla scadenza pasquale, legato all’effusione dello Spirito e all’eucaristia? “Non è saggio irrigidire l’alternativa tra queste due ipotesi, dato che il linguaggio metaforico utilizzato lascia spazio a entrame le letture” (J. Zumstein).
Il Figlio dell’uomo può dare il pane che rimane perché in precedenza ha Dio – cioè il Padre – “ha impresso il suo sigillo/esphragisen” in un momento ben preciso: ha accreditato il suo inviato non tanto nel momento del dono dello Spirito al battesimo (1,32-34), quanto in un passato antecedente alla discesa/catabasi. È “il Figlio dell’Uomo” infatti a donarlo.
Operare per il cibo che rimane
La folla cade in un secondo fraintendimento, che da l’occasione a Gesù di precisare meglio il suo discorso e approfondire la sua rivelazione. La folla intende “l’operare/darsi da fare/ergazesthai” in vista del “pane/cibo che rimane” proveniente da Dio come un semplice “fare/poiein” una qualche opera religiosa fra le altre. Il “cibo che rimane” invece, è un dono che si riceve impostando la propria vita sulla lunghezza d’onda del piano concreto di Dio. È un operare per diventare ricettivi dell’unica “opera di Dio/ergon tou theou”: credere nel suo inviato. È un’opera compiuta verso Dio, adottando un comportamento corrispondente alla sua volontà (genitivo oggettivo)? Oppure è l’unica opera che conta, che Dio compie nell’uomo portandolo alla fede, aprendo il cuore del credente ad accettare il suo inviato, il Rivelatore del Padre (genitivo soggettivo). Propendo per la seconda ipotesi.
Mosè o il Padre?
La folla ritorna alla carica con una terza domanda (v. 30-31). Non chiede più cosa essa debba “operare”, ma quale segno/sēmeion” Gesù “opera/ergazēi” perché possano credergli.
È una domanda equivoca: potrebbe esprimere la disponibilità a credere dopo aver visto un segno che funga da trampolino di lancio. Ma il segno lo hanno già visto (o è stato loro raccontato da chi l’ha visto) poco tempo prima! Si sono appena saziati e volevano far re Gesù… Spesso la gente ha la memoria corta, il che è fonte di molti guai e tragedie di ogni tipo…
Potrebbe essere invece una domanda che esprime incredulità. Non occorre vedere per credere, dirà infatti Gesù a Tommaso nella sua beatitudine otto giorni dopo la Pasqua (cf. Gv 20,29).
La folla ricorda a Gesù anche il fatto che i loro padri nel deserto mangiarono la manna, perché (Mosè, nella loro interpretazione, rapportata alla figura storica di Gesù) “diede loro da mangiare un pane da cielo” (Es 16,15; Nm 9,15).
Gesù rivela solennemente (“Amen, Amen”) il suo pensiero, una vera e propria ermeneutica alternativa dei fatti dell’esodo espressa dalla folla, rapportando il dono della manna a quello del pane abbondante da lui procurato poco prima.
Gesù fa quattro precisazioni: 1) Chi ha donato il pane è stato Dio e non Mosè (cf. 1,17); 2) Il dono del pane non è avvenuto nel passato (dedōken), ma avviene ora: il Padre “dà/didōsin” (ora) il pane; 3) Gesù parla del pane “vero/alethinos” venuto dal cielo; 4) I destinatari del dono non sono gli antenati della folla, ma la folla stessa, loro stessi (hymin).
Il pane genuino della vita
Il pane non è solo “dal cielo” (v. 32), ma è “il pane di Dio”. Il pane “che discende dal cielo” allude all’origine divina del Figlio dell’uomo e alla sua venuta nel mondo. Questo pane ha due caratteristiche: è “verace, genuino/alethinos” e per questo “dona (in continuità) la vita pregna (divina/teologica)/didous … tēn zōēn” (non la semplice “vita biologica/ho bios”).
È un pane dalla valenza salvifica. La sua tipologia allude alla venuta del Figlio dell’uomo nel mondo che ha per scopo il dono della vita divina ad esso. “Il mondo/ho kosmos”, in questo frangente, indica l’insieme della creazione e degli uomini, figli di Dio/tekna tou teou. Non sarà solo Israele a beneficiare di questo pane, ma il mondo intero.
È la soteriologia giovannea a venir qui espressa. Gesù aveva ricordato ai giudei nella polemica seguita alla guarigione del paralitico alla piscina di Betzatà: “Come il Padre risuscita i morti e dà la vita [zōiopoiei], così anche il Figlio dà la vita [zōiopoiei] a chi egli vuole” (Gv 5,21).
Puntuale arriva la quarta domanda da parte dei giudei: “Signore ‘dacci/dos hēmin’ (imperat. aoristo) sempre questo pane”. Inizia a compiere questa azione precisa e non altre: “dona”, “a noi personalmente”, “sempre”, “questo pane” verace, e nessun altro.
Io sono il pane della vita
La risposta di Gesù è pronta. Egli rivela con chiarezza che il dono si identifica col Donatore. “Il pane della vita/ho artos tēs zōēs”, il pane che è e che dà la vita piena, è Gesù in persona. Identificare col verbo “essere” realtà appartenenti a due campi semantici diversi significa introdurre una semantica simbolica complessa. Gesù non è pane, ma a lui viene trasferito la caratteristica del pane quale nutrimento che dona la vita. Con un altro trasferimento di significato, Gesù insegna che “la vita non dipende più dall’acquisizione di un bene materiale ma dall’incontro con una persona ben definita, il Gesù giovanneo” (J. Zumstein). Per avere la vita piena occorre “andare a lui/ho erchomenos pros eme”, in un cammino dinamico che per Giovanni esprime la fede in Gesù. Gesù istituisce un “parallelismo a gradini” tra il non aver più fame e il non aver mai più sete. In questo modo nella seconda parte del parallelismo viene espressa la corrispondenza tra “venire verso di me/erchomai pros eme” e il “credere in me/pisteuein eis eme”.
Gesù-pane va creduto, prima che mangiato.
La sua parola è pane, rivelazione piena del Padre.
Un pane da cui andare, un pane in cui credere.