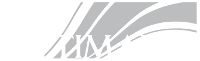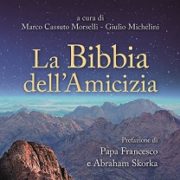Alberto Mello, monaco di Bose, esperto della letteratura e della spiritualità del mondo ebraico, pubblica la traduzione del midrash Avot di Rabbi Natan, corredando il testo di articolazioni in paragrafi titolati e di note esplicative a piè di pagina. Riassumiamo brevemente la sua introduzione al volume (pp. 5-30).
Pirqè Avot (“I detti dei Padri”) è uno dei 63 trattati che compongono la Mishnà, la messa per iscritto (più o meno ufficialmente) della Torah orale che era venuta a formarsi al termine del II secolo d.C.
Pur essendo l’unico libro della Mishnà a non aver ricevuto un commento esplicito nel Talmud, ricevette numerose integrazioni e aggiunte (Tosafot). Esse furono opera di una comunità di commentatori, ma furono editate attribuendole a un maestro del II secolo, Rabbi Natan. Questi era un maestro babilonese appartenente alla quarta o quinta generazione, ossia un contemporaneo di Rabbi Jehudà e con lui segna la fine dell’epoca mishnica.
La sua opera passa in rassegna gli stessi maestri tannaiti di Pirqè Avot, escludendone solo il capitolo sesto, su «l’acquisizione della Torà», che è un’aggiunta posteriore, a scopo liturgico.
Avot di Rabbi Natan è un’opera collettiva e Rabbi Natan, a cui è attribuita, non è altro che uno dei primi maestri menzionati dal testo, esattamente il terzo. Il titolo che si dà a questa Tosefta di Avot è per Mello meramente convenzionale (cf. p. 18).
Di Avot di Rabbi Natan (ARN) esistono due versioni. Quella tradizionale (ARNA) è quella più lunga, ed è quella tradotta da Mello. La versione B (ARNB) è più breve. Secondo lo studioso, si tratta di due stadi successivi di redazione scritta e il testo B è considerato il più antico, anche se meno autorevole. Ciascuna versione ha vario materiale proprio e versioni diverse dello stesso testo.
ARN ingloba i detti di Pirqè Avot ma li arricchisce di altre massime che sono profondamente innovative rispetto al trattato mishnico. Comprende anche varie digressioni storiche, paraboliche e narrative, come l’importante midrash della Genesi e della creazione dell’uomo con cui inizia il testo: Adamo, Eva e l’empio serpente che è considerato come il vero responsabile del peccato cosiddetto originale.
La vita del mondo
Di sabato, in sinagoga si recita questa benedizione: «Benedetto sei tu, Signore Dio nostro, re del mondo, che ci hai dato una legge di verità e hai piantato dentro di noi “la vita eterna” (hajjè ‘olam)».
Mello fa notare che il termine ebraico ‘olam è ambivalente. Deriva da una radice che significa “nascondere”, “occultare” e si riferisce, in prima istanza, al tempo che ci rimane quasi nascosto. Me’olam we-’ad ‘olam, «dal tempo passato al tempo futuro», significa, in pratica, «da sempre e per sempre». Perciò hajjè ‘olam è la vita eterna.
In ebraico rabbinico, il termine ‘olam assume anche un valore spaziale e diventa anche quello che per noi è il “mondo”. L’amore di Dio «per sempre» viene a significare che il suo amore è «per il mondo»; una «gioia eterna» diventa la «gioia del mondo» e, analogamente, la «vita eterna» diventa anche la «vita del mondo».
Nella mistica ebraica esistono però molti “mondi”: mondi infiniti, perché praticamente incalcolabili. Nell’opera L’anima della vita (Nefeš ha-ḥajjim, pubblicata da Qiqajon nel 2016) di Rabbi Ḥajjim di Volozhin, che Mello considera la migliore introduzione alla mistica ebraica, l’uomo è creato da Dio quale responsabile di tutto l’edificio della creazione. Qualcosa impegna l’uomo più ancora della salvezza della sua anima.
L’essere «anima della vita» – potremmo dire anche anima mundi – è la capacità di migliorare, restaurare, riparare il mondo, ed è in questo che consiste la vera immagine e somiglianza di Dio, ossia l’esercizio della paternità o maternità da parte degli esseri umani.
I «Padri del mondo»
I «Padri del mondo» nella Bibbia sono Abramo, Isacco e Giacobbe. Nella Mishnà sono i capostipiti delle due scuole rivali di Hillel e Shammaj, che stanno all’origine della tradizione rabbinica.
Quando Rabban Jochanan ben Zakkai insieme ai rabbini si ritrovarono a Javne per ricostruire la «vita del mondo» dopo la distruzione del tempio di Gerusalemme, essi iniziarono proprio da queste due scuole, dalle opinioni contrastanti di Hillel e Shammaj.
Finirono per ritrovarsi d’accordo con la scuola meno intransigente, meno rigorista, cioè con «la casa di Hillel», senza censurare con questo le opinioni minoritarie di bet Shammaj («casa di Shammaj»), sentenziando che «queste e quelle sono parole del Dio vivente».
Per estensione, «Padri del mondo» sono tutti i maestri tannaiti, i protagonisti della Mishnà che vengono espressamente menzionati nel trattato che si intitola appunto Avot, i «Padri».
Esso si presenta come un trattato, l’unico a contenuto non legale di tutta la Mishnà, che è una sorta di storia della tradizione rabbinica, della catena di trasmissione della Torà orale da Mosè a Giosuè, da Giosuè agli anziani, dagli anziani ai profeti e dai profeti postesilici agli uomini della grande assemblea, cioè della nascente sinagoga. È una specie di carta di identità, un biglietto di presentazione di tutti i maestri farisei che hanno costituito la Mishnà.
L’affidabilità storica della catena di trasmissione acquista una certa stabilità proprio a partire dalla “coppia” Hillel e Shammaj, maestri dell’inizio del I secolo, contemporanei più anziani di Gesù. Essi non sono ancora chiamati «Rabbi», perché di una ordinazione rabbinica vera e propria si può parlare – ricorda Mello – solo dopo il 70.
Hillel è originario di Babilonia, più conciliante di Shammaj, capostipite più rigoroso della scuola palestinese. I detti dei Padri sono di solito in terza persona, mentre i detti di Hillel sono riportati eccezionalmente in prima persona. Egli si espone direttamente e sembra quasi parlare, profeticamente, in nome di Dio.
Il giudaismo di Hillel e quello di Gesù sembrano mostrare – secondo Mello – una certa appartenenza a una «nuova sensibilità» umanistica all’interno del giudaismo.
La forte impronta di Hillel e la scelta di Javne a suo favore sono costitutivi dell’ebraismo rabbinico come normativo dopo la distruzione del tempio.
La Mishnà
Dopo la distruzione del tempio e la convocazione del Sinodo di Javne, iniziato da Jochanan Ben Zakkai e presieduto da Rabban – così viene chiamato il presidente dell’assemblea rabbinica – Gamliel, si sentì il bisogno di formulare non solo un canone preciso della Scrittura ma anche di redigere tutte le tradizioni storiche e liturgiche legate a usi e fatti che ormai rischiavano di perdersi per desuetudine.
Si comincia, inoltre, a sentire la necessità di una Mishnà valida per tutti.
La grande opera di raccolta e sistemazione del materiale mishnico si deve ai due principali rabbi di questo sinodo, Rabbi Eli’ezer e Rabbi Jehoshua’ (solitamente in conflitto tra loro) e, soprattutto, al loro comune discepolo Rabbi ‘Aqiva, il più grande dei maestri tannaiti, e al trasmettitore di quest’ultimo, Rabbi Me’ir.
I criteri che hanno presieduto alla redazione della Mishnà non sono stati esclusivamente di carattere normativo, bensì didascalico: spesso si sono conservate discussioni e halakot (norme) contrarie alla prassi abituale del tribunale rabbinico, perché considerate importanti e stimolanti da un punto di vista pedagogico. Si conservano anche le opinioni minoritarie della scuola di Shammaj.
La redazione finale della Mishnà fu attribuita da Rabbi Sherirà Ga’on (987 d.C.) a Rabbi Jehudà ha-Nasì’ (il presidente»).
Secondo Mello (cf. p. 13), l’opinione attuale più affermata è che Rabbi Jehudà avrebbe sì “pubblicato” la Mishnà, già definitivamente sistemata e avente valore vincolante per tutti, ma sempre come qualcosa da trasmettere oralmente. Perciò, secondo lui, si può dire che la redazione scritta della Mishnà sia stata tutt’al più “tollerata”, ma mai autorizzata.
Questa redazione scritta di fatto non è accertabile prima della pubblicazione del Talmud di Babilonia, che la cita e la commenta (e infatti il testo della Mishnà si ricostruisce a partire dai manoscritti del Talmud). Ora, si ritiene che il Talmud sia stato redatto in aramaico babilonese intorno al VI secolo, prima della conquista islamica.
I maestri tannaiti
Il termine Mishnà deriva dalla radice shanah, che vuol dire “ripetere” un insegnamento ricevuto dalla tradizione. È il nome che si dà all’insegnamento dei maestri farisei del I e II secolo, quelli che si chiamano anche tannaiti (l’aramaico tana’ essendo il preciso equivalente dell’ebraico shanah).
La Mishnà è stata una “ripetizione” orale prima di essere messa per iscritto. Essa rimane sostanzialmente un riassunto pedagogico della Torà orale, un testo scolastico di hakakhà (così Avraham Golberg). Rabbi ‘Aqiva è stato chiamato il «padre della Mishnà».
Mello parla di quattro “strati” dell’attuale Mishnà. Il primo risale a Javne. Il secondo è la Mishnà di Rabbi ‘Aqiva. Il terzo è quello dei suoi discepoli. Il suo più fedele interprete fu Rabbi Me’ir, e infatti si dice che una «semplice mishnà», ossia un’opinione anonima nella Mishnà, è quella di Rabbi Me’ir. Con questo si raggiunge il quarto strato, cioè la pubblicazione finale della Mishnà ad opera di Rabbi Jehudà, il presidente, che era discepolo di Rabbi Me’ir.
In tal modo la «Mishnà» di rabbi Jehudà «ripete» l’insegnamento di Rabbi Me’ir e degli altri discepoli di Rabbi ‘Aqiva.
L’ordinamento della Mishnà
La «nostra Mishnà» (come si chiama il testo finale, che sarà commentato dal Talmud) è suddivisa in 63 “trattati” (massekhot) raggruppati in sei “ordini” (sedarim) che ne definiscono pressappoco i grandi temi.
Sintetizziamo l’indicazione dei temi elencati da Mello.
- L’uomo e la terra: «Sementi» (Zera’im, 11 trattati);
- L’uomo e il tempo: «Feste» (Mo’ed, 12 trattati);
- L’uomo e la donna: «Donne» (Nashim, 7 trattati);
- L’uomo e la società: «Danni» (Neziqim). È il codice di diritto civile e penale. Comprende 10 trattati, perché il trattato sui Danni sui divide in tre «Porte», in aramaico Baba. Qui si ritrova il trattato Avot, il solo testo non giuridico di tutta la Mishnà, che è una rassegna delle autorità che l’hanno prodotta;
- L’uomo e il sacro: «Cose sante» (Qodashim, 11 trattati);
- L’uomo e la morte: «Purità» (Toharot, 12 trattati), nome eufemistico per indicare varie specie di impurità (delle persone, degli arredi, delle suppellettili) dovuta sia a contatto con un cadavere, sia a malattie cutanee. Il trattato Jadajim include anche una discussione circa i testi sacri, che, in quanto tali, «rendono impure le mani».
La pubblicazione della Mishnà da parte di Rabbi Jehudà è avvenuta oralmente. Nonostante questa lunga gestazione orale, la Mishnà ha anche il merito di aver creato una lingua letteraria ricca e precisa. L’ebraico mishnico sarà il fondamento di tutto lo sviluppo linguistico successivo, fino all’ebraico moderno.
Le halakhot rimaste escluse dalla Mishnà (e chiamate barajtot: «esterne») confluirono nella Tosefta, che vuol dire appunto “aggiunta”, “supplemento” alla Mishnà. Con questa aggiunta, la tradizione si arricchisce di un ultimo strato: l’insegnamento del rabbi per antonomasia Jehudà ha-Nasì’ («il presidente»).
Esempi di ampliamento di Avot in ARN
Nella sua introduzione al testo, Mello fornisce tre esempi di come ARN amplia Pirqè Avot.
Le tre colonne
Il primo esempio si riferisce alle tre colonne su cui il mondo sta: Torà, culto e opere di misericordia. Mello fa notare come ci sia uno scivolamento di significato nei termini.
Torà acquista il senso ulteriore di «studio della Torà» (talmud Torà). Il «culto» (‘avodà) si riferisce sì al culto, al “servizio” liturgico, ma, non essendoci più il tempio, acquisisce il senso di preghiera. La terza colonna (gamilut hasadim), che inizialmente significava «rendimento di grazie», la preghiera personale, ora diventa espressione idiomatica per indicare la “restituzione dei favori” o quello di “opere di misericordia” dell’uomo verso il suo prossimo che superano la semplice elemosina.
Il mondo che viene
Il secondo esempio tratta del mondo che viene. Il mondo ebraico distingue tra «questo mondo» (ha-’olam ha-zeh) e «il mondo che viene» (ha-’olam ha-ba’, entrambi espressi con un participio presente).
La tradizione rabbinica pensa che «il mondo che viene» è un mondo già in azione adesso, è lo stesso mondo nella misura che si sta trasformando in un altro. È lo stesso mondo, ma non chiuso in sé, ma in quanto “viene”, cioè è aperto a esiti imprevedibili. Il mondo che viene non è un altro mondo, diverso dal nostro, ma il nostro mondo, “in cammino”, in progress: aperto a molti sviluppi. A colpi di citazioni bibliche, i rabbini discutono su chi ne farà parte.
La risurrezione
Il terzo esempio riguarda la risurrezione. Alcuni dicono che la misericordia non può essere sconfinata, non si spinge «fino al nido degli uccelli». Ma la posizione dominante normalmente è quella che viene esposta per ultima.
Circa la morte e la risurrezione, si ha la certezza che gli inferi, lo Sheol e neppure l’inferno o geenna possono essere definitivi. La fede nella risurrezione si sviluppò tardivamente nel giudaismo, con Dn 12,2, ma la speranza di una vita oltre la morte ha radici più antiche e profonde nell’umanesimo biblico.
I rabbini postulano la provvisorietà dell’inferno, o meglio pensano alla geenna come un purgatorio: un passaggio temporaneo come attraverso il fuoco. Come si dice nel Vangelo di Marco 9,49 «Ognuno sarà salato col fuoco», oppure come si ritrova nel ragionamento dall’andamento rabbinico di Paolo in 1Cor 3,15: «Se l’opera di qualcuno finirà bruciata, quello sarà punito; tuttavia egli si salverà, però quasi passando attraverso il fuoco».
Il Midrash contesta che Mosè abbia visto Dio faccia a faccia (cf. Dt 34,10). Ne conclude che neppure Mosè ha visto Dio durante la sua vita, ma lo ha visto precisamente nella morte. «Quando si può vedere Dio? In prossimità della morte. Da qui si impara che i morti vedono Dio» (Sifrè Devarim 357).
Mello traduce la versione A di Avot di Rabbi Natan (ARNA) pubblicato da S. Schechter. Essa comprende 41 capitoli. Lo studioso suddivide ulteriormente l’opera in paragrafi titolati in modo da facilitare il reperimento analitico attraverso gli indici. Poche sono le omissioni e debitamente segnalate. Sono segnalate anche l’integrazione di alcuni passi più significativi della versione B (ARNB). Le massime che hanno un parallelo in Pirqè Avot sono evidenziate in corsivo. Eventuali varianti significative sono indicate in nota.
La traduzione dei testi biblici e la resa aderente all’originale ebraico di alcuni nomi propri e toponimi biblici sono sempre a cura di Mello.
Corredano l’opera la Bibliografia (pp. 225-230), l’indice biblico (pp. 231-236) e l’indice rabbinico (pp. 237-239).
Opera suggestiva, traduce per la prima volta in italiano un testo che rappresenta una pietra miliare della spiritualità ebraica e che permette di gustare le discussioni tra i vari rabbini e la loro profonda conoscenza del testo biblico, oltreché rappresentare un prezioso parallelo con il mondo di Gesù e degli scritti del Nuovo Testamento.
- I padri del mondo. Avot di Rabbi Natan. Introduzione, traduzione e note a cura di ALBERTO MELLO (Spiritualità ebraica), Edizioni Qiqajon, Comunità di Bose, Magnano (BI) 2024, pp. 246, € 24,00, ISBN 978888822763348.