Tessere di un mosaico
La liturgia ci invita ad iniziare l’anno salutando Maria con l’Antifona:
Salve, Madre santa: hai dato alla luce il Re
che governa il cielo e la terra nei secoli dei secoli.
Quella in Maria Madre di Dio è una fede antica, che affonda le radici nei racconti evangelici, nelle testimonianze di fede e di culto, e si sviluppa sempre alla luce del Verbo incarnato. È la storia dei primi concili a donarci, assieme e attorno alle definizioni trinitarie e cristologiche, anche quelle riguardanti il ruolo di Maria nella storia della salvezza, in particolare proprio il suo legame al Figlio quale Madre di Dio (theotokos), sancito nel Concilio di Efeso del 431 e ribadito a Calcedonia nel 451, proprio per affermare l’unità delle due nature nell’unica persona di Cristo e la sua doppia consustanzialità: al Padre per la divinità e a noi per l’umanità.
Ma prima, attorno, dietro e oltre la terminologia teologica più adeguata, la fede si esprime anche in immagini, emozioni, esperienze, evocazioni e tradizioni che come tessere di un mosaico non dicono tutto né parlano con precisione, ma vanno a delineare le caratteristiche di questa affascinante figura e che cosa essa rappresenti per i credenti che a lei si affidano.
Nei primi secoli cristiani questo universo di significati affonda le sue radici nella lettura allegorica del Primo Testamento e fa sì che esso ci restituisca non soltanto teofanie che rivelano la presenza del Logos che si farà carne, ma anche allusioni e immagini di colei che ne sarà la madre e che avrà anch’essa, come il Figlio, molti nomi e molti modi per esprimere e realizzare la sua missione.
In questo fertile terreno biblico fatto di storie, simboli, personaggi e profezie, germinano la devozione e la poesia, si sviluppano il culto e la preghiera, dando vita a numerose immagini evocative. Basta scorrere le pagine di Andrea di Creta o di Romano il Melode, di Giovanni Damasceno o di Germano di Costantinopoli, passando per l’inno Akathistos, per cogliere la ricchezza di questa interpretazione «mariana» delle Scritture.
Vogliamo qui coglierne solo alcuni tratti, particolarmente evocativi, che ci vengono suggeriti dalla Liturgia delle Ore della Solennità della Madre di Dio.
Roveto sempre ardente
Fin dai primi secoli lo sguardo dei credenti vede Maria misticamente adombrata nel roveto ardente (cf. Es 3,3). Il fuoco che arde e risplende è la divinità stessa, che la bontà misericordiosa di Dio non ha racchiuso in un astro, ma in un corpo umano; per venire nel mondo Dio non ha scelto la materia celeste, ma un «cespuglio terreno», il corpo di Maria, che però rimane intatto, non «consumato» nella sua verginità[1].
In questa immagine si esprime la straordinarietà del Figlio, che nasce uomo come noi eppure al di là delle leggi della natura per sanare la nostra natura, e questo coinvolge la Madre, «roveto sempre ardente» che mentre genera il Figlio è a sua volta generata a una nuova realtà salvata, incorrotta, «inconsumata» e inconsumabile, come si rivelerà nell’Assunzione in Cielo. Per questo la Chiesa prega, nella terza antifona dei Vespri:
«Come il roveto
che Mosè vide ardere intatto,
integra è la tua verginità, Madre di Dio:
noi ti lodiamo, tu prega per noi».
Come rugiada sul vello
Una seconda immagine è quella del vello, la pelle ricoperta di lana su cui il Signore fa scendere la rugiada come segno per Gedeone (cf. Gdc 6,36-40). Il Salmo 72,6 (nella versione dei Settanta) riprende l’idea parlando della venuta del Messia che: «Scenderà come pioggia sul vello e come gocce stillanti sulla terra»[2] e ci fa comprendere come questo scendere della rugiada/pioggia possa essere letto come un simbolo della concezione verginale di Maria, fecondata dalla rugiada dello Spirito e non da seme umano.
La maternità divina di Maria è affermata ancora una volta in funzione della straordinarietà del Figlio, il Messia atteso che è la verità che «germoglierà dalla terra» (Sal 85,12), quella terra che rappresenta la natura umana di Maria. L’antifona dei Vespri ci fa dunque pregare:
«Hai compiuto le Scritture,
quando in modo unico sei nato dalla Vergine;
come rugiada sul vello
sei disceso a salvare l’uomo.
Lode a te, nostro Dio!».
Porta felice del Cielo
Infine in questo inizio dell’anno giubilare non possiamo tralasciare l’immagine della porta, che Gesù stesso ha voluto utilizzare per indicare la sua missione di mediatore verso i pascoli e la Vita in abbondanza (cf. Gv 10,7-10), ma che è anche uno degli appellativi utilizzati per Maria. I Padri cantano Maria/porta richiamando la profezia di Ezechiele (44,1-3) che parla della porta esterna del santuario, destinata a rimanere chiusa e «nessuno vi passerà, perché c’è passato il Signore, Dio d’Israele», richiamando così ancora il mistero della maternità verginale[3].
Maria è però anche la porta aperta, spalancata, la «porta regale» e la «porta felice del Cielo», dalla quale Dio è «uscito», facendosi povero per noi, e nella quale noi possiamo «entrare», arricchiti dalla sua povertà (cf. 2Cor 8,9). Attraverso di lei il «re della gloria» è entrato nella storia (cf. Sal 24,7.9) facendosi uomo, e l’umanità che lei rappresenta ritrova la strada verso la natura beata per cui è stata creata. Grazie a lei è dunque stato possibile, come ci fa pregare la prima antifona, il
«Meraviglioso scambio!
Il Creatore ha preso un’anima e un corpo,
è nato da una vergine;
fatto uomo senza opera d’uomo,
ci dona la sua divinità».
Generare la Parola
Guidati da queste e molte altre tracce bibliche, i Padri ci portano a leggere il ruolo di Maria nella storia e nel nostro itinerario di fede e a vederla come modello della nostra vita cristiana. Come accade per le dichiarazioni dogmatiche, ci accorgiamo che sempre si parla di lei per mostrare il Figlio, sempre lei ci conduce al Figlio, ci rende comprensibile il Figlio, ci indica il Figlio.
Questo suo essere «relativa» a Cristo però non diminuisce, anzi accresce la sua importanza e apre la strada a ciascuno di noi. Maria è unica perché solo a lei è stata donata la grazia di diventare la Madre del Figlio di Dio, in lei Dio si è unito per sempre alla nostra umanità. Eppure nello stesso tempo Maria è vicina a ciascuno di noi, ci apre la strada perché il Verbo possa ancora farsi carne in noi e tra noi.
Nelle pagine della Scrittura Maria è adombrata quando eventi ordinari si manifestano in modo straordinario, perché questo è anche la sua maternità divina. Ci insegna a fare della nostra ordinarietà un luogo dove il Cristo possa ancora abitare, a mettere a disposizione del Verbo la nostra vita perché diventi Parola significativa per altri, ad accogliere la fatica e lo stupore della fede in un Dio che sceglie sempre la via dell’incarnazione.
Così lo Spirito potrà rendere anche noi straordinariamente «gravidi», come ha fatto con Maria, cioè concederci di generare con le opere e lo stile della nostra vita la comprensione della Parola che ha preso dimora in noi[4].
[1] Cf. ad esempio Gregorio di Nissa, Vita di Mosè 2,21.
[2] Nella CEI 2008 si legge invece: «Scenda come pioggia sull’erba, come acqua che irrora la terra».
[3] Cf. Andrea di Creta, Omelie mariane 4.
[4] Cf. Gregorio Magno, Regola Pastorale 3,24.
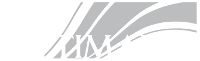


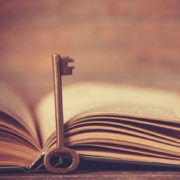


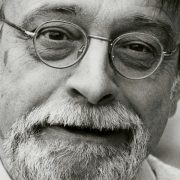
L’immagine che il vangelo ci lascia della Madonna è di una figura importante ma spesso silenziosa. La sua è una presenza che conta ma parla poco. Maria parla poco ma quando serve c’è sempre. Noi invece ci siamo lasciati andare ad un profluvio di parole su di lei, mille immagini mille metafore a volte incomprensibili più simili ad adulazioni.
La figura di Maria va meditata nel silenzio. Su Maria abbiamo esagerato e secondo me non le abbiamo reso giustizia. Meno chiacchiere e più presenza dove serve. Questo è renderle onore.
Sono perfettamente d’accordo!