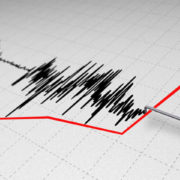Proponiamo il testo del Capitolo 2 del volume di Martha Nussbaum, La speranza degli afflitti. Il lutto e i fondamenti della giustizia. A cura di Paolo Costa, EDB, Bologna 2016.

Martha Nussbaum
Il desiderio di consolazione non è così facile da conciliare con la ricerca di una giustizia universale. Verrebbe da supporre, anzi, che concentrarsi sul proprio bisogno di essere consolati e abbracciati possa essere una potente distrazione dal perseguimento della pace e della giustizia.
Volendo aggiungere una nota autobiografica, l’enigma è all’origine anche dei sentimenti oscillanti, miei e dei miei studenti e lettori, riguardo al mio lavoro come filosofa: mi sono cimentata, infatti, in due temi apparentemente distanti, cercando, da un lato, di delineare alcuni princìpi di giustizia sociale e globale e, dall’altro, indagando la struttura delle emozioni personali – di fatto concentrandomi, nel secondo caso, sulle idee di lutto, consolazione e compassione, sul modo in cui ci si affligge per la morte di un genitore molto amato, sul modo in cui si cerca consolazione dopo aver sperimentato sulla propria pelle un dolore terribile. Le persone tendono semplicemente a pensare che io lavori su due temi slegati. Personalmente sento che i temi sono concatenati, anche se non è facile chiarirne la connessione. […].
Quando siamo bambini, abbiamo mille bisogni e il dolore è un’esperienza molto comune. Desideriamo intensamente essere abbracciati e confortati. Agogniamo un mondo in cui ogni dolore sia annientato, ogni separazione colmata da un abbraccio. In altre parole, vogliamo essere il centro dell’universo. Dopo tutto, l’unico modo per ottenere immediato sollievo da qualsiasi dolore sarebbe trasformare gli altri in nostri schiavi. Dapprincipio, la nostra sola consapevolezza degli altri si dà sotto forma di forze vaghe che provvedono ai nostri bisogni. Quando lo fanno, possono essere «amate». (Metto «amate» tra virgolette, perché non è vero amore quello che prova un bambino quando accoglie il seno o va alla disperata ricerca di conforto). Quando gli altri, invece, non provvedono ai nostri bisogni, quando si rifiutano ostinatamente di rinunciare alla loro separatezza e non soddisfano un impulso imperativo di cura o contenimento, proviamo rabbia. Vogliamo che le persone siano come abbiamo bisogno che siano. Freud aveva buone ragioni a chiamare l’infante «Sua maestà il bambino»: i bambini, come i re, non capiscono che le altre persone sono reali; desiderano soltanto comandarle. Jean-Jacques Rousseau, commentando la tendenza dei bambini piccoli a schiavizzare i loro genitori, vedeva in questa inclinazione una grave minaccia all’idea stessa di un ordine sociale basato sulla giustizia e sull’uguaglianza politica.[1]
La richiesta personale di conforto, nella sua forma infantile, è puro narcisismo. Qualora permanesse nel suo stato originario, annienterebbe qualsiasi pensiero di giustizia in quanto può tranquillamente prescindere dall’idea che le altre persone siano reali.
Con il passare degli anni, se tutto procede regolarmente, diventiamo gradualmente capaci di vedere gli altri come persone intere che hanno bisogni specifici e autonomi, e sviluppiamo un amore e un interesse autentico nei loro confronti e sensi di colpa per le richieste eccessive di cui li abbiamo caricati e di cui probabilmente vorremmo ancora gravarli. Entrambi i nostri testi sottolineano questa capacità di confrontare l’altro «faccia a faccia», panim b ’fanim nel Deuteronomio – un’idea che suggerisce il riconoscimento dell’altro come un fine e non come un mero strumento dei propri desideri. (È stato il commentatore dell’XI secolo Rashi ben Eliezer a notare che un’interazione faccia a faccia richiede onestà e la sospensione dei comportamenti manipolativi e disonesti). Nel libro di Isaia notiamo analogamente che tutti devono portare messaggi di consolazione e gioia non solo a se stessi, ma, soprattutto, ai propri concittadini di Sion. L’imperativo «consolate, consolate il mio popolo» (Isaia 40,1) è un plurale, e sebbene molti commentatori lo interpretino come un riferimento al gruppo di profeti, altri – tra i quali spicca il poeta liturgico Eleazar Kallir, vissuto a cavallo tra il VI e il VII secolo – sostengono che i destinatari siamo tutti noi, l’intera congregazione. (Sono in debito qui con Elsie Stern per la sua bella esegesi del commentario poetico di Kallir, svolta in una tesi di dottorato discussa presso la University of Chicago nel 1998 e intitolata From Rebuke to Consolation). Dovremmo perciò sforzarci di diventare tutti messaggeri di cura e consolazione verso tutti: dato l’universalismo del testo preso nel suo insieme, non sembra esserci infatti motivo per non interpretare questo «tutti» come se significasse «il mondo intero».
L’interesse per gli altri, comunque, non si svilupperà se il bambino resterà convinto che il suo stato ideale sia una condizione di beata completezza o perfezione, la rimozione dal sé di ogni dolore o ansia. Se questo è il proprio fine personale, non c’è altro da fare che usare gli altri come strumenti perché un simile scopo irraggiungibile suscita appetiti insaziabili. È essenziale, pertanto, rinunciare progressivamente a quell’obiettivo personale: non c’è spazio nelle nostre vite per uno stato di completezza o perfezione. Ma ciò non significa altro che riconoscere che siamo fragili e mortali, soggetti a molte debolezze e avversità che sono il destino che accomuna tutti gli esseri umani. Rousseau era convinto che accettare la propria comune fragilità fosse il fondamento di ogni possibilità di giustizia sociale. Da ciò consegue, come ben sapeva l’autore del Contratto sociale, che il riconoscimento della comune fragilità umana è cruciale anche per una felicità basata sulla giustizia, anziché sul suo sovvertimento. Nel sostenere questa tesi Rousseau colse (anche se di certo non intenzionalmente) il significato profondo del testo di Isaia. Per rendersene conto appieno osserviamo più da vicino una strana associazione nella porzione che ho cantato.
Nei versetti famosi che cominciano con «Ogni valle si innalzerà» (Isaia 40,4), il messaggio di consolazione è seguito immediatamente da una voce che annuncia che «ogni essere vivente è erba». Ci si potrebbe chiedere come possano stare insieme queste due idee, perché, se c’è una cosa certa a questo mondo, è che la consapevolezza di essere mortali non è a prima vista consolante. In effetti, tutto ciò che questa voce proclama ha il tono inconfondibile delle cattive notizie: «Ogni essere vivente è erba, e tutto il suo favore è come fiore del prato». Chi ha voglia di ascoltare simili annunci? Be’, sicuramente non il narcisista. Il narcisista, infatti – e con questo termine non mi riferisco a una persona in particolare, ma a una parte o voce che è dentro ciascuno di noi – si aspetta di essere superiore a tutto ciò e immortale (come i re e i nobili di Francia descritti da Rousseau).[2] Il punto, però, è che solo chi riconosce di avere in comune con gli altri esseri umani un insieme di debolezze e bisogni si trova nella posizione di dare, o ricevere, consolazione in una forma non narcisistica.
[1] Cf. J.-J. Rousseau, Emilio, Mondadori, Milano 1997 [ndt].
[2] Cf. ivi, 297 [ndt].