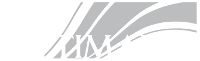Terminato l’esame sulla fede, san Pietro, cantando, benedice Dante, esprimendo la gioia per ciò che egli ha risposto; e gli gira tre volte intorno, incoronandolo testimone della fede.
Subito dopo, dalla corona di beati da cui è uscita la luce di Pietro, si muove quella di Giacomo e poi quella di Giovanni: i tre scelti da Cristo come testimoni della sua potenza (la risurrezione della figlia di Giairo), della sua gloria (la trasfigurazione) e della sua angoscia nel Getsèmani. Ora sono lì, davanti a Dante.
La presenza dell’apostolo Giacomo
L’incontro di Pietro e Giacomo è festoso e tenero come quello di due colombi che si manifestano il reciproco affetto.
Beatrice, piena di letizia, sollecita Dante a mirare il nuovo apostolo. Questi esorta Dante ad alzare gli occhi che aveva abbassato per il «peso» della loro luce.
L’abbondanza di luce è ricchezza spirituale, che si perfeziona man mano che si progredisce in essa. Salendo di cielo in cielo, Dante ha rafforzato la vista. Ora può alzarla. E l’alza verso quei giganti di santità, fulgenti come fuoco.
Anche a lui è stato dato il privilegio di incontrarli, ancora vivo, qui, nel Cielo stellato, nelle stanze segrete della corte celeste, nella festosa atmosfera di splendori. Poco prima ha contemplato il trionfo di Cristo e di Maria, e ora è prossimo alla visione di Dio, oggetto della speranza, sulla quale si svolgerà l’esame.
Il suo scopo, però, non è accertarsi se Dante la possiede, ma gloriarla. In cielo, la speranza non ha più motivo di essere, perché la beatitudine è stata raggiunta. Ma san Giacomo avvampa ancora d’amore per essa; e se di essa si parla, è per gloriarla. L’esame ne è la glorificazione. «Fa risonar la spene in questa altezza» – gli dice l’apostolo che la rappresenta. Solo chi ha visto le gioie del cielo può farlo.
Tale privilegio è legato alla missione di Dante: manifestare agli uomini ciò che ha visto, scriverlo senza nascondere nulla «in pro del mondo che mal vive» (Pg, XXXII, 103), e rafforzare in lui e negli altri il valore della speranza.
Ma quanta ne ha lui per essergli stato concesso di venire dall’esilio terreno alla patria celeste, per esserci venuto ancora vivo, per celebrarla e «con-fortarla» negli altri?
Tanta – risponde Beatrice a questa domanda di san Giacomo. Avrebbe dovuto rispondere Dante; ma lo fa lei, che sempre lo soccorre amorevolmente; e lo fa perché non sembri presunzione la risposta di lui riguardante sé stesso, dato che la Chiesa militante non ha nessun figlio con più speranza di lui (Pd, XXV, 52-53). Siano gli altri a lodarci, non noi stessi – dicono i Proverbi.
D’altronde, san Giacomo sa bene che Dante ne possiede tanta; lo sanno i beati e lo sa Beatrice, perché lo leggono in Dio; e lo sa Dante perché ha la fede, senza la quale non può esserci nemmeno la speranza. Nelle parole di Beatrice c’è la fierezza del cittadino e del cristiano che spera in una patria più bella rispetto a quella che in terra gli è negata, ma che non dimentica. E c’è l’elogio della fede e della speranza.
Dante è vivo, tornerà sulla terra, dopo aver visto le gioie della patria celeste, nelle quali trova consolazione l’esilio terreno. Se la fede e la carità sono frutto d’una conquista, la Speranza è desiderio, fervore dell’anima, tanto più forte, quanto più lo sono le delusioni e l’infelicità. Ed egli sa quanto sia vana la speranza terrena, sia pure la più bella e la più degna d’essere coltivata.
Che cos’è la speranza
Ma cos’è la speranza? – domanda ancora san Giacomo. Questa volta risponde Dante stesso, pronto e volenteroso come uno scolaro. L’umiltà non gli vieta di mostrare la sua preparazione in questa virtù. Lo desidera, anzi, per averne la conferma e compiere più degnamente la missione che lo aspetta.
Ed ecco la grande risposta teologico-dottrinale: «Spene […] è uno attender certo | de la gloria futura, il qual produce | grazia divina e precedente merto» (Pd, XXV, 67-69): la speranza è attesa certa della futura beatitudine.
L’attesa è sempre paziente, come lo stesso Giacomo scrive nella Lettera che Dante citerà come una delle fonti della sua speranza: «Siate costanti (patientes), fratelli, fino alla venuta del Signore. Guardate l’agricoltore: egli aspetta con costanza (expectat… patienter ferens) il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge» (Gc 5,7).
L’attesa è causata in noi dalla grazia divina e dai nostri meriti che la precedono. Questa è la speranza cristiana: certezza, non probabilità né esitazione della gloria futura che attendiamo; e consiste nella visione di Dio che si godrà in modo perfetto quando i corpi saranno risorti. Allora, la loro luce crescerà, e i beati saranno nella condizione più gradita a Dio, nella quale lo contempleranno in eterno.
Finché siamo sulla terra, noi crediamo per fede questa condizione, in modo confuso, certo, ma ugualmente vero, perché la fede non dà ipotesi; la fede è «sustanza di cose sperate» (Pd, XXIV, 64). Se essa è certa, lo è anche la speranza. E l’una e l’altra ci sono date per grazia.
La speranza è tensione verso il cielo, figurata in una giovane donna con lo sguardo fisso ad esso. Ma è anche fondamento della felicità terrena, perché Dio vuole per noi anche questa felicità, che acquistiamo con i meriti delle nostre capacità naturali. La grazia, pertanto, segue i nostri meriti, e gli uni e l’altra sono una sola realtà, perché l’una senza gli altri non porta alla beatitudine.
Quando Dante, alla fine del viaggio, rivede Beatrice – colei che ha rinvigorito la sua speranza – la vede seduta sul trono che i suoi meriti le hanno assegnato. La speranza, allora, deve «con-fortarci», darci la forza di operare virtuosamente.
I Salmi e la Lettera di Giacomo
Questa forza viene a Dante dai libri sacri che sono la parola di Dio; e Dio è il Dio della speranza, luce che scalda il mondo e risplende sopra di esso (Pg, XIII, 19). Due soli nomi sono indicativi qui di tutta la Scrittura: i Salmi, tradizionalmente attribuiti a Davide, e la Lettera dello stesso Giacomo.
La Lettera di Giacomo, in realtà, non parla specificamente della speranza, ma indirettamente ne allude in più parti: per esempio, nel versetto sopra ricordato; o in quest’altro: «Se qualcuno di voi è privo di sapienza, la domandi a Dio, che dona a tutti con semplicità e senza condizioni, e gli sarà data. La domandi però con fede, senza esitare, perché chi esita somiglia all’onda del mare mossa e agitata dal vento» (Gc, 1,5-6); o in altri in cui si dice che Dio premia chi soffre, ma confida in lui. Il confidare e il premio, infatti, suscitano speranza.
I salmi invece, anche quelli nei quali l’orante si rivolge a Dio nella sventura, cantano sempre, alla fine, la speranza, la cui luce penetra nel cuore goccia a goccia come acqua, con la dolcezza della loro musica.
I salmi sono “teodia”: canti di lode a Dio. Con che entusiasmo Dante intreccia queste metafore – luce, acqua, canto, musica – ad esprimere la gioia di possedere questa virtù! «Sperino in te quanti conoscono il tuo nome, perché tu non abbandoni chi ti cerca, o Signore» – dice il salmo 9 (v.11), salmo che esprime la speranza in Dio del misero, preso ad esempio da Dante. Come le avrà sentite nel profondo di sé queste parole che lo hanno illuminato come stella!
Dal Vecchio e dal Nuovo Testamento, dunque, scende la pioggia delle virtù teologali, come distillata libro dopo libro, che ha “riempito”, l’anima di Dante, tanto che ora vuole «riversarla» (repluere) negli altri: «sì ch’io son pieno, e in altrui vostra pioggia repluo» (vv.77-78): verso bellissimo, melodico, che dice tutta la gioia e la dolcezza che la speranza infonde nei cuori.
Fede e speranza sono indissolubili
Fede e speranza, indissolubili, si riflettono l’una nell’altra. Il romanzo postumo di Ignazio Silone – Severina – si conclude con Severina, non più suora, malata in un letto d’ospedale. Le si avvicina una sua ex consorella e le chiede se crede ancora. Severina da molto tempo non crede più in Dio; e le risponde: «Spero, suor Gemma, spero. Mi resta la speranza». Ma è speranza laica, «il lascito cristiano al laicismo contemporaneo, o se si vuole il momento religioso della coscienza laica» (G. Pampaloni). Manca la fede, la conoscenza di Dio.
Sperino in te quanti conoscono te. Nella sventura o nel peccato noi conosciamo Dio; e, una volta conosciuto, diviene la nostra speranza, e tendiamo a Lui. Quanti cercano Dio, sono certi che Dio non li abbandona, perché anche Dio li cerca. «Quaerens me, sedisti lassus»: cercando me, ti sei seduto stanco.
E in un verso semplice e potente – «E chi nol sa, s’elli ha la fede mia?» – Dante fa esplodere tutta la gioia di credente: la più bella, sincera confessione di fede, dopo quella umile e devota a Maria («Il nome del bel fior ch’io sempre invoco | e mane e sera», Pd, XXIII, 88-89).
Egli ha tanta speranza perché ha tanta fede, entrambe vive, risplendenti per grazia divina. Tutta la nostalgia e lo sdegno del cittadino di-sperato con cui si apre il canto della speranza, svaniscono davanti all’orgoglio della fede e della speranza del cristiano. Il cristiano è «luce del mondo».
Tornato sulla terra, Dante vuol far risplendere questa luce davanti agli uomini, perché rendano gloria a Dio (Mt, 5,16). Nel percorso della vita, terrena e spirituale, la speranza è luce e guida; è parte di essa; è àncora – come i pittori l’hanno dipinta con altra immagine.
La luce che racchiude l’apostolo Giacomo tremola di soddisfazione e di gioia per ciò che Dante ha detto sulla speranza. Dall’alto si ode cantare Sperent in te qui noverunt nomen tuum: il versetto 11 del salmo 9, che Dante ha ricordato prima come fonte della sua speranza. Al canto rispondono i beati. Dante è incoronato anche di questa virtù.
Dante a Roma per il giubileo del 1300?
Non sappiamo se Dante sia venuto a Roma nel 1300 come pellegrino del primo giubileo della storia della Chiesa. È un’ipotesi. I ricordi di Roma sparsi nella Commedia possono riferirsi alla sua presenza in città l’anno dopo. Nemmeno possiamo dire che la Commedia sia una celebrazione del Giubileo, essendo più profonda e complessa.
La fede di Dante non disdegna la devozione popolare, almeno nello spirito, ma è una fede profonda ed esigente. Egli certamente sentì e condivise il fervore che quel giubileo generò nella cristianità, e trasformò il viaggio a Roma in viaggio verso il cielo, collocandolo in pieno anno giubilare.
Questo Itinerarium ad Deum all’insegna della conversione interiore è lo spirito che pervade la Commedia. Pellegrini su questa terra, desideriamo tornare alla patria celeste. Il pellegrino verso la Roma terrena e quello verso la Roma celeste provano gli stessi sentimenti, hanno lo stesso desiderio di Dio, la stessa speranza.