
- Il titolo del suo recente volume definisce il rapporto fra potere delle immagini e storia cristiana, come un «amore inquieto». C’è quindi un rapporto profondo (amore) e una difficile relazione (inquieta). Potrebbe spiegarlo?
Anzitutto mi interessa sottolineare la scelta dei termini. Solitamente nei discorsi cristiani si ricorre al binomio arte/fede per intendere una sorta di sodalizio dato in natura che rende le due parti reciprocamente esclusive. Come se l’arte appartenesse da sempre alla fede e come se la fede si nutrisse da sempre di arte. Entrambi questi termini sono solo la condensazione retorica, nel contempo mitizzante e semplificatrice, di un rapporto che in realtà chiede altri vocaboli e altri racconti. Io appunto preferisco dire da un lato «potere delle immagini» e dall’altro «storia cristiana».
Potere delle immagini significa che la dimensione estetica e figurale che appartiene a determinati oggetti non si riduce alle opere d’arte e alla loro storia, ma riguarda una forza simbolica che va ben al di là del racconto della storia dell’arte e della sua mitizzazione. Il potere delle immagini è un fenomeno sociale totale che prescinde dai criteri di qualità prescritti nel Settecento dalle teorie dell’arte. La nostra epoca ne è una prova lampante. Le immagini hanno riempito il mondo non solo della loro presenza ma soprattutto dei loro effetti.
Analogamente, dire storia cristiana significa rendere complesso un termine di confronto che si tende a rappresentare come una entità sempre identica a se stessa e che quindi può rapportarsi ai fenomeni da una posizione di immutabilità. Si continua a pensare al cristianesimo in questo modo. Almeno nelle questioni che riguardano questi temi. Quella cristiana invece è stata una storia. Un cammino evolutivo nel quale cristianesimi anche diversi, nel contesto di quadri culturali in continua trasformazione, hanno intrattenuto il loro rapporto col potere delle immagini in modo non sempre identico. E nemmeno sempre così pacifico e naturale come vorrebbe il cliché che fa l’apologia dell’«arte sacra» (che in realtà è solo la proiezione mitizzata dell’arte a soggetto religioso dell’epoca tridentina, peraltro filtrata dalle lenti del tardo romanticismo).
Ripercorrere la storia al di fuori di questi cliché mostra che il sodalizio non solo è scaturito da origini turbolente, ma ha dato vita a un itinerario sempre accidentato e a un rapporto sottoposto a continua sorveglianza, oltre che esposto a perenni patteggiamenti. È stato sicuramente un amore, nel senso che il cristianesimo, contro lo stesso DNA delle sue radici ebraiche, ha trovato nell’espressione sensibile delle sue forze migliori qualcosa cui non poteva rinunciare senza perdere la propria natura. Ma si è trattato anche di un legame inquieto, perché costantemente esposto a un potere delle immagini sempre pronto a prendere il sopravvento. Per il cristianesimo le immagini erano quasi un sacramento, ma questo le portava a un’altezza tale da metterle sempre in condizioni di diventare degli idoli. Non si può fare la storia delle immagini cristiane senza fare al contempo quella del sacramento e del rapporto forme/forze che continuamente agisce in esso.
- Il volume sintetizza in tre grandi periodi la relazione fra arte e vita cristiana: icona, rappresentazione, “video sfera”. Quali sono (a grandi linee) le caratteristiche fondamentali dei tre periodi?
Nella prima fase le immagini, che si chiamano proprio «icone» svolgono una funzione molto vicina a quella del sacramento. Veicolano presenze. Sono segni integranti del dispositivo liturgico. Nel nostro umanesimo, che è il secondo momento, le immagini ormai divenute anche opere dell’arte non perdono questo legame con la sfera spirituale, ma non possono più esercitarlo al di fuori di una funzione che ormai è rappresentativa. Sono finestre sul mondo. Su questo mondo, non sull’altro. Il loro potere comincia a dipendere dalla qualità tecnica che viene loro conferita dall’abilità degli artisti. Non sono più icone in senso stretto, sono opere dell’arte. E il loro avanzamento tecnico è inerente alla loro natura. Perciò sono tracce di una «storia» che le vecchie icone non contemplavano nemmeno. Il terzo momento è quello in cui ci troviamo noi. La storia dell’arte è morta, nel senso che le immagini hanno ripreso il loro potere istitutivo al di fuori delle pratiche artistiche, in complicità con nuove dimensioni simboliche (lo spettacolo, la moda, la cosmetica) e con inediti poteri tecnologici (la multimedialità digitale). Esistono continuità e contiguità fra questi tre scenari, ma sono anzitutto tre epoche diverse.

- «Vogliamo tornare amici»: le parole di Paolo VI agli artisti nel 1964 a che cosa tendevano e quali risultati hanno alla fine avuto? Qual è stato il senso della ripresa dell’incontro con gli artisti nei pontificati successivi?
Paolo VI è stato il primo a esplicitare la rottura, come un coniuge responsabile che ammette quanto un amore si sia logorato. Ha chiamato gli artisti per questo momento di verità, ma i veri destinatari del messaggio erano i cristiani, lontani dalla cultura del loro tempo e anche dalla vera densità delle loro poste in gioco spirituali. La mia impressione è che purtroppo quel gesto, così clamoroso e profetico, sia stato anche tardivo. Mentre si pensava di far pace con Picasso, Warhol stava già cambiando il mondo. Gli altri pontefici si sono tutti sentiti in dovere di rinnovare quel discorso, ma forse non con la stessa coscienza. Solo Benedetto XVI è entrato nella questione con una certa profondità, con il merito di aver indicato la «liturgia» quale luogo di discernimento di una questione divenuta sempre più spinosa.
- Sono numerosi e importanti gli artisti cattolici e cristiani del Novecento. Che cosa ha impedito alle comunità cristiane di riconoscerli e di favorire la loro “scuola”?
Credo il fatto che il cattolicesimo, in alto come in basso, nel Novecento ha camminato in costante polemica con la cultura che si andava affermando. Quelli tra i grandi e veri artisti che erano rimasti credenti sentivano in fondo di non potersi estraniare da quella cultura e si esprimevano come parte di essa. Sicché nella Chiesa hanno trovato più spazio modesti artigiani della figura che però apparivano meno contagiati dalla nuova cultura. Il rapporto figura/dogma appariva una trincea da non abbandonare. Nessuno vedeva quanto le arti del Novecento stavano entrando nuovamente nell’orbita della performance/sacramento. Si dovrebbero aggiungere mille precisazioni a questa affermazione. Ma credo che in sostanza la ragione sia questa.
- Nel volume parla delle tentazioni delle comunità cristiane rispetto all’arte contemporanea: dal rifiuto totale alla deriva neo-orientale, dalla subalternità acritica al devozionismo ecc. Quali debolezze? Quali ambiguità nasconde il ricorso alla formula spesso citata «la bellezza che salva»?
Si tratta del ricorso al «surrogato» sia mentale che figurativo. L’ingenua pretesa di poter prolungare o resuscitare un sistema simbolico in un contesto che manca delle condizioni che lo hanno un tempo generato. Si possono ripescare le forme, ma con questo non si rianimano le forze. E non ci si accorge peraltro di compiere un gesto che, mentre ha l’ambizione di mantenersi fedele a un passato perduto, appartiene in realtà proprio al principio postmoderno del riciclo sistematico delle vecchie narrazioni. Nulla è più postmoderno del ritorno in auge delle icone.

- Nel contesto post-moderno, che alla condizione umana non riconosce alcun fondamento, l’estetismo o la bellezza formale sembrano coprire il vuoto di senso. Questa appare anche per la Chiesa la sfida seria da affrontare. Si tratterebbe forse di un altro libro da scrivere: ma in che modo immagina che la si possa affrontare? Da dove dovremmo (ri)partire nel rapporto con l’arte?
Nel nostro mondo la bellezza ha socialmente acquisito una funzione «cosmetica». Non significa che noi non facciamo più esperienza della bellezza come referente del trascendente che fa capolino nel mondo. Non abbiamo smesso di emozionarci davanti a un tramonto o di chiamare bello un gesto eticamente rilevante. Ma abbiamo perso il lessico che riconosce quelle esperienze come esperienze del «sacro» che annuncia la presenza del reale. Non avendo più le parole ci sembra di non vivere più nemmeno quelle esperienze.
Il nostro sistema culturale invece è attratto verso quella bellezza che viene chiamata a «rimediare» a una serie di vuoti simbolici (la trascendenza, l’identità, il senso) che richiedono comunque di essere colmati, in un modo o nell’altro. Per dirlo in modo piuttosto sbrigativo (quindi anche superficiale) la dimensione estetica, con tutte le sue arti magiche, serve a sostituire artificialmente quel senso e quella identità che sentiamo di non possedere più come qualcosa di radicato nella realtà (nell’essere, avrebbero detto i filosofi di una volta). Il senso non esiste; costruiamocene uno; e già che ci siamo facciamo che sia bello.
Non la metterei nei termini di una sfida della Chiesa. Si tratta della condizione in cui si trova tutta l’umanità, compresi quelli che vanno in chiesa. La cultura cristiana deve anzitutto comprendersi come parte di un sistema simbolico da cui non si può pensare estranea. Solo così essa può evitare di imbracarsi in crociate che finiscono per scambiare mulini per giganti. Il primato della dimensione estetica, quella che noi sintetizziamo col termine «bellezza», resta lo spazio in cui, nel modo che per ora è rimasto loro possibile, gli esseri umani continuano a proiettare la loro tensione verso il senso, la trascendenza, l’identità. Che questo avvenga in forma simulativa mi sembra secondario rispetto al fatto che continui a avvenire. Già capire questo consentirebbe di andare oltre semplici considerazioni moralistiche. E anche il problema più specifico dell’«arte» e della famigerata «arte contemporanea», mi sembra più legato al bisogno di «stare» che non a quello di «ripartire». Stare nella propria cultura è la vera condizione perché il vangelo le resti di casa.

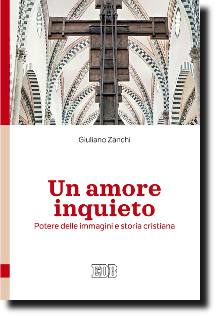





Domande a Spadaro
Settembre 4, 2020 / gpcentofanti
Sull’ultimo numero de La Civiltà Cattolica A. Spadaro edita un suo testo nel quale tratta di una via di riforma ecclesiale centrata su un’autentica crescita personale. Uno stimolo che in ciò viene da papa Francesco consiste nell’apertura ad un discernimento dai contorni non in tutto canalizzati dalle strutture mentali prevalenti. Ho sottolineato altrove che tale fecondo sommovimento, pur con i suoi possibili limiti, può contribuire nel tempo ad aprire per i fedeli un oltre, una strada più semplice e bella (https://gpcentofanti.altervista.org/una-chiesa-famiglia/ ).
Le impalcature di fondo asfittiche ed immutabili del razionalismo non hanno certo aiutato la ricerca di un rinnovamento integrale, fin dalle impostazioni essenziali. Dunque non pare diffusa, nelle gerarchie, una sete di avvicinarsi sempre più al discernere concreto, divino e umano, di Gesù. Anche le succitate strade innovative rischiano in diversi casi di divenire acquisizioni presto assorbite nella precedente staticità.
Qui sta un punto fondamentale di domanda all’intervento di Spadaro. Una scarsa sete di Luce può comportare il restare chiusi nella propria pur innovativa esperienza. Non si ritiene, di fatto, possibile imparare piste nuove e feconde da altri. Si ritiene di poterle imparare casomai da persone catalogate istituzionalmente in base a ruoli e competenze. La prudenza nel non dare adito agli spiriti cattivi di cui tratta il direttore della rivista prevale spesso sull’accoglienza, anche sui media, di voci e stimoli nuovi.
Prima di tutto pare talora carente l’attenzione profonda, integrale, ad ogni specifico uomo, ai suoi bisogni. Permane una mentalità variamente libresca. Lo dimostra in qualche caso l’assenza di problematicità nel considerare questi temi della crescita condivisa, partecipata. Suscita domande su tali scie la poca attenzione, nemmeno nei modi e nei tempi adeguati, allo sviluppo delle identità, senza il quale l’incontro, la solidarietà, rischiano di divenire pensiero astratto, unico, a favore dei pochi ricchi e potenti che sempre più dominano il mondo spogliandolo di tutto.
Le aperture formalistiche facilitano il prevalere di nuovi codici prefabbricati, il favorire con evidenza parti politiche in un’epoca di vuoto assoluto, dando fiato ad un apparato ormai boccheggiante. Mentre si potrebbero aprire vie per una ricerca anche politica più semplice e autentica. Più capace di ascoltare, capire, la gente e di favorirne, fin dalla scuola, la libera maturazione e dunque poi la partecipazione.
Il testo di p. Spadaro pare insomma gettare un qualche parziale seme di novità per qualcuno che creda davvero a quelle parole.