
In fatto di religione, la giurisprudenza costituzionale ha ribadito la pari dignità di diritti anche a coloro che propugnano un credo ateo o agnostico. «La Chiesa, fedele ai suoi doveri verso Dio e verso gli uomini, (…) si sforza di scoprire le ragioni della negazione di Dio che si nascondono nella mente degli atei e, consapevole della gravità delle questioni suscitate dall’ateismo, mossa dal suo amore verso tutti gli uomini, ritiene che esse debbano meritare un esame più serio e più profondo» (Gaudium et spes, 21).
La Costituzione italiana, la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo tutelano, in relazione all’esperienza religiosa, la libertà di coscienza tanto per i credenti quanto per i non credenti, ai quali va riconosciuto il diritto di fare propaganda, nelle forme che ritengono più opportune, delle loro convinzioni.
Il diritto di propaganda e di diffusione del proprio credo religioso o del proprio credo ateo o agnostico non deve, però, tradursi nel vilipendio della fede da altri professata, secondo un accertamento che il giudice di merito è tenuto ad effettuare con rigorosa valutazione delle modalità con le quali si esplica la propaganda o la diffusione.
Il principio della parità di trattamento impone che venga assicurata una forma di uguaglianza tra tutte le forme di religiosità, in esse compreso il credo ateo o agnostico, e la sua violazione integra la discriminazione vietata dalla legge, che si verifica quando, nella comparazione tra due o più soggetti, non necessariamente nello stesso contesto temporale, uno di essi è stato, è, o sarebbe avvantaggiato rispetto all’altro, sia per effetto di una condotta posta in essere direttamente dall’autorità o da privati, sia in conseguenza di un comportamento, in apparenza neutro, ma che abbia comunque una ricaduta negativa per i seguaci della religione discriminata.
Sono tre principi di diritto affermati da una recente ordinanza con la quale la Corte di Cassazione traccia un’approfondita disamina della questione.
La vicenda
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità risale al mese di luglio 2013, allorquando una libera associazione di cittadini, con sede legale in Roma, chiede al Comune di Verona di essere autorizzata all’affissione di alcuni manifesti – sui quali è impresso il logo e la denominazione dell’associazione richiedente – riportanti la parola, a caratteri cubitali, “Dio”, con la lettera “D” cancellata con la classica “X” e le successive lettere “io” in corsivo, seguita dalla frase «10 milioni di italiani vivono bene senza D. E quando sono discriminati, c’è… al loro fianco».
A fronte di tale richiesta, la Giunta comunale esprime il proprio diniego, ritenendo il manifesto «potenzialmente lesivo nei confronti di qualsiasi religione».
L’associazione in questione propone allora ricorso presso il Tribunale di Roma, chiedendo che, previo accertamento del carattere discriminatorio del rifiuto posto dal Comune, quest’ultimo sia condannato alla cessazione della condotta, nonché al risarcimento del danno. Il ricorso viene, però, rigettato e la decisione di primo grado è confermata dalla Corte d’Appello. L’associazione impugna la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, la quale decide utilizzando le argomentazioni sotto sintetizzate.
La giurisprudenza costituzionale
L’articolo 19 della Costituzione riconosce espressamente a tutti la libertà di professione, culto e propaganda religiosa, dovendosi quest’ultima intendere quale forma di manifestazione del pensiero tutelata dal primo comma dell’articolo 21 della Costituzione.
Tali libertà incontrano il proprio unico limite nella contrarietà al buon costume, ovverosia con il comune sentire della collettività sotto il profilo morale in un determinato periodo storico.
Sulla base del combinato delle due norme sopracitate, la Corte Costituzionale, secondo cui «l’ateismo comincia dove finisce la fede religiosa», in passato aveva interpretato la norma limitando il contenuto della libertà di religione al suo “profilo positivo” e, dunque, alla circostanza di avere un credo, ritenendo che l’ateismo fosse del tutto estraneo al principio di cui all’articolo 19 della Costituzione.

In seguito, tuttavia, sulla base della valorizzazione del dettato degli articoli 2 e 3 della Costituzione in relazione alle disposizioni in esame, tale orientamento fu totalmente smentito dalla giurisprudenza costituzionale successiva.
In particolare, si affermò il principio secondo il quale la libertà religiosa rientra nel novero della più ampia libertà di coscienza – da intendersi quale libertà di scegliere il proprio credo, scegliere di modificarlo e scegliere di non averne alcuno – e che la libertà di coscienza in ambito religioso rappresenta uno dei diritti inviolabili dell’uomo, a presidio dei quali è posto l’articolo 2 della Costituzione. Oggetto di tutela è tanto il diritto di credere quanto quello di non credere, poiché il principio di eguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione non tollera alcuna discriminazione (riconoscendo a tutti i cittadini «pari dignità sociale, senza distinzione di religione»).
La normativa europea e internazionale
Alla medesima conclusione circa la necessaria parità di trattamento e tutela da riservare a credenti e non credenti si giunge, volgendo lo sguardo alla normativa europea e internazionale, le cui previsioni pongono vincoli alla legislazione nazionale.
Con riferimento all’ordinamento dell’Unione Europea, va rilevato che l’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea dichiara che «ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione» e che «tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti».
Analoga previsione è contenuta, a livello di normativa internazionale, nell’art. 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo secondo cui «ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui».
Tale principio è ribadito dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, la quale in più occasioni ha affermato che la libertà in esame debba essere riconosciuta ad atei, agnostici, scettici e indifferenti, assicurando a costoro piena parità di trattamento rispetto ai credenti.
L’uguaglianza fra tutte le forme di religiosità, in esse compreso il credo ateo o agnostico, è prevista altresì dalla Direttiva dell’Unione Europea 2000/78/CE del 27 novembre 2000, di diretta applicazione nell’ordinamento, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. La sua violazione integra la discriminazione vietata, che si verifica quando, nella comparazione tra due o più soggetti, non necessariamente nello stesso contesto temporale, uno di essi è stato, è, o sarebbe avvantaggiato rispetto all’altro, sia per effetto di una condotta posta in essere direttamente dall’autorità o da privati, sia in conseguenza di un comportamento, in apparenza neutro, ma che abbia comunque una ricaduta negativa per i seguaci della religione discriminata.
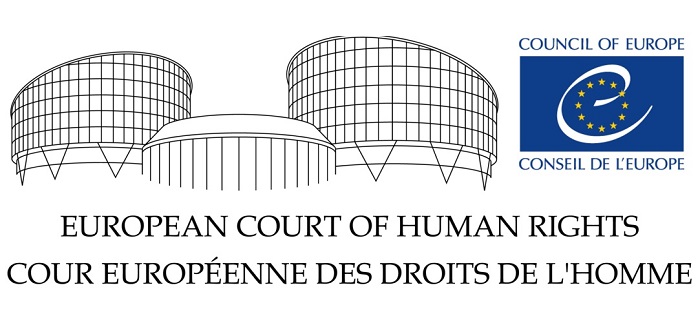
Il principio di laicità dello Stato
Il supremo principio della laicità dello Stato, che trova fondamento negli articoli 7 e 8 della Costituzione e che assurge al rango di «principio supremo», è da intendersi non come indifferenza di fronte all’esperienza religiosa, bensì come salvaguardia in regime di pluralismo confessionale e culturale della libertà di religione, la quale rappresenta un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall’articolo 2 della Costituzione.
Esso, postula, pertanto un atteggiamento dello Stato equidistante e imparziale nei confronti di tutte le confessioni religiose, e la parità nella protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza, e anche se si tratta di una fede esclusivamente laica o agnostica.
Tale principio trova altresì la sua enunciazione nell’articolo 1 del Protocollo addizionale al Concordato tra Stato e Chiesa del 18 febbraio 1984, a tenore del quale «si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano».
Il reato di vilipendio
Una volta identificato, nei termini detti, il contenuto della libertà di religione e della libertà di coscienza, risulta opportuno individuarne i limiti.
La linea di confine di tali libertà è rappresentata dal rispetto della sensibilità religiosa altrui, che non deve mai subire un pregiudizio in conseguenza di un atto di professione o di diffusione di un diverso credo (o non-credo).
In particolare, la pratica e la propaganda religiosa non devono mai sfociare in condotte tali da integrare il reato di vilipendio, previsto e punito dall’articolo 403 del codice penale, che si concreta in un atteggiamento di disprezzo gratuito, in un’offesa chiara e diretta, fine a se stessa, nei confronti degli appartenenti ad una confessione religiosa.
La condotta di vilipendio si connota entro i confini segnati dallo stesso significato etimologico del verbo “tenere a vile”, ossia additare al pubblico disprezzo o dileggio. Il vilipendio alla religione, peraltro, non deve mai essere confuso con la discussione, scientifica o meno, sui temi religiosi, né con la critica, o con l’espressione di dissenso dai valori religiosi per l’adesione ad ideologie atee o di altra natura, ovvero con la confutazione, anche con toni “accesi”, dei dogmi della fede.
In sostanza, in materia religiosa, la critica è lecita quando si traduca nella espressione motivata e consapevole di un apprezzamento diverso e talora antitetico, risultante da una indagine condotta, con serenità di metodo, da persona fornita delle necessarie attitudini e di adeguata preparazione, mentre trasmoda in vilipendio quando, attraverso un giudizio sommario e gratuito, manifesti un atteggiamento di disprezzo verso la religione, disconoscendo all’istituzione e alle sue essenziali componenti (dogmi e riti) le ragioni di valore e di pregio ad essa riconosciute dalla comunità, e diventi una mera offesa fine a se stessa.
La decisione della Corte di Cassazione
Sulla base della ricostruzione suesposta, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ritenuto configurata una discriminazione ai danni dell’associazione. Il contenuto dei manifesti, infatti, riproduceva esclusivamente il convincimento degli associati, senza che ciò si traducesse in un attacco diretto a screditare le diverse confessioni religiose e, pertanto, senza che venissero oltrepassati i confini della libertà di propaganda.

Inoltre, il Tribunale – prima – e la Corte d’Appello – poi – si erano limitati a verificare che, nel medesimo orizzonte temporale in cui era stata negata l’autorizzazione di affiggere i manifesti oggetto di contestazione, il Comune di Verona non avesse concesso una simile opportunità ai seguaci di confessioni religiose portatrici di un credo positivo, senza invece tenere in adeguata considerazione la circostanza che in passato il diritto di propaganda di questi ultimi non avesse mai subìto limitazioni e che, di fatto, tutti gli spazi risultavano ad essi riservati.
Pertanto, poiché il diniego appariva sorretto esclusivamente dalla finalità di impedire la diffusione, peraltro lecita, di un pensiero religioso negativo, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviava il procedimento alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione per risolvere la questione alla luce dei principi di diritto affermati.





