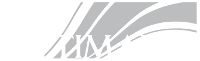Si avvia alla seconda edizione il Corso di Alta Formazione in «Dialogo Interreligioso e Relazioni Internazionali», promosso dall’ISSR «A. Marvelli», delle diocesi di Rimini e di S. Marino-Montefeltro, congiuntamente all’Università degli Studi di San Marino (cf. SettimanaNews). Abbiamo posto alcune domande alla teologa Simona Segoloni Ruta, docente presso il Pontificio istituto teologico Giovanni Paolo II di Roma e vicepresidente del Coordinamento delle teologhe italiane (CTI), che collabora al Corso di Alta Formazione.
- Nella complessità del contesto storico attuale come l’interdisciplinarità metodologica può favorire l’approccio alle questioni del dialogo interreligioso e delle relazioni internazionali intorno alle quali lavorerà il Corso di alta formazione? Qual è, dal suo punto di osservazione privilegiato, il compito specifico che può assumere la teologia nella elaborazione dei processi complessi in seno alle nostre società?
Oramai sappiamo tutti e tutte che la realtà in cui viviamo (e la realtà in genere) è estremamente complessa. Non basta più per comprenderla e per viverci dentro, come ci si poteva illudere fino a un paio di secoli fa, un approccio minimale oppure semplice che tenga conto di una prospettiva sola o che decida di utilizzare solo alcune categorie per interpretare e comprendere e ne scarti altre. Non ci si può illudere più neppure che basti guardare per vedere le cose come stanno, che basti fare quello che si è sempre fatto per fare ciò che è giusto, che basti scegliere solo quelli che pensano come noi, per non doverci porre veramente davanti alle sfide della storia.
Oramai sappiamo che la realtà è complessa e che per affrontare una qualsiasi questione occorre una molteplicità di prospettive e anche una molteplicità di competenze. Per questo motivo, ogni problema chiede interdisciplinarietà e intradisciplinarietà, chiede cioè che lo stesso oggetto sia guardato secondo l’angolo prospettico di differenti discipline e che i risultati di ciascuna indagine siano assunti dalle altre discipline come provocazione e dato da considerare.
Ogni indagine, col suo metodo e le sue domande, può illuminare solo un angolo del reale, ma questo non può restare sconosciuto o marginale per le altre indagini, che pure avranno metodo e domande propri. Ciascuna prospettiva così, pur procedendo autonomamente e specificamente, viene illuminata e arricchita dai risultati delle altre che la aprono a nuove domande o le offrono nuovi dati di partenza.
Già questo sarebbe sufficiente per dire come il Corso di alta formazione dell’ISSR di Rimini, proprio per l’approccio scelto, sia importante, ma se poi si considera il tema in oggetto, cioè il dialogo interreligioso e le relazioni internazionali, per di più in un momento come il nostro in cui questi sembrano gettati nel caos, allora si deve constatare che si tenta un’avventura intellettuale indispensabile (quella della interdisciplinarietà) su un tema drasticamente complesso quanto fondamentale per la pace, la cooperazione fra i popoli, la stessa sopravvivenza.
La teologia, che pure nel panorama accademico italiano non compare e non viene considerata come strumento critico e conoscitivo, ha invece la grande capacità di interrogare il vissuto umano e di interpretare specificamente i vissuti religiosi, con i loro simboli e le loro pratiche, affatto secondari per la comprensione fra i popoli e anche per la purificazione di interpretazioni violente e inique delle tradizioni religiose. Senza un approccio teologico, la religione apparirà o folklore o verità assoluta in mano ad alcuni, irrilevante per i primi, non indagabile per i secondi. In questo modo tutte le dinamiche religiose resteranno non comprese e non criticamente vagliate e in questa condizione non è possibile né un dialogo interreligioso né solide e feconde relazioni internazionali.
A queste sfide, il Corso di alta formazione aggiunge quella della lettura di genere, continuando il dialogo e la collaborazione con il Coordinamento delle teologhe italiane. Le differenti prospettive non entrano in gioco solo quando si hanno diverse discipline, ma anche quando si guarda la realtà da due posizioni diverse, con due orizzonti diversi, come accade quando le donne guardano una realtà che normalmente le esclude, non le nomina, le marginalizza o le considera irrilevanti.
Scoprire che non esiste un pensiero neutro in termini di genere, ma che c’è sempre un punto di partenza e anche la decisione o meno di considerare il proprio punto di partenza come parziale, è una marcia in più per la comprensione dei problemi del dialogo interreligioso e delle relazioni internazionali, perché alle donne non tocca la stessa sorte degli uomini in nessuna delle esperienze umane e avere il coraggio di mettere a tema criticamente anche questi aspetti può avere solo il vantaggio di arricchire la comprensione di ciò che indaga.
- Altra tematica di rilievo ci pare l’educazione alla cultura della pace e del dialogo interreligioso. Come creare, o ampliare, una prospettiva culturale in grado di formare criticamente le coscienze non in direzione sincretista, ma secondo un orientamento e uno sguardo aperti e tesi a cogliere il tesoro di sapienza custodito presso altre tradizioni religiose e culturali? E, in questa direzione, quali potenzialità può esprimere il coinvolgimento del Coordinamento delle Teologhe italiane?
Formare criticamente le coscienze all’incontro, al dialogo, alla convivenza, è la chiave – mi sembra abbastanza evidente – per costruire una cultura di pace e quindi una prassi di pace su piccola, come su larga scala. Sono le ben venute dunque tutte quelle istituzioni o tutte quelle iniziative dove sia possibile formarsi in questo senso e mi pare che il Corso di alta formazione possa essere una di queste iniziative.
Formare una coscienza non è una questione da poco e allo stesso tempo non è qualcosa che può essere fatto con i mezzi di comunicazione di massa: ciascuna persona ha bisogno di cura per poter crescere e formarsi a valori così complessi e ricchi quali sono quelli che soggiacciono ad una cultura della pace. Ciascuno ha bisogno di tempo, di accompagnamento, di stimoli, di riflessione: di una scuola. In questo senso ovviamente devono lavorare in modo generale tutte le istituzioni educative, ma non possono che essere meritorie quelle iniziative che mettono in campo competenze specifiche, approcci interdisciplinari, ambiti di ricerca e di insegnamento dedicati al dialogo e alle relazioni.
Credo dunque che certamente un Corso come quello che stiamo presentando possa avere l’ambizione di contribuire ad una cultura della pace, attingendo in modo specifico ai tesori che le tradizioni religiose possiedono in ordine all’amore reciproco, all’armonia con il creato e alla pace fra popoli e persone.
Diversamente da quanto infatti molte volte si pensa, le religioni non sono foriere di guerra e inimicizie. Queste sono state scatenate spesso sotto copertura religiosa, ma con ben altri fini. Recuperare la sapienza pacifica di chi fa esperienza di Dio, dunque, aiuterebbe a purificare alcune interpretazioni religiose inaccettabili, ma anche ad istruirsi a logiche nuove di convivenza radicate in antichi vissuti e antichi insegnamenti.
Il coinvolgimento del CTI in tutto questo appare assolutamente opportuno. La pace infatti è da sempre un tema caro alla teologia femminista e alla teologia delle donne. Anche l’ultimo corso on line del CTI è stato dedicato a questo tema. Sempre le teologhe hanno tentato di discernere nella propria tradizione le logiche pacifiche, inclusive, relazionali, da quelle violente, escludenti e gerarchiche, per dichiarare poi con forza che il Dio dei Vangeli è il Dio della vita, della pace, dei legami.
- Le istanze di complessità e pluralismo proprie del nostro tempo sono una sfida alla quale il Corso di alta formazione intende rispondere. Sarà in grado di svolgere costruttivamente l’inaggirabile interconnessione dei piani e degli elementi in gioco? E, in questa prospettiva, il percorso sinodale della Chiesa cattolica, che lei sta seguendo come studiosa, può fornire metodi strumenti linguaggi, insieme a una più acuta e aggiornata sensibilità ecclesiale, a favore di un ascolto attivo dello Spirito e della sua azione creativa, anche all’interno delle diverse fedi?
Se l’intento di cui già ho provato a dire raggiugerà i suoi scopi è difficile a dirsi. Le sfide sono davvero impegnative, ma è anche vero che strumenti e metodo sono stati pensati adeguatamente e quindi si può sperare nel risultato. Questo credo valga anche per il Sinodo. Abbiamo avviato un processo cui non siamo abituati e cui non mancano resistenze, ma il processo è valido. Ha portato alla luce molti problemi, fatto emergere snodi cruciali per il futuro della chiesa, dato voce a sofferenze e contraddizioni. E – cosa di non poco conto – si è cominciato a capire che per decidere secondo lo Spirito non basta la decisione di uno, ma serve il consenso di molti e molte: un consenso non costruito sull’opportunità di gruppi più o meno influenti, ma tessuto nella fatica, nell’ascolto reciproco, nella trasparenza di esporsi e nel coraggio di cercare decisioni e vie non comode, capaci di fare il bene di tutta la chiesa.
Questo percorso è una palestra indispensabile per incontrare altri esseri umani e credenti di altre fedi. Se non sappiamo stimarci, ascoltarci, trovare punti di consenso, nemmeno fra di noi, come potremo esserne capaci con chi vive una fede altra o ha una cultura altra? Per questo il Sinodo sulla sinodalità può significare per la chiesa non solo un avvio di riforma, ma anche un cambiamento di stile, perché, una volta imparate, certe pratiche possono essere riutilizzate in molti luoghi diversi, generando incontro e relazioni vivificanti. Certo tutto questo viene frenato, quando non impedito, se non si riesce a riconoscere il valore delle voci che fino ad ora abbiamo escluso: paesi di culture non occidentali, poveri, etnie non bianche, donne.
Per evitarlo e per mettere quanto più a frutto il processo sinodale, il Corso di Alta formazione può essere un contributo, qualificato e intelligente, un laboratorio in cui criticamente approcciare temi e questioni per imparare l’arte delle tessiture e raccogliere così i frutti di pace delle tradizioni religiose. Almeno questo è l’intento.