
Sabato mattina ad Ankara è ufficialmente iniziato il terzo mandato presidenziale di Recep Tayyp Erdoğan. Dopo il giuramento, ha reso onore, come consuetudine, al mausoleo di Ataturk e portato l’omaggio, ormai tradizionale, alla Repubblica turco cipriota − riconosciuta solo dalla Turchia e dal benevolo Azerbaijan − con volo diretto sul versante turco di Nicosia: questi gli atti formali.
Gli ospiti
Dentro gli stessi, molto più sostanziali e significative sono risultate le presenze straniere. Già da sé dicono molto: il presidente venezuelano Nicolás Maduro, il primo ministro ungherese Viktor Orban, il presidente azero Ilham Aliyev, quello armeno Nicole Pashinian − segnale importantissimo −, il primo vicepresidente iraniano Mohammad Mokhber, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg accompagnato dall’ex primo ministro svedese Carl Bildt, molto apprezzato in Turchia. Putin ha mandato lo speaker della Duma, Vyacheslav Volodin.
L’opzione turcofona si è dunque manifestata con la presenza del leader azero, quella del nuovo espansionismo pan-nazionalista con le presenze russa e iraniana. Mentre Stoltemberg e Bildt hanno rappresentato la terza gamba della politica turca, dovendo parlare con Erdoğan dell’ingresso della Svezia nella NATO, chiave del rapporto con l’Occidente, non più fondato sul principio di fedeltà a priori, bensì sulla interlocuzione sempre aperta.
La scelta dell’armeno Pashnian, indica poi la pista di una normalizzazione col vicino armeno: ipotesi lontana, ma probabilmente non impossibile. Tutte le direttrici della politica internazionale di Erdoğan e del suo nuovo governo sono state dunque ben rappresentate.
Gli sponsor
L’assenza di nomi di spicco in caratteri arabi non toglie, tuttavia, che la quarta faccia del nuovo corso − una volta risolta la disputa con Riad con l’archiviazione del processo in Turchia per l’assassinio nel consolato di Istanbul del giornalista saudita-americano Jamal Khasshoggi − comprenda la relazione col giovane principe saudita Muhammad bin Salman, mandante del crimine.
I cinque miliardi di dollari che, dopo Mosca, anche Riad ha versato nelle casse della banca centrale turca per consentire a Erdoğan di elargire prebende prima del voto − forse decisive per la vittoria in un Paese economicamente in ginocchio e straziato dal terremoto − hanno prodotto, nei giorni scorsi, il primo sviluppo di gratitudine: una fitta schiera di imprenditori turchi si è già recata a Riad promettendo ingenti investimenti nei nuovi progetti di sviluppo sauditi.
Riad ha peraltro prontamente presentato la visita quale ingresso degli uomini d’affari turchi nel salotto buono del gigante saudita Aramco, a caccia di partner in tutto il mondo. A Riad si è parlato di pipe-line, di treni veloci e altro, per un valore complessivo di 50 miliardi di dollari.
Il nuovo – quanto collaudato – corso di Erdoğan vuol fare inoltre della Turchia la porta aperta dell’aggiramento delle sanzioni occidentali alla Russia. Questo è sicuro: il presidente sa bene che, per puntellare la sua moribonda economia nazionale, ha bisogno di tutti i traffici – più o meno legali – con una nutrita schiera di «amici».
Tanto che molti scommettono pure sul buon esito della missione del segretario generale della NATO che è alla ricerca del disco verde turco all’ingresso della Svezia, magari in cambio degli agognati F-16 (nonostante la stampa locale sappia delle resistenze del Congresso americano).
La situazione interna e la religione
È dunque un Erdoğan allenato a giocare a tutto campo quello che si è presentato ai turchi e al mondo intero, attore globale con le mani libere, proprio come l’ex nemico e nuovo amico bin Salman. Ankara ha l’inflazione alle stelle e il popolo alla fame: il leader sa che, per la sua agenda interna, è fondamentale rastrellare aiuti da tutte le parti, dando tuttavia soddisfazione all’orgoglio nazionale della Turchia, esibito quale protagonista globale, mentre elargisce solo piccole prebende.
Il tratto dell’orgoglio nazionale e nazionalista − visto dal punto di vista turco piuttosto che occidentale − collega Erdoğan ad Ataturk. La divisione non è più tra laici e islamici, perché il nuovo leader – sempre lo stesso da 20 anni − parla come il vecchio leader all’orgoglio nazionale, con la stessa lingua, sebbene con accento diverso.
Come la Turchia dei pogrom e dei golpe potesse essere ritenuta laica è cosa assai strana, così come è assai strano che possa essere ritenuta panislamica sunnita una Turchia ormai nazionalista, come questa di Erdoğan.
La politica «religiosa» con il nuovo corso cambierà? Non penso. Se Ataturk voleva nazionalizzare la religione, con l’invenzione di un ministero del culto che controllasse cosa si diceva nelle moschee di Allah circa il «padre dei turchi», così Erdoğan vuole islamizzare lo Stato, facendo di sé stesso il nuovo «padre dei turchi», il vero volto dell’islam turco, sempre più assente dal dibattito islamico globale e privo di teologi di spicco, salvo ovviamente lui, il «padre musulmano della nazione turca».
Si consideri la formula che ha usato per il giuramento: «Come presidente, giuro sul mio onore e sulla mia integrità, davanti alla grande nazione turca, di lavorare con tutto il mio potere per proteggere l’esistenza e l’indipendenza dello Stato e di adempiere al mio dovere in modo imparziale», usando in queste ultime parole la formula di rito.
L’altro ruolo che il presidente assegna alla religione è quello della conservazione sociale, dimostrato dagli spietati e rozzi attacchi alla comunità LGBT, cruciali per un leader che ritiene il paternalismo autoritario prerogativa della Stato e quindi di sé stesso. È chiaro che, in questo quadro, le altre religioni possono figurare agli occhi di Erdoğan come minoranze da proteggere, come ai tempi del Sultano, ma poco più.
L’opposizione
Ma la domanda politica più rilevante − per immaginare il futuro in Turchia − riguarda ora l’opposizione guidata da Kemal Kiliçdaroğlu che ha, sì, perso ma con un ragguardevole 47% dei voti al ballottaggio.
La coalizione delle sei forze eterogenee che lo hanno sostenuto − con l’apporto esterno dei curdi decisivi in tanti collegi, ma non ammessi al centro dell’alleanza perché incompatibili con i nazionalisti di destra che pure vi siedono − reggerà? Sembrerebbe impossibile, ma è troppo presto per dirlo.
Il campo critico a cui guardare è ancora, comunque, quello curdo: vi si gioca ora una partita decisiva. Condannato in un processo farsa allestito dallo stesso Erodğan, il leader della vera forza politica curda turca, Selahettin Demitras, ha fatto sapere a sorpresa che lascerà la politica attiva, pur restando nel partito. Ha lasciato intendere di ritenere un errore non aver presentato un candidato curdo alla presidenza.
Il ragionamento è semplice: il suo partito, HDP, ha sostenuto il candidato dell’opposizione Kemal Kiliçdaroğlu, ma molti turchi non curdi hanno così scelto di abbandonare l’HDP e di votare direttamente per il partito di Kemal Kiliçdaroğlu, togliendo forza alla novità politica del partito turco e curdo − quindi nazionale, non etnico − che Demitras aveva posto al centro della vita politica.
Con una candidatura del suo partito, HDP, avrebbe rafforzato la novità, non avrebbe perso voti e avrebbe potuto negoziare con la coalizione di opposizione un accordo in vista del ballottaggio, evitando di lasciarla in balia dell’estrema destra nazionalista, come è accaduto. Il Partito della Vittoria ha appoggiato Kemal Kiliçdaroğlu al ballottaggio, ma ottenendo in cambio termini insultanti verso i curdi e gli esuli siriani presenti in Turchia.
Ora i curdi devono decidere cosa fare. Il PKK − che ha dato pure indicazione di voto per Kemal Kiliçdaroğlu già dal primo turno −, secondo alcuni analisti, potrebbe riprendere le sue azioni militari in Turchia, pensando in tal modo di costringere Erdoğan a un nuovo negoziato con il suo storico nemico, Öcalan, tuttora detenuto. Nella logica di Erdoğan, altri attentati del PKK potrebbero tornare molto utili, per continuare a sostenere che i curdi erano e sono sempre «terroristi». D’altro canto, però, i curdi del PKK hanno un altro modo per dimostrare di esistere?
Trattare con Erdoğan sarebbe comunque la scelta più sensata per loro come per l’HDP di Demitras. In questa contingenza, riottenere il governo di alcune città curde commissariate dal governo sarebbe la contropartita più importante in vista del voto amministrativo del prossimo anno. Ma Erdoğan vorrà? Ci penserà: potrebbe aiutarlo a rendere più pacifico il Paese che lui governa con una economia al disastro.
Il nodo della crisi
Molto dipenderà da come andranno le cose nel nord della Siria, ove si trova il vero punto di crisi di Erdoğan. I gruppi estremisti da lui foraggiati da anni, a cominciare dagli ex qaidisti di Abu Muhammad Joulani, avversano l’intesa con Assad che il presidente turco sta perseguendo con i buoni uffici di Putin.
Questa servirebbe a Erdoğan per liberarsi di qualche milione di esuli siriani deportati dalla Siria e che ora non vorrebbe più vedere, per via della crisi economica che attanaglia il Paese e il successo che sta riscuotendo la xenofobia. Ma se le milizie da lui stesso armate nel nord della Siria gli renderanno impossibile l’accordo sulla testa dei siriani, Erdoğan si troverà ben presto nei pasticci.
Ecco che un accordo − almeno con i curdi dell’HDP − potrebbe aiutarlo. Ma il funambolico Erdoğan sta coltivando un altro sogno: far emergere il nuovo gruppo curdo, Huda-Par, come suo alleato di estrema destra. Poiché questi curdi rivolgono i loro coltelli contro i curdi di Demitras, nessuno, in Turchia, li chiama «terroristi».
Saranno questi l’arma segreta di Erdoğan per scompaginare i curdi? Elettoralmente Huda-Par conta pochissimo, ha ottenuto appena lo 0,3% dei voti. Ma se Erdoğan li inserirà nelle municipalità curde commissariate dal governo presto ne potremmo sentir parlare, molto di più del poco che si senta dire di loro oggi.


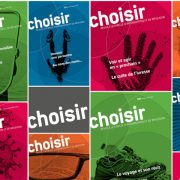



Mentre le pressioni di Erdogan influenzano l’agire politico sia della Svezia che dell’Iraq, in Rojava le milizie filo turche incendiano i raccolti. Curdi quindi sempre sotto tiro, ma anche sempre indomiti. Per quanto “senza altri amici che le Montagne”.
I CURDI, UNA STORIA DI RESISTENZA
Gianni Sartori
Curdi sempre all’ordine del giorno. Anche se talvolta – penso – ne farebberopure a meno.
Nell’indifferenza (eufemismo) di cancellerie e media (in buona parte almeno) occidentali che proprio non sembrano vedere, rendersi conto del dramma che si va compiendo ai danni di questo popolo coraggioso.
D’altra parte, di questi tempi poi, nessuno sembra voler mettersi a discutere con Erdogan & C.
Ma i curdi resistono e con loro anche qualche residua minoranza non omologata, ancora disinteressatamente solidale.
A Stoccolma nel pomeriggio di domenica 4 giugno si è svolta una manifestazione, a cui hanno preso parte centinaia di persone, indetta per dire “NO alla Nato e alle leggi di Erdogan in Svezia”. Ossia contro l’inasprimento legislativo (entrato in vigore da circa una settimana), sostanzialmente un modo per assecondare le richieste del neoeletto presidente turco Recep Tayyip Erdoğan.
E con cui si finirà per far pagare ai curdi (sia con la repressione, sia con le estradizioni) l’entrata della Svezia nell’Alleanza atlantica.
Tra gli organizzatori, la rete “Alleanza contro la Nato” (NEJ TILL NATO), varie organizzazioni curde, gruppi femministi, movimenti di sinistra e per la giustizia climatica. Da segnalare, oltre a qualche organizzazione per la difesa dei Diritti umani, la presenza di alcuni intellettuali e di esponenti politici.
Con le nuove norme vengono inasprite le pene per la partecipazione, la promozione e il sostegno a quella che viene considerata un’organizzazione terrorista (sostanzialmente il PKK, ma la legislazione finirebbe per colpire anche dissidenti e oppositori politici), sia in patria che all’estero. Con pene previste fino a cinque anni.
Per Erdogan finora la Svezia avrebbe appunto offerto asilo a quelli che in Turchia vengono considerati “terroristi”, sia membri del PKK (veri o presunti), sia esponenti dell’opposizione politica curda.
Da ciò il suo veto all’ingresso della Svezia nella Nato (come il Paese scandinavo aveva chiesto ancora l’anno scorso).
Intanto in Bashur (il Kurdistan entro i confini iracheni) si va allentando l’assedio dei militari iracheni al campo per rifugiati di Makhmour. Stando alle dichiarazioni di Yusuf Kara, copresidente dell’Assemblea del campo, il ritiro sarebbe già stato completato.
Dopo 16 giorni di assedio e altrettanti di resistenza popolare e grazie agli accordi presi congiuntamente nei negoziati che si sono svolti a Bagdad.
Qualcosa del genere era già accaduto nel 2021 (con chiusura degli accessi e barriere di filo spinato intorno al campo), quando Barzani (presidente del PDK, partito curdo considerato “moderato” da alcuni e “collaborazionista” da altri) aveva sottostato al volere di Ankara. Così allora come in questi giorni, il fine nemmeno tanto celato sarebbe quello di costringere gli abitanti del campo all’evacuazione. Nonostante non si siano resi responsabili di nessuna violazione della legge irachena.
Intanto in Rojava, ancora una volta e non casualmente nella stagione del raccolto, diversi incendi dolosi sono scoppiati nei campi dove il grano è ormai maturo.
Da manuale: incendiare i raccolti – così come “avvelenare i pozzi” – rientra nei metodi delle “guerre a bassa intensità”. In Rojava, relativamente bassa comunque.
In genere la Turchia ricorre al bombardamento con cannoni e mortai, oppure al sabotaggio per mano di incendiari prezzolati che appiccano il fuoco direttamente alle coltivazioni. Alcuni di loro sono stati catturati dalle forze di sicurezza curde e – oltre a telefoni e carte SIM fornite direttamente da una rete turca – erano in possesso anche delle coordinate delle principali fattorie.
Ovviamente quella che viene messa in serio pericolo è la sicurezza alimentare delle popolazioni locali.
Un ulteriore tentativo (cos’ come per Makhmou) per sradicarle, costringerle ad andarsene, a trasformarsi in sfollati, profughi
Gianni Sartori.