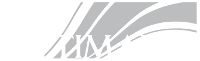L’ondata di decreti esecutivi con cui Trump ha iniziato il suo secondo mandato presidenziale è stata un’abile messa in scena dell’efficacia emotiva e comunicativa della sua retorica. Due temi toccano l’anima profonda di quello che sono gli Stati Uniti: quello della cittadinanza e quello della immigrazione – o, meglio, della sua repressione. La Nazione americana si è costruita anche sulla forza, lavoro e intellettuale, che le è stata offerta dagli immigrati provenienti da altri paesi.
Trattandosi di un fenomeno che può intersecarsi con la politica estera, la diplomazia o la sicurezza nazionale, una serie di sentenze della Corte suprema lasciano ampio spazio di manovra al potere esecutivo americano nella gestione dei fenomeni migratori e nel disegnare politiche in merito.[1] Latitudine che è stata usata in passato generalmente per controllare l’ingresso dei migranti all’interno degli Stati Uniti – con misure che andavano da quote annuali di migranti all’esclusione di persone che provenivano da determinate aree del mondo (a cavallo tra XIX e XX secolo questo riguardava soprattutto le popolazioni asiatiche).
L’ampiezza di azione concessa all’esecutivo dalla Corte Suprema non significa però avere carta bianca: il Congresso, in primo luogo, e poi i cittadini attraverso pratiche legali, possono giocare il loro ruolo nel determinare alcuni limiti al potere esecutivo anche in materia di immigrazione.
La cittadinanza
Più delicata, dal punto di vista legale, è la questione della «limitazione» dell’applicazione dello ius soli per quanto riguarda il riconoscimento della cittadinanza a chi nasce all’interno degli Stati Uniti. Più delicata perché si tratta di materia costituzionale: ancorata nel 14mo emendamento (1868), che fu un primo passo in direzione del riconoscimento dei diritti civili degli afro-americani.
Il primo articolo dell’emendamento afferma che «tutte le persone naturalizzate o nate negli Stati Uniti, e soggette alla sua giurisdizione, sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato dove risiedono. Nessuno Stato deve emanare o applicare qualsiasi legge che possa diminuire i privilegi o le immunità dei cittadini degli Stati Uniti; nessuno Stato può deprivare qualsiasi persona della vita, della libertà o della proprietà senza un regolare procedimento giuridico; né può negare a qualsiasi persona che si trova all’interno della sua giurisdizione l’uguale protezione del diritto».
La plausibilità costituzionale del decreto esecutivo in materia firmato da Trump è legata alla interpretazione della congiunzione «e» che lega lo ius soli alla giurisdizione degli Stati Uniti. Dalla fine del XIX secolo, la Corte Suprema ha sistematicamente applicato una interpretazione di tipo esplicativo (il fatto di essere nati negli Stati Uniti implica, ipso facto, il trovarsi sotto la sua giurisdizione). Il decreto immagina la possibilità di una funzione aggiuntiva: non basta essere nati negli Stati Uniti ma, ivi nascendo, bisogna avere uno status legale che pone il nascituro sotto la sua giurisdizione – di cui non godrebbero i figli degli immigrati irregolari.
Al momento attuale, stante anche la coerenza di più di un secolo di giurisdizione della Corte Suprema, le possibilità che il decreto esecutivo sulla cittadinanza firmato da Trump possa trovare il favore della maggioranza dei giudici della Corte sono minime, se non nulle.
Ma di questo la nuova amministrazione americana è ben consapevole. Paradossalmente, il decreto esecutivo sulla cittadinanza non mira a ottenere effetti a breve termine, che sarebbe la sua funzione legale, quanto piuttosto a gettare un’ombra a lungo termine su un’assodata pratica costituzionale del paese. Così facendo, la possibilità di una limitazione dello ius soli entra nel dibattito pubblico, occupa le menti delle persone, e può arrivare a creare le condizioni di un cambiamento della interpretazione del 14mo emendamento anche all’interno della Corte Suprema.
Cambiamento che andrà accompagnato, o favorito, da una opportuna selezione dei prossimi giudici della Corte stessa. Cosa, questa, che tocca uno degli snodi decisivi dell’ordinamento democratico: ossia, quello di una effettiva ed efficace separazione dei poteri. Ma l’effettiva indipendenza e autonomia del potere giudiziario, in particolare della Corte Suprema, è affidata, dopo la scelta da parte del potere esecutivo, al Congresso – è quindi nella delicata congiunzione fra legislativo ed esecutivo che si gioca la possibilità della salvaguardia non solo dell’indipendenza del potere giudiziario, ma anche di un corretto ordinamento democratico.
Non è solo questione di politicizzazione della Corte Suprema, ma più a fondo di una sempre più evidente allergia verso la limitazione del potere esecutivo da parte di quello giudiziario – che spinge a trovare vie per una sua sottomissione al primo, ossia a disattivarlo quale garanzia del mantenimento della democrazia stessa.
Immigrazione: Amministrazione Trump vs. Chiesa cattolica
Che il carattere repressivo delle politiche di Trump nei confronti degli immigrati irregolari producesse una reazione critica da parte della Chiesa cattolica, era cosa facilmente immaginabile. Il 22 gennaio ha preso la parola il presidente della Conferenza episcopale americana, mons. T. Broglio, affermando che alcuni dei decreti esecutivi, compresi alcuni che riguardano l’immigrazione, «sono profondamente problematici e avranno conseguenze negative, che riguarderanno soprattutto quelli fra noi che sono più vulnerabili».
Sempre il 22 gennaio è intervenuto anche il presidente della Commissione per le migrazioni della Conferenza episcopale americana, mons. M. Seitz vescovo di El Paso (Texas). Pur riconoscendo il diritto di un paese alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, Seitz ha affermato che i vescovi e i cattolici non «possono tollerare alcuna ingiustizia, e sottolineiamo che un interesse nazionale egoistico non giustifica politiche le cui conseguenze sono contrarie alla legge morale (…). L’uso di generalizzazioni indiscriminate per denigrare qualsiasi gruppo di persone, come il descrivere tutti gli immigrati senza documentazione quali “criminali” o “invasori”, per privarli della protezione del diritto, è un affronto a Dio, che ha creato oguno di noi a sua immagine».
La replica da parte dell’amministrazione Trump non si è fatta attendere. Il 26 gennaio, in un’intervista sulle politiche riguardanti l’immigrazione, il vice-presidente JD. Vance, nella quale si presentava come «devoto cattolico», ha messo in dubbio la ragione ultima della posizione presa dai vescovi della sua Chiesa.[2] La preoccupazione manifestata dai vescovi cattolici americani non sarebbe mossa da motivi umanitari ma pecuniari: ossia, dal vedersi tagliare i fondi federali che vengono concessi ad enti cattolici che operano per provvedere ai bisogni degli immigrati legalmente presenti sul territorio americano.
Tra le righe dei decreti esecutivi in materia di immigrazione viene sospesa una procedura introdotta dall’amministrazione Biden: quella che impediva dei raid o l’applicazione di misure di sicurezza in luoghi sensibili come le scuole, i luoghi di culto, gli ospedali, le sedi di enti caritativi – tranne nel caso della presenza di persone pericolose o di criminali. Posto davanti alla domanda diretta se egli fosse a favore di una simile misura, Vance ha detto di esserlo certamente se nei luoghi sensibili «vi fosse una persona dichiarata colpevole di un crimine violento» – fatto, però, già contemplato dalle procedure precedenti all’amministrazione Trump. Se così stessero effettivamente le cose, non si darebbe ragione per la loro sospensione totale provocata dai nuovi decreti esecutivi.
Denigrazione e contraddizione sono quindi gli strumenti usati da Vance nella sua prima diatriba con i vescovi cattolici – indicati anche come gruppo carente, se non di impedimento, nel realizzare quello per cui il popolo americano ha votato. Insomma, ha detto Vance, «spero, come cattolico devoto, che i vescovi facciano meglio». Le attese devote di Vance vanno, dunque, nella direzione di un allineamento totale e silente dei vescovi con l’amministrazione Trump.
Allineamento che ha trovato la sua rappresentanza nella preghiera di invocazione del card. T. Dolan, arcivescovo di New York, in occasione della cerimonia di inaugurazione del mandato presidenziale di Trump. Diversa sembra però essere la visione di papa Francesco per ciò che concerne la Chiesa cattolica negli Stati Uniti. La nomina del card. R. McElroy ad arcivescovo di Washington[3] va, infatti, in una direzione opposta a quella auspicata dal vice-presidente Vance: non una Chiesa accondiscendente alle politiche dell’amministrazione Trump, quanto piuttosto capace di far sentire la sua voce anche quando questo significa entrare in conflitto con essa.
Il curriculum di McElory non lo pone sulla linea di Francesco solo per quanto riguarda gli immigrati o la realizzazione di un’effettiva sinodalità della comunità ecclesiale, ma anche sul versante di una convinta salvaguardia degli istituti della democrazia come forma di governo della vita associata. La distanza odierna del papa da quello che fu il sospetto vaticano di inizio XX secolo sull’«americanismo» del cattolicesimo statunitense, troppo prono a sposare i processi democratici della Nazione, diventa evidente e palpabile proprio nella persona che ha scelto per guidare la diocesi della capitale americana.
Con il paradosso che oggi, al contrario di ieri, l’appoggio convinto alla virtuosità iscritta nella democrazia viene dal pontefice romano e non dai vescovi americani.
La retorica di Trump e i suoi costi
In un articolo pubblicato il 21 gennaio su America, il direttore della rivista gesuita Sam Sawyer ha posto il problema politico di trovare vie efficaci per confrontarsi con la retorica del «buon senso» di Trump.[4] Lo stile oratorio di Trump è quello di affermare che «vi sono risposte ovvie, di buon senso, per tutti i problemi che affliggono l’America. Le soluzioni si daranno immediatamente, spinte dalla rinnovata credenza nell’eccezionalismo americano che ci condurrà a “vincere come mai prima” sotto la guida di Trump (…). Trump non riconosce mai che le sue scelte politiche potrebbero comportare dei rischi o avere dei costi (…)» per i cittadini americani.
L’imposizione di dazi farà aumentare il prezzo dei beni importati, costo che ricadrà inevitabilmente sul consumatore-cittadino statunitense. L’uso interno dei militari, vera linea di frattura con il governo della Nazione fino a ora, non solo chiede di distogliere truppe da zone di interesse strategico per gli Stati Uniti, ma implica anche il reperimento dei fondi per utilizzarle in questo modo inusuale.
La cancellazione dello ius soli per i figli di immigrati irregolari, sospesa pochi giorni dopo la firma del decreto esecutivo da parte di un giudice federale di Seattle, rischia di sfornare una quantità notevole di apolidi senza diritto di cittadinanza in nessun paese – neanche quello di provenienza dei genitori se questo, come nel caso del Messico, contempla una cittadinanza legata al luogo di nascita e non allo ius sanguinis.
L’immigrazione illegale negli Stati Uniti trova uno dei suoi motori principali nel fatto che le persone prive della necessaria documentazione possono trovare facilmente collocazione sul mercato del lavoro americano: vengono pagati meno e non devono godere delle già scarse tutele legate ad assunzioni regolari da parte dei datori di lavoro. Il problema dell’immigrazione illegale andrebbe, dunque, affrontato non solo attraverso deportazioni di massa, ma anche intervenendo alla radice dell’impiego di immigrati senza documenti nel mondo del lavoro della Nazione – cosa che Trump si guarda bene dal fare.
Il sogno di una deportazione totale degli 11 milioni di immigrati irregolari metterebbe in ginocchio tutta l’industria alimentare del paese, accanto a quella della ristorazione. Con una conseguente esplosione dei prezzi dei beni di prima necessità, che si riverserebbe ancora (anche) su coloro che hanno votato per Trump.
Dietro la retorica dell’ovvietà e del buon senso si cela, quindi, un immenso non detto che dovrà essere pagato dalla popolazione americana e che produrrà un incremento della povertà e dell’alienazione di ampie fette della cittadinanza. Si tratta, però, di una retorica vincente – almeno a livello elettorale e di costruzione del consenso. Retorica a cui è difficile controbattere, perché smascherarne il non detto non fa altro che alimentare la strategia di semplificazione e dell’uso del buon senso di cui essa è diventata abile stratega.
Ma vi è un’altra conseguenza, che incide sull’architettura stessa dell’ordinamento democratico, legata alla riuscita della retorica di Trump: quella di rendere del tutto irrilevante la necessità di ogni argomentazione, di ogni apprendimento, di ogni strategia a lungo termine. La consunzione della democrazia inizia propria da qua: quando la cittadinanza si schiera una parte contro l’altra, senza sentire il dovere di dare ragione delle proprie posizioni – in questo modo, è la passione per il bene comune, quello che unisce maggioranza e minoranza, che va del tutto smarrito. E con esso la faticosa avventura della democrazia.
[1] Verfassungsblog: Five Question to Amanda Frost (https://verfassungsblog.de/the-use-of-the-military-is-a-real-sea-change-in-policy/).
[2] America: Vance Spars with US Bishops (https://www.americamagazine.org/politics-society/2025/01/26/vance-bishops-trump-immigration-policy-migrants-humanitarian-assistance).
[3] Commonweal: A Serious Man (https://www.commonwealmagazine.org/mcelroy-dolan-robert-francis-trump-catholic-preziosi).
[4] America: The Problem with Donald Trump’s “common sense” Approach to America’s Problems (https://www.americamagazine.org/politics-society/2025/01/21/trump-inauguration-common-sense-249752).