
Non capita tutti i giorni che termini di teologia morale come quello dell’ordo amoris entrino nel ciclo delle notizie statunitensi, ma viviamo in tempi straordinari. In una recente intervista rilasciata a Fox News, il vicepresidente JD Vance ha invocato la tradizionale nozione teologica dell’ordine dell’amore per giustificare l’aggressiva cancellazione o sospensione da parte dell’amministrazione Trump di quasi tutti i programmi di aiuti esteri degli Stati Uniti. Altri commentatori, tra cui il redattore di First Things R.R. Reno, hanno pubblicamente appoggiato il modo in cui Vance ha ridimensionato le nostre responsabilità morali.
Vance ha sostenuto che l’amministrazione Trump sta seguendo la “visione cristiana” delle nostre responsabilità basata sulla sua lettura dell’“ordine dell’amore” di Tommaso d’Aquino. Il vicepresidente ha detto: “Dovremmo amare prima la nostra famiglia, poi i nostri vicini, poi la nostra comunità, poi il nostro paese e solo dopo considerare gli interessi del resto del mondo”.
Questa visione morale ha enormi conseguenze nel mondo reale, come stiamo già iniziando a vedere. Il vicepresidente sostiene che dovremmo risolvere i nostri problemi interni prima di preoccuparci delle nazioni lontane e dei loro popoli. Molti americani sono d’accordo con questa visione e sembrano non preoccuparsi del fatto che molti di coloro che sostengono la politica della “carità inizia in casa” sono felici che lì anche si fermi.
Vance cerca di usare l’ordine dell’amore di Tommaso d’Aquino per sostenere la sua ideologia politica, ma l’ordine etico che propone è effettivamente coerente con l’etica di Tommaso d’Aquino o, più in generale, con i principi della dottrina sociale cattolica?
L’interpretazione proposta da Vance sembra più concentrata sulla definizione dei limiti dell’amore che sul suo corretto ordinamento. Secondo il suo racconto, l’ordo amoris riguarda il modo in cui la nostra limitata capacità di amare dovrebbe essere suddivisa, suggerendo un’inevitabilità quasi metafisica che si esaurirà senza lasciare nulla per le persone vulnerabili ai margini della società. Questo equivale a poco più che un’immagine di facciata per una moralità ristretta ed egoistica che non è assolutamente all’altezza della descrizione dell’ordine dell’amore proposta da Tommaso d’Aquino e poi ampliata dagli insegnamenti sociali cattolici.
Tommaso d’Aquino sull’amore e la carità
Cosa intendeva Tommaso d’Aquino quando scrisse dell’ordine dell’amore?
Nel suo significato più elementare, “amore” è volere il bene per qualcuno. Anche se siamo tenuti a volere il bene per tutti, in quanto creature finite non possiamo fare il bene attivamente per tutti, quindi dobbiamo essere selettivi. Il bene che dobbiamo concretamente volere per gli altri è determinato dal nostro particolare rapporto con loro. Il dovere di fare il bene a coloro che sono in qualche modo legati a noi ha la precedenza sulla responsabilità verso altri più lontani, almeno quando si tratta del bene che è alla base del nostro legame.
Tommaso d’Aquino bilancia l’amore tra i membri della famiglia con le responsabilità che riguardano altri tipi di relazioni. L’amore familiare sano e giusto è generalmente “ordinato” nel senso che (in circostanze normali) dovremmo onorare i nostri genitori più degli altri anziani, prenderci cura dei nostri figli più degli altri bambini e impegnarci in un’intimità fisica ed emotiva esclusiva con un coniuge che è di natura diversa dalle altre forme di intimità. L’ordine dell’amore fornisce un ampio quadro di riferimento per riflettere sulla forma generale delle nostre responsabilità, ma non ignora il fatto che a volte le contingenze della vita possono richiedere di scavalcare le nostre priorità abituali.
Ci sono diversi problemi con la concezione dell’ordine dell’amore proposto da Vance e dai suoi difensori. In primo luogo, il loro resoconto tende a vedere l’amore, almeno al di fuori della famiglia, come qualcosa di simile alla moderna carità: donare risorse per bontà di cuore. Tommaso d’Aquino, d’altra parte, pensava alla caritas in termini fondamentalmente relazionali: come una sorta di legame, amicizia o comunione in Cristo. La carità moderna dona da una distanza di sicurezza, ma la caritas cerca l’unione nata dall’amore.
In secondo luogo, Vance, Reno e altri che lo seguono, non seguono Tommaso d’Aquino nel riconoscere che l’amore di Dio è il fondamento, il fulcro e il cuore animatore dell’ordine cristiano dell’amore (l’ordo caritatis, per essere più precisi). Dio ama l’intero ordine creato e gli esseri umani come partecipanti a questo mondo più ampio. Poiché tutte le persone sono create a immagine di Dio, condividiamo un’uguaglianza fondamentale di dignità intrinseca. L’universalità dell’amore divino e la sua espressione nella creazione della persona umana costituiscono la base dell’impegno cristiano a volere il bene di ogni prossimo senza eccezioni.
In terzo luogo, Vance e i suoi sostenitori affermano che dovremmo amare prima le nostre famiglie e poi i nostri prossimi. Sembrano pensare ai “prossimi” in senso letterale, come persone particolari che vivono nelle nostre vicinanze. Questo uso ristretto non è in linea con l’ampliamento del termine da parte di Gesù stesso, che include non solo i “vicini” che vivono nel nostro “quartiere”, ma tutti gli esseri umani. Gesù considerava vicini vedove e orfani, poveri, malati e disabili, emarginati sociali e, sì, lavoratori stranieri.
In una lettera ai vescovi statunitensi del 10 febbraio, papa Francesco ha osservato che “il vero ordo amoris che deve essere promosso è quello che scopriamo meditando costantemente sulla parabola del buon samaritano (cf. Lc 10:25-37), cioè meditando sull’amore che costruisce una fratellanza aperta a tutti, senza eccezioni”.
L’estensione della nostra preoccupazione morale
Quarto, nella tradizione cattolica, ci prendiamo cura della comunità in parte adempiendo alle nostre responsabilità verso le nostre famiglie, amici, colleghi di lavoro, concittadini e altri ancora. Seguendo Aristotele, Tommaso d’Aquino sostiene che, proprio come il tutto ha la priorità sulle sue parti, così il bene comune della comunità è “più perfetto” e un “bene superiore” rispetto al bene privato dei suoi membri.
Quinto, è importante notare che l’ordine di obblighi di Vance include l’amore per il proprio paese. Il paese come stato-nazione non è un oggetto d’amore nell’ordine di amore di Tommaso d’Aquino (l’Italia non divenne un paese unificato fino al 1861), ma egli rispettava i legami e i doveri verso il proprio principato, la propria città, il proprio stato o il proprio re. L’etica cattolica oggi apprezza un sano amore per il proprio paese, ma non l’ulteriore affermazione che non abbiamo alcuna responsabilità nei confronti dei cittadini di altri paesi.
Non è possibile conciliare la nozione di ordo amoris di Tommaso d’Aquino con una posizione che separa nettamente l’amore per i nostri concittadini americani da qualsiasi preoccupazione per gli stranieri, indipendentemente dal fatto che risiedano o meno tra di noi. Vance sostiene una politica che non consente ai migranti costretti a lasciare le loro case a causa di violenze e difficoltà estreme nemmeno di richiedere asilo, un diritto sancito dalla legge statunitense sui rifugiati del 1980. L’etica cattolica apprezza un amore patriottico ordinato per il proprio paese, sì, ma non una xenofobia nazionalistica che rifiuta di vedere i propri simili in condizioni di estremo bisogno come propri vicini.
In sesto luogo, la posizione di Vance ammette che gli americani potrebbero avere una minima responsabilità nei confronti delle persone di altri paesi, ma questo suggerimento appare solo come una riluttante concessione teorica. Fino a quando non avremo messo completamente in ordine casa nostra, si sostiene, non dovremmo nemmeno “prendere in considerazione gli interessi del resto del mondo” – figuriamoci fare qualcosa che possa aiutare le regioni che stanno soffrendo di più, a volte a causa delle nostre stesse politiche; a meno che, naturalmente, ciò non contribuisca direttamente alla prosperità degli Stati Uniti. Poiché i poveri saranno sempre con noi, questa clausola rinvia a tempo indeterminato, e di fatto nega, qualsiasi responsabilità morale che il nostro governo potrebbe avere nei confronti delle popolazioni del Sud del mondo colpite da terribili crisi umanitarie, tra cui carestie, epidemie e guerre civili.
Nessuna vera etica cattolica relega alla periferia esterna della nostra preoccupazione morale un gran numero di prossimi che soffrono lontano. Il fatto che non possiamo amare ogni prossimo “allo stesso modo e nella stessa misura”, come giustamente osserva Reno, non giustifica l’amare solo la nostra gente e ignorare il resto dell’umanità – che è esattamente ciò che propone la lettura dell’ordine dell’amore di Vance. Un tale amore, in termini cristiani, è tutt’altro che propriamente “ordinato”.
Settimo, in una radicale deviazione da Tommaso d’Aquino, né Vance né Reno tengono conto dei gradi di necessità nel loro ordine dell’amore. Reno scrive: “Trascurare i bisogni di qualcuno in Siria non facendo una donazione a un’organizzazione umanitaria potrebbe essere peccaminoso… (sottolineo potrebbe). Ma restare indifferenti quando un vicino è in difficoltà è probabilmente un peccato più grave”. Qui egli sottintende che dovremmo considerare le grandi sofferenze dei siriani sottoposti a rapimenti, gas, sequestri, sparizioni, mutilazioni, torture e massacri come meno importanti per noi di qualsiasi tipo di disagio subito dalle persone nelle nostre comunità e nel nostro paese.
Sia Vance che Reno considerano la vicinanza a noi, ma ignorano il bisogno. Tommaso d’Aquino, d’altro canto, capì che a volte dobbiamo dare priorità ai bisogni più urgenti degli estranei rispetto ai semplici desideri dei nostri cari. In alcune occasioni, sottolinea, dovremmo dare un aiuto concreto a coloro “che hanno più bisogno… piuttosto che a chi è più strettamente unito a noi…” (Summa Theologica, II-II, 31 ,9; vedi anche 30, 3).
Tommaso d’Aquino potrebbe aver pensato ai mendicanti indigenti che incontrava per le strade di Parigi o Napoli, ma oggi dobbiamo essere consapevoli non solo dei senzatetto che dormono nei nostri parchi, ma anche delle persone disperatamente povere intrappolate nelle favelas di Rio o nelle baraccopoli di Nairob – essendo loro prossimi non principalmente attraverso un servizio diretto, ma sostenendo le istituzioni che cercano di rispondere ai bisogni espressi da queste persone e garantire che i loro diritti siano rispettati.
Sussidiarietà e solidarietà
Un’ultima nota: l’interpretazione di Vance dell’ordine dell’amore ignora il ruolo delle istituzioni come veicoli sia dell’amore che della giustizia. Considerate questa citazione dal saggio di Reno: “L’amore cristiano incoraggia la preoccupazione per le vittime degli incendi in altri stati, regioni o paesi. Ma ancora di più l’amore cristiano ci spinge a venire in aiuto dei vicini le cui case in fondo alla strada stanno bruciando”.
Se ne hai la possibilità, ovviamente, dovresti correre fuori e gettare acqua sul lato della casa del vicino, ma ciò di cui il tuo vicino ha davvero bisogno è che una squadra di vigili del fuoco si presenti il prima possibile. I vigili del fuoco sono gestiti dai governi cittadini e finanziati dalle tasse. Se ami il tuo prossimo (in entrambi i sensi del termine) devi votare per funzionari governativi e politiche che non lasciano i proprietari di case a cercare di spegnere incendi violenti con i loro tubi da giardino. L’insegnamento sociale cattolico riconosce il contributo delle istituzioni ben gestite al bene comune in modi che una lettura così restrittiva dell’ordine dell’amore non contempla.
Come hanno ripetutamente insistito diversi papi recenti, l’amore per il prossimo non dovrebbe limitarsi ad atti di virtù individuale, ma deve anche ispirare un impegno personale e collettivo per correggere l’ingiustizia strutturale. Il principio di sussidiarietà riconosce che in molti casi solo i governi hanno le risorse per affrontare problemi su larga scala radicati nell’ingiustizia strutturale.
Consideriamo un esempio concreto. Nel 2003, il presidente George W. Bush ha istituito il PEPFAR, il Piano di emergenza del Presidente per l’assistenza contro l’AIDS. Fin dalla sua istituzione, il PEPFAR ha investito oltre 110 miliardi di dollari nella risposta alla pandemia. A questo singolo programma è attribuito il merito di aver salvato oltre 26 milioni di vite e di aver permesso a più di cinque milioni di bambini di nascere senza l’HIV. Questo programma è al servizio di persone che non hanno accesso, o ne hanno uno molto limitato, a test, trattamenti antiretrovirali o cure e supporto critici. Nessuna donazione privata da parte di benefattori ben intenzionati è sufficiente per affrontare una sfida così grande.
Attualmente, la capacità di funzionamento del PEPFAR e il suo futuro sono in discussione a causa della revoca dei finanziamenti da parte dell’amministrazione Trump e della caotica ristrutturazione degli aiuti umanitari americani. Sostenere programmi governativi come il PEPFAR è un modo pratico ed efficace di amare il vicino lontano. Al contrario, tagliare questo tipo di programma significa abbandonare alcuni dei nostri fratelli e sorelle più bisognosi.
L’ordine tomistico dell’amore, correttamente interpretato, riconosce che dovremmo prenderci cura dei nostri cari più stretti, dando al contempo una priorità speciale ai nostri fratelli e sorelle più piccoli.
Più in generale, l’etica cattolica è sia personale che sociale, aperta al mondo piuttosto che rivolta verso l’interno, e caratterizzata da compassione e giustizia piuttosto che da indifferenza o ostilità. Offre una visione tipicamente cristiana dell’ordine dell’amore che cerca di rendere giustizia alle responsabilità verso i propri cari e verso gli estranei bisognosi, sia individuali che collettivi.
Siamo tutti sicuramente più inclini a concentrarci strettamente sulla cura della famiglia e degli amici piuttosto che sull’ospitalità verso gli estranei e sull’aiuto ai “miserabili della terra”. Ma troviamo una visione correttiva nell’esortazione di papa Giovanni Paolo II a coltivare la virtù della solidarietà, nella preoccupazione di papa Benedetto XVI per il “bene comune universale” e nella promozione dell’accompagnamento e della fraternità da parte di papa Francesco.
Non dovremmo permettere che l’amore per noi stessi, le nostre famiglie e comunità, il nostro paese, offuschino la nostra responsabilità di affrontare i bisogni gravi e urgenti dei nostri fratelli e sorelle costretti a vivere ai margini del nostro mondo. Sforzarsi di vivere questo tipo di amore non rende qualcuno un “liberale”, e tanto meno un membro della “sinistra radicale”, ma un cristiano.
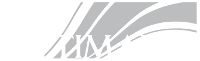





Vabbè. Un ricorso a Tommaso dalla posizione che ricopre il nuovo JD Vance può risuonare anche Macchiavellico. E non dimentichiamo che oltre Tommaso l’Italia ha dato i natali anche ad un Niccolò Macchiavelli che, al 3º paragrafo del VXII capitolo del Libro, evidenzia al Principe che: Gli Uomini sdimenticano più presto la morte del padre che la perdita del patrimonio. Perciò in un ipotetico Ordo Amoris USA hanno tralasciato, invece che i vicini ed i paesani, più comprensibile amore per il denaro le ricchezze ed il potere se “gli uomini piangono otto giorni la morte del padre ed una vita intera la perdita del patrimonio”