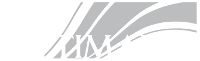In un passaggio dei Soliloquia (I, 2,7), sant’Agostino risponde all’interrogativo della ragione su che cosa egli voglia conoscere con brevi e famose parole: «Dio e l’anima: questo desidero conoscere» e all’ulteriore domanda: «nulla più?», egli ribadisce: «assolutamente nulla». Di questa risposta è notevole la ferma certezza con cui Agostino indica in Dio l’oggetto più degno della nostra conoscenza, e l’altrettanto chiara convinzione che la conoscenza di Dio sia inscindibilmente connessa a quella dell’anima.
Nel linguaggio di S. Agostino «anima» è il termine che indica il sé, l’identità personale di ciascuno di noi, sicché la sua risposta suppone che la conoscenza di Dio e quella di sé stessi siano inestricabilmente collegate.
Cosa è rimasto oggi di questo nesso così stretto tra teologia e conoscenza del sé? All’apparenza molto poco: l’interesse a conoscere Dio sembra oggi scarso perfino tra i teologi cristiani probabilmente a causa di un’inconfessata «morte di Dio» e quindi della conseguente paura di non essere più à la page parlando di Dio, mentre la ricerca della conoscenza di sé, quando non è ridotta alla gestione delle proprie emozioni, la cui crescente necessità, in una società emotivamente fragile come la nostra, ingrossa sempre più le fila degli psicologi e delle psicologhe, presenta un rapporto privilegiato con l’ambito molto vasto e variegato della «spiritualità», che è tutt’altra cosa rispetto alla teologia.
In questo contesto è quindi da salutare con favore la riedizione (la terza, riveduta e ampliata) del libro di Giacomo Canobbio, Il destino dell’anima (Morcelliana). La prima edizione del 2009, tradotta anche all’estero, seguiva di due anni l’uscita di un fortunato libro di Vito Mancuso, L’anima e il suo destino (Cortina, Milano 2007) che ha avuto il merito, se non altro, di riportare l’attenzione del pubblico colto sul significato teologico dell’anima e, con le sue tesi provocatorie, ancorché non sempre fondate, di stimolare anche i teologi italiani a riflettere nuovamente sul tema.
Il libro di Canobbio, come si evince dal sottotitolo: «Elementi per una teologia», è in effetti un tentativo di riprendere in mano la grande questione teologica dell’anima, offrendo al lettore una sin tesi delle principali indicazioni del Magistero nel corso dei secoli, delle opinioni teologiche predominanti nella storia della teologia cristiana e, soprattutto, dei problemi teorici che avviluppano questa questione, resi ancora più intricati dal confronto con le scienze contemporanee.
Nel primo capitolo Canobbio parte proprio dalla sfida lanciata dalle neuroscienze e dal tentativo di naturalizzare l’essere umano, cioè di eliminare nella comprensione della natura umana qualsiasi riferimento a entità spirituali, ma anche dalla sfida della teoria dell’evoluzione che ha inaugurato nella modernità un nuovo paradigma di comprensione dell’umano.
Egli mostra, da una parte, come il progetto di naturalizzazione dell’essere umano, che travalica l’ambito puramente scientifico, oltre a non rendere ragione della complessità della sua natura umana, rappresenti una negazione della sua differenza qualitativa rispetto agli altri esseri viventi. Dall’altra, mostra che il pensiero biblico, la riflessione teologica medioevale (san Tommaso) e quella contemporanea (soprattutto K. Rahner e A. Ganoczy), anche se in modo non del tutto compatibile fra loro, offrono le risorse concettuali per ripensare l’immagine dualistica dell’essere umano che è divenuta tradizionale nel pensiero cristiano, ma che è invisa tanto alle neuroscienze quanto alla teoria dell’evoluzione.
Un problema particolarmente delicato, a questo proposito, è quello dell’origine dell’anima che facilmente dà il via a interpretazioni contrapposte, quella soprannaturalistica e quella naturalistica, segnate entrambe da limiti esplicativi notevoli.
Nel secondo capitolo Canobbio affronta la questione della divaricazione prodottasi in epoca moderna, soprattutto nella teologia protestante, tra la concezione biblica e quella filosofica dell’anima derivata dal pensiero greco antico. Per cercare di superare questa divaricazione, egli riprende la concezione dell’anima di san Tommaso d’Aquino, che già nella sua epoca ha rappresentato un tentativo di sintesi tra il dato antropologico biblico, la psicologia aristotelica e la visione platonica dell’anima.
La sua concezione dell’anima come «forma sussistente del corpo» dà infatti ragione del fatto che corpo e anima non sono semplicemente due sostanze giustapposte nell’essere umano, bensì formano un’unità sostanziale, pur conferendo un privilegio ontologico all’anima che, in quanto «forma sussistente», non viene meno con la morte del corpo. Per quanto alcuni vedano, come osserva Canobbio (cf. p. 127), un residuo di platonismo in questa concezione, essa è essenziale per difendere un’immagine duale e non semplicemente dualistica dell’essere umano, una concezione che mostra tutta la sua rilevanza anche riguardò al tema del destino dell’anima.
A questo tema sono dedicati il capitolo terzo e quello finale, dove Canobbio affronta la questione della vita dopo la morte. Anche in questo caso, egli si adopera per ricomporre la frattura interpretativa scavata da esegeti e teologi contemporanei tra immortalità dell’anima e resurrezione del corpo, una variante della presunta antitesi tra pensiero biblico e pensiero filosofico.
Le considerazioni di Canobbio ruotano essenzialmente attorno a due grandi questioni teoriche: se la morte sia o meno una condizione naturale dell’essere umano o non piuttosto l’immortalità, con il conseguente problema di capire come la morte capovolga la destinazione originaria dell’essere umano, e in quale forma si dia sopravvivenza del sé dopo la morte del corpo.
Anche in questo caso, la concezione di san Tommaso offre un punto di sintesi tra visioni contrapposte, perché la sopravvivenza dell’anima senza il corpo, pur ammessa nel tempo intermedio tra la morte individuale e la fine dei tempi con l’avvento del giudizio universale, è pensata come «innaturale» e quindi costitutivamente orientata alla finale resurrezione del corpo.
Affrontando quest’ultimo problema Canobbio discute anche la problematica concezione della «resurrezione della morte», proposta dal teologo G. Greshake, che appunto fa a meno dell’idea di un’anima separata, utilizzando, nel confronto critico con essa, le osservazioni fatte da Joseph Ratzinger nella sua escatologia.
Il libro di Canobbio, come attesta il successo avuto, si distingue per chiarezza espositiva, abbondanza di riferimenti, capacità di padroneggiare una questione complessa e dai molteplici risvolti e di orientare il lettore senza far venire meno questa complessità.
Se Canobbio, magari in vista di una futura, ennesima edizione, volesse allargare ancora il cerchio delle sue considerazioni, due punti, ci permettiamo di suggerire, andrebbero tenuti maggior mente in conto: il primo è il dibattito in filosofia della mente contemporanea, che serve per capire meglio il carattere della sfida avanzata dalle neuroscienze e anche per modulare la risposta teologica ad essa. Del resto, proprio questo dibattito fa capire quanto l’alternativa secca tra materialismo e dualismo sia impropria e perché una soluzione originale come quella di san Tommaso trovi oggi una nuova credibilità.
Il secondo punto riguarda il carattere ancipite del destino escatologico umano, che nel libro di Canobbio non è messo in evidenza. Se si segue san Tommaso fino in fondo, occorre ammettere che il destino dell’anima appare sotto la luce della salvezza, ma anche sotto quello della perdizione. Mancuso, nel libro sopra citato, (cf. p. 260), rigetta la dottrina della dannazione eterna, lasciando il lettore diviso e perplesso tra l’accettazione dell’apocatastasi (universalismo della salvezza) e quella dell’annichilazione del malvagio. Sarebbe utile che anche su questo punto Canobbio potesse orientarci in modo efficace, come ha fatto sul resto.
Giacomo Canobbio, Il destino dell’anima. Elementi per una teologia. Nuova edizione ampliata, collana «Pellicano rosso», Morcelliana, Brescia 2024, 224 pp., 18 euro. La recensione è stata pubblicata sulla rivista Dialoghi, 3/2024, pp. 89-92.