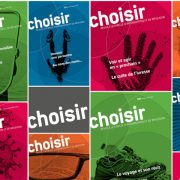Riflessioni a partire da La Macchina del tempo di H.G. Wells
Una serata tra amici in una casa signorile dell’Inghilterra vittoriana: uno scenario tutt’altro che inconsueto, un vero “luogo comune” per la cultura della seconda metà del XIX secolo. In questo ambiente un singolare personaggio – del quale non viene detto mai il nome: egli è solo “Il Viaggiatore” – espone una sua teoria, secondo la quale viaggiare nel tempo è possibile. Mostra poi una strana macchina, «una struttura metallica lucente, poco più grande di un piccolo orologio a pendolo, fatto con molta accuratezza: era in parte d’avorio, in parte di cristallo trasparente» (I) e spiega agli astanti (alcuni sono chiamati per nome, ma c’è anche un Medico, uno Psicologo, un Uomo molto giovane, un Giornalista…), in una sala illuminata da una dozzina di candele (!), che essa è in grado per l’appunto di viaggiare nel tempo, la quarta dimensione della realtà: e infatti si smaterializza, diretta verso il futuro. Il narratore – anch’egli anonimo – racconta poi come il Viaggiatore abbia mostrato loro una macchina più grande: «alcune parti erano di nichelio, altre d’avorio, altre ancora erano state certamente segate o limate nel cristallo di rocca», che il Viaggiatore intende usare per spostarsi egli stesso nel tempo.
Una settimana dopo il gruppo viene riconvocato. Il Viaggiatore giunge all’appuntamento in ritardo e in condizioni pietose, sporco, stracciato e sofferente. Dopo essersi ripreso, si ripropone di raccontare quanto gli era accaduto nel suo viaggio. «Quasi tutto vi sembrerà menzogna. Non importa! È verità, ogni parola è vera, qualunque cosa pensiate. Ero nel mio laboratorio alle quattro e da quel momento ho vissuto otto giorni, dei giorni che nessun uomo ha vissuto prima d’ora» (II).
Il Viaggiatore era andato avanti di ottocentomila anni, giungendo su un prato, sotto la pioggia, accanto ad una grande scultura simile a una sfinge alata scolpita nel marmo bianco: «era molto rovinata dalle intemperie e dava una disgustosa sensazione di malattia» (III). Viene avvicinato da un individuo: «era esile, alto circa un metro e venti, vestiva una tunica di porpora stretta in vita», una «creatura bellissima, aggraziata, ma incredibilmente fragile… il suo viso roseo, ricordava la bellezza dei tubercolotici». Il Viaggiatore impara poco alla volta a conoscere il mondo degli Eloi, dalla lingua «armoniosa e dolce», connotati da «una delicata gentilezza, una certa naturalezza infantile» (IV), «al livello mentale di un bambino di cinque anni». Essi sono felici delle loro danze, dei loro canti, del raccogliere fiori, «passavano il tempo in divertimenti gentili, bagnandosi nel fiume, amoreggiando in maniera semischerzosa, mangiando frutta e dormendo» (VII), immersi in una natura che – comprende il Viaggiatore – ha perso tutta la sua connotazione minacciosa, privata com’è (o come sembra) di predatori, animali pericolosi, malattie.
Gli Eloi vivono in comune, in grandi edifici decadenti, che sembra non abbiano costruito: nell’anno 802.701 l’umanità vive dunque in un «decadente splendore» (V). «Tutta la Terra era diventata un giardino», «tutto il mondo diventerà intelligente, istruito e cooperante»; è insomma l’«ultima grande pace», dove nessuno possiede nulla in privato, nessuno conosce la scrittura, non esiste il linguaggio figurato, è scomparso l’uso del fuoco.
Questo (peraltro agghiacciante) panorama non dice però tutto: c’è qualche indizio del fatto che sulla Terra dell’anno ottocentomila esiste anche qualcos’altro, che si nasconde nei numerosi pozzi che dal livello terreno sprofondano nelle viscere della Terra. La curiosità del Viaggiatore (oltre che la necessità di ritrovare la Macchina che gli è stata misteriosamente sottratta) lo porta a penetrare in uno di questi pozzi, dove incontra l’altro esito dell’umanità: i Morlocchi, creature «di un color bianco sporco … aveva dei grandi occhi strani d’un grigio rossastro e una lunga capigliatura bionda che le ricadeva sulle spalle e sulla schiena» (VII); «pareva un ragno umano». Dunque «non vi era più un’unica specie umana, ma si era differenziata in due tipi distinti»: oltre alle «graziose creature del mondo in superficie» vi era quel «repellente, scolorito essere notturno». I Morlocchi facevano «tutto il lavoro necessario al benessere della razza che viveva in superficie», per poi divorarla. Il Viaggiatore lo scopre con raccapriccio, e conclude che questa sia l’ultima conseguenza della differenziazione, che egli già conosceva nel suo tempo, tra classi agiate rimaste oziose in superficie e proletari costretti al lavoro sottoterra.
Il protagonista visita anche un «palazzo di porcellana verde», un grande museo che aveva ospitato tutto il sapere umano e che ora è ridotto in rovina: la sua biblioteca, in particolare, è una «triste distesa desolata di carta marcita» (X). Riflette infine tristemente: «com’era stato breve il sogno dell’intelletto umano … con tenacia si era avviato verso il benessere e le comodità, verso una società equilibrata, le cui parole d’ordine erano ”sicurezza” e “stabilità”; aveva realizzato le sue speranze per poi arrivare a questo» (XII).
Recuperata avventurosamente la Macchina, il Viaggiatore va ancora oltre, e osa una distanza maggiore. Si trova su una spiaggia desolata, accanto ad un mare che rifrange le sue lente onde su una spessa crosta di sale. La Terra si è “fermata”, e rivolge al Sole sempre la stessa faccia. Nell’aria rarefatta si muove un’immensa farfalla bianca, e «una mostruosa creatura che assomigliava ad un granchio» tenta di aggredirlo (XIII). Per sfuggire a quest’ultima si spinge fino a trenta milioni di anni. «La spiaggia rossastra … sembrava senza vita ed era ora ricoperta di un leggero strato bianco; sentii un freddo intenso; rari fiocchi bianchi cadevano di tanto in tanto, turbinando … Le rive del mare erano bordate di ghiaccio, ed enormi massi di ghiaccio galleggiavano più lontano, ma quasi tutta la distesa dell’oceano salato, color sangue sotto l’eterno tramonto, non era ancora gelata». «Il mondo era avvolto nel silenzio. Nel silenzio? Sarebbe difficile descrivervi quella calma». Unica forma di vita, «una cosa rotonda della grossezza di un pallone da foot-ball forse, o anche di più, dalla quale uscivano dei tentacoli; sembrava nera di fronte al color rosso sangue dell’acqua e saltellava qua e là a balzi irregolari» (p. 128). Il Viaggiatore, a quel punto, intraprende il viaggio di ritorno. Tra coloro che ascoltano il suo racconto, molti sono scettici: unica prova concreta che egli può portare sono gli strani fiori che una ragazza degli Eloi gli aveva donato, e che egli porta ancora sbiaditi nella sua tasca.
Il narratore si reca quindi ancora una volta, il giorno successivo, a casa del Viaggiatore: ma egli era però ripartito. «Scomparve tre anni fa, come tutti sanno, e non è ancora tornato» (XIV). Non gli resta che una malinconica osservazione: il Viaggiatore «pensava solo con tristezza al progresso dell’umanità e non vedeva nella crescente ricchezza della civiltà che un assurdo accumulare inevitabilmente destinato, alla fine, a ricadere sui suoi creatori e a distruggerli. Se è così, non ci resta che vivere come se così non fosse» (epilogo). Unica piccola consolazione quei fiori bianchi che vengono dal futuro e che testimoniano un affetto che continuerà ad esistere nel cuore dell’uomo «anche quando l’intelligenza e la forza saranno scomparse».
***
Herbert George Wells aveva frequentato la Scuola Normale di Scienze a Londra, ed era stato alunno di un famoso biologo, Thomas Henry Huxley (nonno dell’Huxley autore di Brave New World), grande sostenitore dell’evoluzionismo darwiniano. Quest’ultima dottrina scientifica divenne una delle sue principali fonti di ispirazione, e favorì in generale l’attitudine del giovane scrittore ad andare oltre le convenzioni sociali, le prassi politiche, le convinzioni psicologiche. Wells non tardò anche a coglierne anche le implicazioni più estreme: un esempio di ciò lo si trova per l’appunto in The Time Machine, scritto nel 1895.
L’importanza del racconto (poco più di cento pagine) è ben nota dal punto di vista storico-letterario: Wells è anzi considerato l’inventore del tema del viaggio nel tempo non più in un sogno, in una visione o grazie all’intervento di una qualche divinità, ma in forza di una macchina. Ho iniziato questa comunicazione riassumendo La macchina del tempo perché a mio parere tematizza, in modo efficace e radicale, alcune delle domande che siamo costretti a farci da alcune generazioni a questa parte, e che portano con sé la necessità anche di un ripensamento radicale del modo di vivere una fede adulta nel nostro mondo.
Credo che la “rivoluzione scientifica” portata a termine tra XIX e XX secolo non sia infatti stata ancora del tutto compresa, né probabilmente può esserlo facilmente nelle sue reali dimensioni.
* Abbiamo assistito allo sfondamento del tempo. Se trasferiamo la scala cosmica su misure che ci sono meno aliene, e poniamo il big bang quindici minuti fa, scopriamo che la Terra esiste da cinque minuti, i vertebrati da trenta secondi, i dinosauri si sono estinti da quattro secondi, l’uomo esiste da qualche centesimo di secondo e la distanza che ci separa dalla prima venuta di Cristo si misura in decimillesimi di secondo. Di fronte a noi abbiamo ancora qualche minuto prima della morte del Sole, mentre l’orizzonte di completo spegnimento delle stelle è attualmente valutato in un tempo equivalente a due mesi e mezzo (tempi ancora più lunghi, ma già calcolati, prevedono quindi il decadere delle onde gravitazionali, poi del protone e infine il trasformarsi della materia in un liquido dalla temperatura prossima allo zero assoluto) (sono consapevole del fatto che gli scienziati stessi sono costantemente alla ricerca di nuovi modelli interpretativi, e che quindi quanto vado rozzamente sunteggiando potrebbe venire in seguito modificato da nuove teorie; però ricordo che qui stiamo confrontandoci “solo” con le “certezze” del nostro tempo. Ho inoltre l’impressione che nuove teorie, semmai, renderanno il quadro ancora più complesso e paradossale, non meno).
* Abbiamo assistito allo sfondamento dello spazio. Anche qui trasferiamo le scale cosmiche a dimensioni più comprensibili, o almeno proviamoci. Se la sfera terrestre – che pure ha dimensioni che superano l’esperienza quotidiana! – avesse un diametro pari ad un millimetro, la Luna sarebbe un puntino a tre centimetri, il Sole una palla da tennis a 11 metri, l’orbita di Plutone starebbe a cinquecento metri da qui, la stella più vicina a 3.000 km (tremila chilometri). La Via Lattea, in proporzione, avrebbe un diametro pari alla metà della distanza tra la Terra e il Sole: e per valutare le dimensioni del resto dell’universo dovremmo aggiungere a questa cifra cinque zeri in più.
* Ma c’è stato anche lo sfondamento della quantità. Se paragoniamo una stella ad un carattere tipografico, scopriamo che il numero di stelle presenti nella nostra galassia è pari ai caratteri tipografici che stanno in una grande biblioteca fatta di centinaia di migliaia di volumi; e vi sono probabilmente più stelle nell’universo di quante siano mai state le lettere stampate sulla Terra (se non ci credete fate qualche moltiplicazione, si stima che esistano settantamila miliardi di miliardi di stelle, se per fare cifra tonda calcoliamo venti miliardi di terrestri vissuti negli ultimi cinquecento anni e in ogni unità-libro mettiamo un milione di caratteri fanno 3,5 milioni di libri a testa…). Non è detto che attorno ad ogni stella debbano orbitare dei pianeti (anche se è probabile che ciò accada), e non è certo detto che i pianeti adatti ad ospitare la vita debbano essere frequentissimi, ma è con queste cifre che abbiamo a che fare (traggo questi dati da quanto è disponibile on-line, a partire da wikipedia; le proporzioni sono però mie, se non vi convincono provate a rifarle).
Probabilmente a questi “sfondamenti” bisognerebbe anche aggiungerne altri, a cominciare da quello che ha portato a superare le convinzioni “fissiste” per quanto riguarda la realtà vivente, per giungere (forse) alla consapevolezza del fatto di trovarci immersi in una continua e imprevedibile trasformazione; ma credo che per il momento queste note siano sufficienti.
Abbiamo dunque vissuto, o stiamo vivendo, la perdita del “fondo”, della base sulla quale da qualche millennio si appoggiavano o si appoggiano le nostre convinzioni politiche, culturali, etiche, religiose. L’uomo contemporaneo ha scoperto, o sta scoprendo, di vivere in un universo che esorbita e travolge ogni antropocentrismo o geocentrismo. Cosa resta allora del “piccolo mondo antico” biblico ed evangelico, che già ci sembra così lontano dalla esperienza quotidiana? Come si può ripensare la fede, e soprattutto viverla, in questo “nuovo” mondo, piccolo e breve se raffrontato alle dimensioni cosmiche? Cosa significano frasi come “secondo la loro specie”, “a immagine e somiglianza”, “pienezza dei tempi”, “secoli dei secoli”, “non prevarranno”, “ultimo giorno”? Qual è il rapporto, a livello di prassi, tra la lotta per la sopravvivenza, che sembra dare il tono all’evoluzione, e i criteri con cui saremo giudicati? Cosa voleva dirci il Risorto con la promessa «ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20) e con il mandato «mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra» (At 1,8)?
***
Ci sono certamente in circolazione delle letture “tranquillizzanti” di questa serie di sfondamenti. Forse basta dire che la Creazione è più ampia di come la immaginavamo e che Dio è conseguentemente un Creatore ancora più grande; che la Terra che Egli dà all’uomo ha in realtà dimensioni universali, tali da impegnarlo in un percorso di scoperta e amministrazione per il quale il tempo a disposizione non è poi così esorbitante; che basta togliere al termine “uomo” il legame con una determinata specie e mantenerlo aperto ad indicare qualunque forma di vita che raggiunga l’autocoscienza, la consapevolezza, l’intelligenza. Basta?
Fino a un certo punto. Non si può infatti negare, prima di tutto, che le dimensioni di cui abbiamo parlato diano comunque le vertigini. Ma credo che ad inquietare sia soprattutto la percezione che gli “sfondamenti” abbiano messo all’angolo, “ridotto” ad atto di fede, l’idea che l’Universo abbia un fine, un senso, una logica (un logos che stia “in principio”). Nei secoli passati ci eravamo abbondantemente sforzati di “dimostrare”, filosoficamente o sentimentalmente, la possibilità di riconoscere nella Creazione l’orma del Creatore. Oggi non è più così, soprattutto perché lo sguardo scientifico, programmaticamente, rimuove qualunque “causa finale” dal suo orizzonte (e se non fosse così non sarebbe la scienza moderna). Ma si tratta della stessa scienza che è stata in grado di rendere il mondo un luogo meno ostile per l’uomo, che ci ha permesso di dominarlo… È come se quotidianamente ripetessimo un “Ascolta Israele” riferito non più alla liberazione dall’Egitto da parte di JHWH, ma alla liberazione (almeno provvisoria) dalla fame, dal freddo, dalla fatica da parte della Scienza (Dt 4: «I vostri occhi videro…»). Scienza che, come detto, non conosce fine (al maschile), e ci dice che l’universo è privo di una direzione che non sia quella del suo decadimento per entropia, o al più è destinato ad una rigenerazione che cancellerà la memoria di tutto ciò che è avvenuto in precedenza. Un’escatologia priva di sbocco, di speranza, ossia disperata.
La fede può certo essere tale anche senza l’“evidenza”, vera o presunta, del finalismo antropocentrico: ma essa è chiamata a un salto nel buio di proporzioni superiori a quanto si riteneva comunemente necessario. Ne siamo capaci? Ho l’impressione che di fatto oscilliamo tra la speranza in un futuro semplicemente meno misero e ingiusto del presente e un radicale rifiuto del confronto, quasi che l’esistenza materiale sia un’illusione alla quale Dio, prima o poi, ci sottrarrà. Quest’ultima posizione, che ha certamente un suo “fascino”, toglie però sensatezza ad una creazione in cui il settimo giorno appare tanto lungo quanto inutile. Sono possibili altre risposte?
«Giunsi persino a stropicciarmi gli occhi e a implorare Dio di farmi svegliare» (H.G. Wells, La Macchina del tempo, XI).
Articolo pubblicato su Il Margine, n. 3/2009. Le citazioni dell’opera di Wells sono tratte dall’edizione curata da F. Ferrara e tradotta da P. Carabelli, Mursia, Milano 1996; i numeri romani tra parentesi si riferiscono ai capitoli.