
Sergio Givone, filosofo e romanziere, professore emerito all’Università di Firenze, ove è stato ordinario di Estetica presso la facoltà di Lettere e Filosofia, è l’autore del volume La ragionevole speranza. Come i filosofi hanno pensato l’aldilà (Solferino, 2025). Lo abbiamo intervistato.
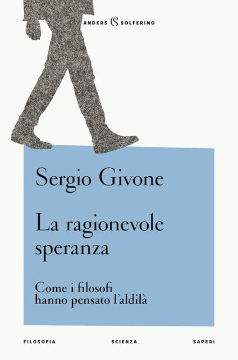
- Se posso chiederle, professore: quale circostanza della vita personale ha occasionato la scrittura di questo suo libro?
Ho compiuto ottant’anni, la mia vita si avvia a conclusione, volente o nolente sono costretto a chiedermi se con la morte tutto finisce o se, al di là della morte, ci sia qualcosa, magari la cosa più importante di tutte: risposta d’obbligo, in realtà evasiva e di comodo.
Comincio col dire che non è tanto la morte a inquietarmi, quanto la vita. Questo il problema: se la vita umana sia «una passione inutile», come diceva Sartre, e dunque una passione votata all’assurdo, oppure no. Sospesi come siamo non solo fra la gioia e la disperazione, ma tra il bene e il male, tra il senso e il non senso, tra l’essere e il nulla, ci giochiamo la vita in ogni istante; infatti, possiamo perderla da un momento all’altro, così come da un momento all’altro possiamo riacquistarla.
Domandiamoci allora: vale la pena vivere? La pena è tanta, e sembra voler durare sempre, mentre la vita passa come facendosi beffe delle nostre speranze, molto fumose e incerte, e delle nostre delusioni, immancabili e certissime. Per cui io dico: o la vita si inscrive in un più alto orizzonte di senso, misterioso fin che si vuole, ma necessario, o è la cosa più insensata che ci sia. La sola luce che possa essere gettata sull’aldiquà viene dall’aldilà…
- Il sottotitolo recita: «Come i filosofi hanno pensato l’aldilà». Tra i tanti citati, può dire, in proposito, di Immanuel Kant e di Simone Weil: qual è il filo che unisce?
L’accostamento di Immanuel Kant e di Simone Weil può sembrare azzardato, soprattutto se come termine di paragone prendiamo l’aldilà, che è quanto di più equivoco ci possa essere. Ma è proprio su questo punto che Kant e Weil rivelano singolari affinità. Entrambi pensano che l’aldilà abbia ben poco a che fare con lo spazio e col tempo: non sia, cioè, un luogo, sia pure un luogo dislocato chissà dove, e neppure un tempo, sia pure un tempo che abbraccia tutti i tempi, ma rappresenti piuttosto una dimensione dello spirito, che si trova non già fuori di noi, bensì in noi.
Per Kant l’aldilà è il mondo noumenico, il mondo della libertà e della responsabilità, il mondo dove l’uomo è chiamato a decidersi per il bene o per il male. A sua volta per Simone Weil l’aldilà è il sacro, è l’assoluto, è il tratto essenziale che è comune a tutti gli esseri umani e che li rende tutti ugualmente degni di rispetto, di compassione e di amore.
- Come noto − e ricordato nel suo libro − Lei è stato allievo di Luigi Pareyson, di cui, evidentemente, nutre una stima grandissima. Vuole spiegarci la concezione di «apocatastasi» in Pareyson?
Per Pareyson, come già per i Greci e per i Padri della Chiesa, l’apocatastasi è la reintegrazione finale di tutte le cose nella loro perfezione originaria, cioè nella perfezione dell’inizio ritrovata alla fine dei tempi.
Come concepire l’apocatastasi e quindi la ritrovata armonia dell’uno-tutto in una prospettiva che, come quella cristiana, considera definitiva e non revocabile la separazione di bene e male, paradiso e inferno, giusti e dannati? L’apocatastasi è inconcepibile: lo stesso Pareyson non esita a definirla così.
Eppure, è un’idea di cui non si può fare a meno, se non vogliamo parlare di fallimento della creazione. Pareyson non ha elaborato una sua visione dell’apocatastasi, semmai ha espresso un certo rimpianto per non aver saputo o potuto approfondire un tema tanto vertiginoso. Però ne ha riproposto, con tutta la forza, il problema.
- È possibile, secondo Lei, un incrocio − o persino uno scambio − tra pensiero filosofico contemporaneo e pensiero teologico cristiano, tra immortalità dell’anima e risurrezione dei corpi?
Immortalità (dell’anima) e risurrezione (dei corpi) sono idee che non possono essere confuse: la prima è un’idea tipicamente greca, la seconda invece è cristiana. Eppure, le due idee, almeno a partire dal cristianesimo, stanno e cadono insieme. La teologia scolastica ad esempio le teneva unite, anche se non le identificava: immortalità e risurrezione.
Anche il pensiero filosofico contemporaneo tende a sminuire ciò che separa le due idee e ad accentuare ciò che le unisce, ma per rigettare sia l’una sia l’altra. Non così Kant. In Kant l’immortalità dell’anima, quale postulato della ragione, e la risurrezione dei corpi, che apparteneva alla sua fede cristiana, tornano ad affacciarsi, insieme, all’orizzonte del pensiero.
- Naturalmente, sono interessato a conoscere la sua personale opinione: qual è la sua ragionevole speranza?
La mia ragionevole speranza è quella che mi fa dire, nei momenti di buio o, peggio, di oscuramento e di opacità: no, non può essere. Trovo che il non senso e l’assurdo siano peggio della disperazione. No, l’ultima parola sul mondo non può essere l’afasia, il silenzio, la vanificazione di ogni verità e di ogni luce.
Se la verità almeno una volta si è manifestata − e che si sia manifestata è innegabile − è per sempre. Se la luce almeno una volta è apparsa – ed è apparsa – non importa che le tenebre l’abbiano rifiutata. Se qualcuno ha potuto implorare, non senza ragione, di non essere «confuso in eterno» − non confundar in aeternum, (Salmo 31) − nulla vieta che la stessa preghiera sia anche la mia, nel varcare la soglia.
- Viviamo per la morte o moriamo per la vita?
Vivere per la morte è una buona scuola, un ottimo esercizio, una formidabile palestra. Morire per la vita è la nostra salvezza.
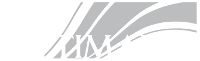


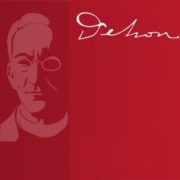


È stato uno dei miei migliori maestri di vita. Mi ha insegnato che vivere attraverso la filosofia, si vive meglio. Si può vivere bene, a volte anche in modo superlativo, quando trovi qualcuno o qualcosa che ti ha illuminato l’esistenza.
Grazie mio caro Professore!