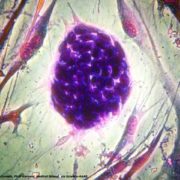Nella prestigiosa scenografia della chiesa di San Procolo a Bologna si è tenuto il primo di una serie di incontri organizzati dall’Unione giuristi cattolici italiani sul tema della Dignità della persona. Si è voluto iniziare con lo sguardo rivolto alle persone rinchiuse in un carcere, luogo che abbisogna di attenzione, civile ancor prima che cristiana, perché la dignità è sottoposta a compressioni minacciose. L’Italia è stata in merito censurata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo perché le condizioni della reclusione si possono configurare come trattamento disumano. Riportiamo il testo dell’intervento del cappellano della Casa circondariale di Bologna che ha affiancato in quella sede il garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale, Antonio Ianniello, e il giudice Federico Casalboni.
Prendo l’abbrivio da una forma del linguaggio che si è accomodata nei nostri discorsi e che riconosco presente molto spesso anche nelle mie parole. Voglio pensare che per gli altri, come per me, nasca da una necessità forse un po’ pigra di semplificare. Ma il linguaggio detta la punteggiatura delle nostre relazioni.
Detenuto e persona detenuta?
E dunque confesso che troppo spesso parlo di quanti sono in carcere chiamandoli “detenuti”. La sostantivazione dell’aggettivo, al di là delle considerazioni di genere, forse è solo una scorciatoia lessicale, ma forse rivela la tentazione condivisa col pensiero comune che identifica le persone con la loro condizione o – troppo spesso nei confronti di coloro che sono stati condannati – con il loro operato.
Il primo passo da fare per riconoscere e ancorare la dignità della persona è liberarla dalle identificazioni col suo agito.
Poi mi capiterà anche in questo intervento di cadere nella semplificazione dell’aggettivo sostantivato, ma voglio smentire già da subito me stesso nel momento in cui, per pigra semplicità, parlassi di “detenuti” anziché di “persone detenute”.
La rivoluzione paolina
In qualità di ministro nella comunità cristiana e cattolica, sono consapevole che se sono in grado di donare qualcosa è per la grazia di averlo ricevuto.
E uno dei doni fondamentali ricevuti dalla tradizione cristiana in riferimento alla qualifica etica della nostra libertà e del nostro agire è la rivoluzione, etica ma, direi di più, antropologica, operata dall’apostolo Paolo. Non a caso uno che ha dovuto fare la sua fatica per farsi accettare dalla neonata comunità cristiana che lo identificava col suo passato di zelota della legge.
La rivoluzione fondamentale operata dalla riflessione paolina – tanto da vedersi assegnare il titolo di “fondatore” del cristianesimo – attinge il rapporto tra etica e antropologia, tra libertà e grazia.
Paolo proveniva dal giudaismo osservante, che si considerava destinatario privilegiato dell’alleanza offerta da Dio, incardinata sull’assioma «se osservi la mia Legge, io sarò il tuo Dio e ti colmerò delle mie benedizioni». Ben conosciamo gli esiti a volte drammatici di questo impianto che arrivava a considerare castigo di Dio le malattie e le sventure.
Dopo l’incontro con quel Gesù impersonificato nei destinatari della sua persecuzione, Paolo diventa profeta – si potrebbe dire altrettanto intransigente – della libertà che ci ha guadagnato Cristo.
Per la grazia donataci senza merito, prima di ogni merito, al di là di ogni merito noi siamo stati costituiti figli di Dio e nulla potrà più separarci dal suo amore (se non il rifiuto consapevole).
La religione dell’alleanza predicava: «se vuoi essere alleato di Dio, osserva i suoi comandamenti».
La religione della grazia annuncia: «Sei figlio di Dio, dunque vivi riconoscendo e osservando il comandamento che ti urge dentro e, dal di dentro, ti invita ad amare». Comandamento che assomiglia all’imperativo di mangiare per chi ha fame e bere per chi ha sete.
L’etica scaturisce dall’ontologia
La rivoluzione operata da Paolo è di tipo copernicano, perché al centro non vi è più l’imperativo, ma l’indicativo. Non più «fai così se vuoi essere gradito a Dio», ma «sei gradito a Dio, sei suo figlio, dunque vivi quello che sei». Non è l’etica a definire la nostra ontologia; viceversa è l’ontologia a tracciare l’etica.
La colpa, per quanto grave e capace di deturpare la natura di umani, non potrà mai cancellare l’immagine divina in noi nella quale siamo stati costituiti, né la nostra condizione ontologica di figli.
Chiunque proviene da una comunità cristiana e incontra una persona detenuta, per qualunque motivo (colloquio, servizio umanitario, animazione culturale o sportiva…) sarà motivato ultimamente dalla consapevolezza di servire una persona che è amata da Dio, come me prima, dopo e al di là di ogni merito.
Credo sia questo il cuore del vangelo (buona notizia) che un discepolo di Gesù, a qualunque titolo e in qualunque azione, è chiamato ad annunciare con le parole, con le azioni e perfino col silenzio.
Dalla nuova vita la revisione critica non viceversa
Uno dei titoli principali della valutazione del percorso “trattamentale” da parte degli educatori e dell’équipe nel suo insieme mette a fuoco la “revisione critica” dell’agito e del passato in generale. Ritenendo che questa sia condizione necessaria al reinserimento e a un progetto di vita alieno dal crimine.
Ritengo che il mio compito di cappellano, in continuità e complementarietà con quello degli operatori pedagogici, si muova nella direzione inversa. A me spetta annunciare che la novità di vita è già data come dono, e il progetto di vita che determina l’agire sia espressione di questa vita nuova sempre disponibile piuttosto che strategia per la sua acquisizione.
Primato della mistica sull’etica
Non è operando il bene che si acquisisce la dignità perduta operando il male. È dalla consapevolezza di fede della propria e altrui inalienabile dignità che matura la scelta di operare il bene e negarsi al male.
Il mio compito di cappellano (in quanto prete) non è principalmente quello di ottenere l’adozione – più o meno libera – di determinati comportamenti, ma creare le condizioni che rendano possibile l’esperienza di fede per la quale mi sento amato e degno d’amore prima e al di là di ogni mio gesto.
È da questa esperienza del grande mistero che sono io (mistica) che può (solo può!) maturare la scelta di adottare una costellazione di comportamenti coerenti.
Sento mio dovere e mia vocazione credere ostinatamente in questa possibilità, come solo il Dio di Gesù riesce a credere indefettibilmente, senza la pretesa di controllare l’esito.
«A noi la battaglia, a Dio la vittoria» era il motto di Giovanna d’Arco: faccio tutto quello che è possibile alla mia insufficienza non perché mi sia garantito un risultato, ma nella convinzione che nessun risultato etico sia possibile senza questa premessa “mistica”.
Dalla dignitas infinita alla dignitas in finitis (rebus)
Non vogliate cadere nel tranello di pensare che primato della mistica significhi primato dell’evanescente. Al contrario significa il primato della necessità di “fare esperienza” del mistero (della mia dignità, dell’amore di altri e di un Altro). Per questo i “diritti” o le condizioni connessi alla dignità hanno valenza essenziale e non accessoria.
La dignitas infinita può essere sperimentata solo nella dignitas in finitis.
Su questa declinazione è senz’altro più competente e informato il garante e perciò non mi inoltro. Mi preme soltanto richiamare alcuni aspetti della vita reclusa che contraddicono quanto detto finora, ammesso che abbia qualche verità.
Quando l’assurdo diventa norma
Il diritto positivo è a tutela dell’etica civile o della persona? È una falsa alternativa?
C’è una situazione (in realtà sono tante) nella quale il “sistema penale” italiano – orientato dalla Costituzione al reinserimento – mostra la sua inconsistenza paradossale per non dire assurdità. Quando un imputato ha trascorso in carcere il tempo massimo previsto per la custodia cautelare (non parliamo dell’uso “disinvolto” di questa eccezione a discapito di chi è presunto innocente) e torna alla libertà; riesce a trovare un lavoro, a procurarsi un domicilio, a “metter su” famiglia alla quale promette un futuro; e poi, magari dopo dieci anni, lo raggiunge la condanna definitiva deve andare in carcere, bruciando tutto quanto fin qui costruito, esattamente per ricostruire – con l’“aiuto” del carcere – quel “reinserimento” ottenuto con la sua sola buona volontà. Assurdo? Sì, ma frequente.
Si palesa l’intento inconfessabile quanto condiviso dall’opinione comune che lo scopo dell’esecuzione penale è infliggere una quota (proporzionata) di sofferenza. Rivelatore il commento di Francesco Maisto al progetto di legge che mette a tema l’istituto della liberazione anticipata speciale: «Si consideri che la situazione descritta [il sovraffollamento anzitutto, ndr] sta infliggendo una pena ulteriore, non prevista dal giudice all’atto della sentenza di condanna, per cui il tempo della detenzione genera una sofferenza supplementare che potrebbe e dovrebbe comportare, giustamente, una riduzione del tempo della pena. La responsabilità è dello Stato che non riesce a garantire le condizioni ordinarie – di legge – della pena» (SettimanaNews, 18 aprile 2024).
Devo ammettere che per secoli la teologia cristiana ha giustificato una pedagogia secondo la quale viene riconosciuta al dolore una valenza salvifica, fino a sostenere che Cristo ci ha salvati con la sua sofferenza.
Abbiamo per secoli predicato che quanto più soffriamo – perfino incitando a cercare la sofferenza – tanto più rendiamo gloria e “soddisfazione” a un Dio nei confronti del quale mi dichiaro ateo. Non è il dolore che salva. È l’amore che salva e rende sostenibile il dolore.
L’inflizione di una sofferenza con l’intento di redimere umilia la dignità dell’uomo e contrasta il progetto che Dio ha su ciascuno di noi.
Vita affettiva
La sentenza n. 10/2024 della Corte costituzionale riconosce il diritto a «colloqui intimi, anche a carattere sessuale, con la persona convivente non detenuta, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia».
I commenti – questi sì indecenti – che titolano la notizia parlando di «stanze a luci rosse», sviliscono la “dignitas infinita” dell’intimità affettiva e sessuale di una coppia.
Anche qui devo ammettere che la predicazione della Chiesa ha per secoli rinforzato il pregiudizio malizioso nei confronti degli affetti e ancor più della sessualità, nel contesto di una denigrazione più generale e pregiudiziale del piacere.
Come cappellano sento il dovere di chiedere che venga riconosciuto e apprezzato il diritto all’intimità affettiva, «anche a carattere sessuale» come momento alto di quella “mistica” che ci fa sperimentare capaci di dare e ricevere amore.
Non c’è emozione più contundente nei colloqui con le persone detenute di quando mi sento dire: «Non ho nessuno che mi desideri. Non ho nessuno che mi aspetti. Non ho nessuno che mi chieda come sto e al quale importi se stanotte ho dormito o meno…».
Diritti o esigenze inalienabili?
Sempre certo che dei diritti più consistenti legati alla dignità della persona parleranno il garante e il giudice Casalboni che è stato magistrato di sorveglianza, mi limito a richiamare un paio di esigenze invocate dall’esperienza di chi è privato della libertà di movimento a tutela della propria dignità e necessarie per “restare umani”.
- Il silenzio. Nella celebrazione della messa domenicale, cerco di salvaguardare i piccoli spazi di silenzio previsti dalla liturgia, nella condizione di offrire gocce d’acqua a un assetato. Devo dire che l’offerta non sempre viene accolta, perché in un carcere il silenzio sembra un tabù e tutto sembra quasi organizzato per impedire che via sia qualche bolla di silenzio. Senza silenzio è difficile prendersi cura di sé, difficile entrare in sé stessi e restare umani. C’è abbondanza di silenzio disumanizzante, quello emotivo.
- Il buio. Non ho mai trascorso una notte in carcere e perciò parlo per sentito dire. In carcere non c’è mai buio, esteriore. C’è abbondanza di buio interiore e di vuoto. Non c’è invece mai una pausa dalla sovrabbondanza di stimoli sensoriali (luminosi, uditivi, olfattivi e perfino tattili). Può essere funzionale a coprire artificiosamente il buio interiore.
- La bellezza. Non sembri stonato o eccessivo richiamare questa necessità: la dignità ha bisogno della bellezza per essere coltivata. Non si può volere l’una senza garantire l’altra. Bellezza fatta di parole belle, contristate dal vocabolario umiliante della vita quotidiana. Bellezza fatta di aggettivi e sostantivi, fatta di giudizi che riconoscono il bello e il buono e non si limitano a denunciare il male.
Dignità e gratuità
Come cappellano – al momento cappellano volontario – e ancor prima come figlio di Dio e figlio di questa umanità credo che il contributo più alto a me possibile verso la persona condannata e privata della libertà di movimento consista nell’offerta di una relazione improntata a gratuità.
Le carceri sono affollate di poveri cresciuti in un clima sociale – del quale siamo tutti responsabili – che incoraggia la delinquenza. Non sopporto però il pietismo di certa sociologia che considera i poveri “poverini”. Ognuno resta sempre dignitosamente libero nelle proprie scelte.
Resta pur vero che nei colloqui incontro molti che nella loro vita, anche familiare, hanno conosciuto soltanto relazioni strumentali: “sei qualcuno se mi dai qualcosa”, “vali per quanto puoi darmi”. Per questi la proposta di una relazione gratuita è una sorpresa, fino a renderla “incredibile” e a tentare di ricondurre anche l’incontro con il volontario o il cappellano entro il modello opportunista: «Perché vieni in carcere?» è la prima domanda che ti senti rivolgere.
Sperimentare di essere “meritevoli” di attenzione e premura per il semplicissimo fatto di essere persone credo sia premessa e insieme necessità per ogni ridefinizione di sé come persona e libera.
Cappellano: occuparsi e preoccuparsi
Rispetto alle figure istituzionali – sempre incostituzionalmente poche rispetto alla necessità – il cappellano non è tenuto a stabilire un “contratto educativo” con la persona detenuta e ha l’impagabile opportunità, e il dovere che ne deriva, di offrire una relazione gratuita. Condizione di una dignità incondizionata e di ogni condizionale salvezza.
Credo profondamente e incondizionatamente alla dignità di ogni persona. Come umano e come credente me ne preoccupo. Per il mio ruolo, anche in nome della società civile, me ne occupo, certo che ne vale comunque la “pena”, senza alcuna pretesa di determinare il risultato, ma consapevole che senza la nostra battaglia nessun Dio e nessuna persona avrà la vittoria.