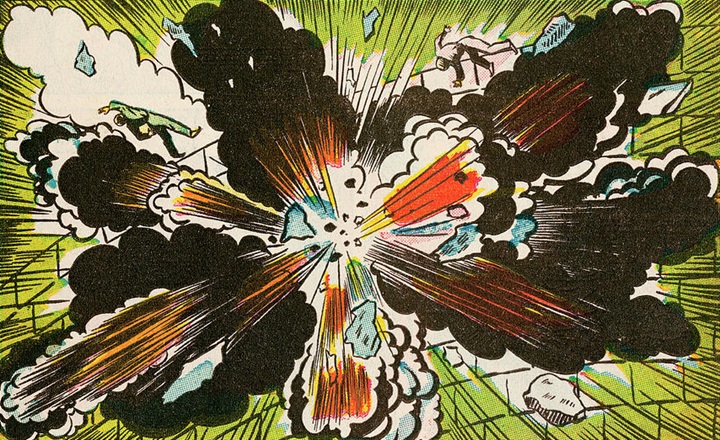
Si parla in tante parti del mondo ogni giorno, ogni ora, di guerra, di vendetta, di attacco e contrattacco, di rappresaglia, raramente si usa il vocabolo violenza, forse perché aveva ragione il grande antropologo francese René Girard che la definì “mimetica”, visto che per lui i rapporti umani sono essenzialmente dei rapporti di imitazione.
Se questo è il discorso teorico evocato da alcuni in questi giorni, nella realtà si percepirebbe una sfiducia tale nei confronti di molti governanti e della politica mondiale da far emergere un nuovo fatalismo, per il desiderio prioritario di porre fine a tutto.
Questi osservatori, allargando il loro sguardo nello spazio e nel tempo, in queste ore hanno ricordato i giorni della vittoria della Brexit; mentre tutti sapevano che sarebbe stata esiziale per chi la faceva, loro hanno deciso di farla, con un voto che chiamano fatalista.
Procedendo con lo stesso metro ritengono che l’estremismo populista di oggi segua impulsi affini, desideri porre fine a tutto, magari per sempre, nella piena sfiducia nei confronti della politica. E la sfiducia nella politica si manifesta in parti diverse del mondo in forme diverse. Si spiegano così, nel mondo arabo, le opposte parti che applaudono le bombe contro Hezbollah, odiata da alcuni, o quelle contro Israele, odiato da molti altri? È l’urgenza impossibile di porre fine a tutto?
***
Guardiamo un attimo agli ultimi accadimenti, che sembrano indicarci la guerra come pulsione che nasce dalla sfiducia definitiva nella politica e che comporta l’identificarsi con l’unico obiettivo ammissibile, porre fine a tutto.
Già anni fa l’accademico libanese Antoine Courban avvertiva che il rischio globale è profondo: “sarebbe la perpetua battaglia notturna tra Giacobbe e l’Angelo nel Libro della Genesi, una battaglia tra rappresentazioni mentali di Dio e dell’uomo. È una guerra infinita di immagini e virtualità, una guerra infinitamente moderna. Il nostro mondo ha messo in soffitta i corpi intermedi che un tempo erano in grado di attutire l’urto di un simile scontro. Ora che non ci sono più terze parti, le energie insospettabili della psiche umana possono finalmente avere libero sfogo. Pace perpetua o orrore metafisico?”.
Un esempio. L’andamento della guerra in corso in Medio Oriente non consente di immaginare un mutamento rapido. Mai lanciarsi in previsioni, soprattutto in Medio Oriente, soprattutto alla vigilia di un voto americano con il Presidente in carica che non corre per la rielezione. Ma l’impressione, che forse sarà smentita nelle prossime ore, è che la diplomazia americana rimbalzi come una pallina che non sa fermarsi tra un cessate-il-fuoco e l’altro, a Gaza o in Libano, senza determinare né l’uno né l’altro. Poi arriverà, ultimativo, il “time out”?
***
Mentre si parla di un orientamento iraniano a far colpire Israele dalle milizie irachene, Netanyahu, scrivono alcuni, intravvederebbe nella possibile elezione di Donald Trump la speranza di un suo disco verde all’attacco contro le centrali nucleari iraniane.
Il candidato Trump nei giorni scorso si era detto favorevole. Da presidente-eletto lo sarebbe ancora? Intanto lui avrebbe avvertito che per il suo insediamento, se eletto, si aspetta di aver la parola fine sulla guerra di Gaza già pronunciata. Forse, coerentemente con la possibilità di una scadenza, i dolorosi avvenimenti che nella striscia si accavallano in un turbine che ad alcuni appare da prima del time-out.
Ma intanto il time out si sposterebbe, dalle elezioni all’ insediamento: si potrebbe recuperare fiducia nella politica?
***
Chi opta certamente per il fatalismo è il giornalista anglo-libanese Mohammad Chebbaro, che nel suo mondo lo vede emergere dal senso di impotenza davanti a Gaza, Libano, Siria, Yemen, Iraq, Sudan, interminabili teatri di distruzione.
“Questo riflette anche una tendenza mondiale di malessere generale che sconfina in una pulsione fatalista, che chiede la fine di tutto. I leader e le istituzioni si fidano sempre meno, mentre la fiducia delle persone nei loro sistemi di governo sprofonda ulteriormente. Questo sta persino portando a una perdita di fiducia nell’etica condivisa della santità della vita umana e delle conquiste storiche comuni, ancorate alla ricerca della pace e della felicità”.
L’attesa che l’arbitro dichiari il time out diviene allora una non-attesa, perché non si ha fiducia nell’arbitro? Non c’è arbitro, non ci sarà vero time out, c’è solo un riprodursi infinito della guerra, un dramma insopportabile che produrrebbe un misto di sfiducia e di abbandono all’ultima violenza.
***
Questa violenza appare allora davvero la parola rimossa, da tutti. E in effetti si parla di guerra, di vendetta, di attacco e contrattacco, non si usa il vocabolo violenza.
L’esempio che Girard fece fu proprio l’11 settembre: “Quando ho letto i primi documenti di Bin Laden e ho riscontrato i suoi accenni alle bombe americane cadute in Giappone, ho capito a un tratto che il livello di riferimento è il pianeta intero, ben al di là dell’Islam. Sotto l’etichetta dell’Islam c’è una volontà di collegare e mobilitare tutto un terzo mondo di frustrati e di vittime nei loro rapporti di rivalità mimetica con l’Occidente. Ma nelle Torri distrutte lavoravano sia stranieri che americani. E per l’efficienza, la sofisticazione dei mezzi impiegati, la conoscenza che essi avevano degli Stati Uniti, gli autori degli attentati non erano anch’essi un po’ americani? Siamo in pieno mimetismo”.
Dunque la parola violenza potrebbe imporre di considerare la necessità di una non-violenza radicale. Ma che cos’è la non-violenza nella realtà? Lasciar massacrare l’aggredito? Forse la riflessione giusta è quella sollecitata da papa Francesco sulla “non-violenza attiva” che dovrebbe considerare soprattutto – o anche – il modo in cui si guarda l’altro, il nemico. Questo forse è un punto da considerare maggiormente.






Sommessamente osservo che dai tempi del lessico democristiano, le “convergenze parallele” ne furono un esempio pirandelliano, il mondo non ne può più di parole a “vanvera”. La “non violenza attiva “ è una stupidaggine che appare colta solo in quanto invenzione di un Papa. Era preferibile il tempo in cui “la guerra era una prosecuzione della politica con altri mezzi”, frase ipocrita e decisamente volgare. Occorre lealta’ e rispetto del prossimo e dire che la violenza è mostruosa sempre. Sia quando si scatena sui campi di battaglia sia tra le mura domestiche a scapito di donne o persone inermi e fragili. Occorre dire che peccato e peccatore sono la stessa cosa e che non esiste possibilità di assoluzione o perdono dell’uomo violento. Di un Dio che permette tutto in nome di un supposto amore per la specie umana, comunque si manifesti, ne faremmo in molti a meno. E’ un Dio inutile, un ossimoro etico, un verboso e petulante impiccione. Credo che vista l’inutilita’ di un intervento divino che non combina mai nulla, sarebbe ora che l’umanità decida da sola come condannare la violenza fino ad eliminarla completamente dalla sua vita.
Per me la “non violenza attiva”, espressione che ignoro in quale contesto sia nata, non può scaturire da un improvviso cambiamento dell’umore di due avversari già sul campo. È più facile che la buona volontà trovi spazio in chi nel complessivo scenario esternamente a un conflitto soprattutto trai diversi che internazionalmente si affrontano, guarda e presumibilmente ha sentimenti di paura, e, in proporzione alla prossimità, di attesa. Non bastano le mozioni di principio o di deplorazione, bisogna che dei contingenti di pace (promossi fattivamente se non materialmente mobilitati dall’ONU) provvedano a fermare nei singoli mandanti le iniziative armate che, sia nel focolaio del nord Europa che in medio-oriente hanno avuto un carattere unilaterale e che adesso non si lasciano fermare da risposte che sono magnetiche di un sempre maggior impiego di mezzi e di vite umane.