Papa Francesco ha chiesto ai vescovi tedeschi che modifichino il versetto della petizione Non indurci in tentazione per un maggiore adeguamento alla traduzione francese (come è già avvenuto nella liturgia di lingua spagnola).
I vescovi tedeschi non lo hanno giudicato opportuno (cf. Settimananews, 29 gennaio 2018). Credo che si tratti di un gesto, dal punto di vista ecclesiologico, importante, perché questo fatto è dovuto al rispetto e alla comunione, mostrando una sana libertà e un legittimo pluralismo nel servizio pastorale.
Con lo stesso rispetto e identico desiderio di comunione, a partire dal servizio teologico (certamente, senza arrogarmi il diritto di rappresentare la teologia), posso tentare di mostrare la mia convinzione, cioè che la ragione sta dalla parte del papa. Lo faccio, perché mi pare che, ben oltre il caso particolare, siano in gioco due delle questioni più urgenti per la teologia e la spiritualità di oggi: la lettura della Bibbia e l’orazione nella sua modalità di petizione.
Letteralismo biblico
Per incominciare, sorprende che praticamente tutta l’argomentazione dei vescovi tedeschi parta da una lettura letterale della Bibbia. Sorprende in modo speciale quelli che, come noi, si occupano soprattutto di teologia fondamentale, facendo sì che la comprensione della fede mantenga, da un lato, la sua coerenza intellettuale e, dall’altro, risulti criticamente assimilabile e cordialmente vivibile. Mantenendo questo presupposto, non potremmo nemmeno chiamare “padre” non solo i sacerdoti ma gli stessi genitori biologici; e, inoltre, seguendo san Paolo, dovremmo imporre un rigoroso silenzio alle donne nella Chiesa.
Una volta che l’esegesi – come ha riconosciuto il concilio – ha reso impossibile la permanenza di una lettura fondamentalista della Bibbia, e la cultura ha imposto come evidente e irreversibile la comprensione teologica che Dio non “interviene”, alla maniera della causalità mondana, nei processi naturali e umani, sorprende che si prendano alla lettera «alcuni episodi impressionanti di dure prove della fede a cui Dio sottopone gli uomini, affinché essi – con il suo aiuto – le possano superare come Abramo (cf. Gen 22) e Giobbe». O che, nonostante si avverta che «questa tentazione e questa seduzione (di cui parla il Padre nostro) rappresentano una forza enorme a cui gli uomini sono esposti e a cui essi stessi si espongono», si possa ammettere, anche come ipotesi: «In teoria, sarebbe possibile che Dio, nella sua santa ira, faccia assaporare fino in fondo agli uomini ciò di cui essi stessi sono colpevoli».
Per fortuna, lo stesso scritto episcopale annulla questa ipotesi, andando al cuore del messaggio di Gesù: «Ma il Vangelo mette in rilievo la giustizia di Dio come misericordia». E ciò indica il cammino vero, che è quello di interpretare la lettera, inevitabilmente espressa nelle condizioni del suo tempo e della sua cultura, in accordo con lo spirito: con lo Spirito. Però duole che questo principio non abbia impregnato tutta l’esposizione, creando così una dura tensione che non solo impedisce di mantenere una sufficiente coerenza logica, ma che, in certe occasioni, come aveva denunciato san Paolo, può portare ad un’opposizione mortale tra la lettera e lo spirito (2Cor 3,6).
Le ambiguità del linguaggio
Di fatto, questa tensione appare con forza nel linguaggio usato nel documento. Di buon accordo, i vescovi ci ricordano una verità teologicamente evidente, prendendola da san Tommaso, e che già prima, tra gli altri, aveva esposto sant’Agostino nella sua Lettera a Proba, cioè che non si tratta di convincere Dio, ma di convincere noi stessi. Però, anziché tirare le giuste conseguenze cercando un linguaggio che esprima questa relazione in modo diretto e veritiero, il documento adotta espressioni che oggettivamente “dicono” qualcosa di diverso e anche di contrario rispetto a quello che dicono le parole o a ciò queste parole vorrebbero dire. Così che si insiste nel mantenere la “petizione” (“Non ci indurre in tentazione”), ma traducendola in valori che sono sì autentici e appartengono all’orazione, ma che non sono petizione: riconoscere la nostra dipendenza da Dio e la fiducia in lui, fidarsi della sua guida, glorificarlo, desiderare che venga il suo Regno e che si faccia la sua volontà. Si dice anche che “pregare” (si noti: non “chiedere” o “domandare”) «è anzitutto ascoltare la parola di Dio».
Però, ripeto, tutte queste espressioni non sono né implicano una “petizione”, e non basta fondere tutto nello stesso concetto, affermando che Dio «esaudisce le domande secondo il suo piano salvifico, che rimane un mistero per gli uomini». Perché non possiamo identificare la profondità inesauribile del “mistero” di Dio con le difficoltà o le contraddizioni logiche del nostro discorso umano. Il potere del linguaggio sullo spirito è di una forza incalcolabile e, senza dubbio, non dipende dalla nostra buona intenzione soggettiva. «Parlare male fa danno alle anime», diceva Socrate.
Chiedere, e farlo con insistenza, in privato e in comunità, nella devozione personale o nella liturgia collettiva, sta modellando l’immaginazione e segnando l’intelligenza con un’immagine di un Dio che bisogna convincere, esortarlo ad avere pietà – Lui, non noi, perché l’espressione come tale suppone che l’abbiamo già – che si ricordi, che abbia compassione… Poco a poco, come una pioggia oscura, questa ripetizione va deformando l’immagine del Dio di Gesù, che è quella di un amore gratuito e di una generosità incondizionata, fino a renderla difficilmente riconoscibile, se non direttamente inaccettabile.
Ripeto, non sto dicendo che questa sia l’intenzione soggettiva. Però, questo è ciò che è dentro la forza oggettiva del linguaggio. Oggi, non solo per necessario rigore teologico, ma per elementare necessità pastorale, non possiamo né dobbiamo disconoscere il suo influsso. A partire dalla linguistica, quindi senza partire neppure da preoccupazioni religiose, il grande linguista Emil Benveniste disse che il «Kyrie eleison può far intendere che Dio potrebbe non avere pietà». E Karl Rahner ha messo sull’avviso qualcosa che la teologia non dovrebbe mai dimenticare: nella cultura di oggi la Chiesa non è padrona di determinare i significati delle parole che usa. Queste sono lette, soprattutto dalle nuove generazioni, conformemente alle definizioni dei dizionari e alle indicazioni dirette e lineari dei mezzi informatici.
Il fondamento della fiducia
È certo che la Bibbia è piena di orazioni di petizione e di esortazioni a praticarle; tutto indica che Gesù stesso abbia pregato così (benché non più di tanto, come indicano le sue notti passate nella preghiera di contemplazione). Sant’Agostino e san Tommaso non potevano prescindere da una lettura letterale dei testi, benché essi stessi notassero la necessità di interpretarli.
Oggi non solo possiamo, ma anche dobbiamo prescindere da questa lettura, andando oltre la lettera fino a giungere all’intenzione – certa ed evidente – dei testi: la fiducia. Se qualcosa segna l’esperienza personale e l’annuncio di Gesù è la sua fiducia nell’Abbà, che si volge con un amore infinito e con un perdono incondizionato verso i suoi figli e le sue figlie, tanto che non gli sfugge neppure la caduta di un capello dalla nostra testa e che “molto più” di qualsiasi padre o madre di questa terra è ben disposto e sempre attivo nel procurarci il bene.
La traduzione e la coltivazione di questa relazione fondamentale, di questa instancabile presenza salvifica, non è la sfiducia, ma la fiducia, non il convincere ma lasciarsi convincere, non la petizione ma l’accoglienza. Cosa che non impedisce di manifestare davanti a Dio i nostri desideri e speranze, i nostri bisogni, gioie e angustie… tutto a condizione di esprimere con giustizia e fedeltà la verità della nostra situazione davanti a Lui. In definitiva, dobbiamo pregare con formule che ci aiutino a riconoscere, a vivere e a confermare la sicurezza che Dio ci sta sempre aiutando e che spetta a noi accogliere il suo aiuto, cercando di ascoltare i suoi appelli e a lasciarci guidare dalla sua grazia.
Credo che si possa dubitare che la “traduzione” adottata dai vescovi tedeschi sia pienamente fedele all’intenzione più profonda e genuina di Gesù. Ne abbiamo una prova eloquente anche in un testo che non solo ha molte possibilità di essere uscito dalla sua bocca, ma che presenta l’unica occasione nella quale ci viene trasmessa una sua considerazione espressamente critica circa il senso dell’orazione: «Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate» (Mt 6,7-8) A questo allude il documento: «Non sprecare parole come i pagani ( Mt 6,7), ma parlare nella libertà dei figli di Dio, come Gesù ha insegnato».
Il problema della tentazione come sintomo e chiamata
Benché riguardi l’orazione centrale del cristianesimo, il dialogo sulla tentazione non cessa di girare attorno a un problema limitato e molto concreto. È il sintomo della situazione generale originata dall’ingresso della Modernità. La critica biblica e l’autonomia funzionale del mondo stanno esigendo una nuova traduzione, veramente aggiornata, del messaggio cristiano. Però, invece di affrontarla come tale, la teologia si è soffermata sulle difficoltà particolari, a misura che i dubbi o le sfide andavano affiorando. In questo modo, le difficoltà non hanno potuto ricevere quell’attenzione che le integrasse in una visione d’insieme, ricevendo anche quella luce che, secondo il Vaticano I, nasce dalla connessione dei misteri che sono tra loro distinti.
Il tema della tentazione, come abbiamo visto, può essere affrontato solo nel quadro più generale e incisivo della petizione che, a sua volta, porta a quello dell’orazione come tale. Una nuova formulazione, che faccia riferimento con rigore alla gratuità e alla generosità infinita del Dio annunciato da Gesù, aspetta e sollecita con urgenza una nuova formulazioni nella pietà individuale e, soprattutto, nella celebrazione liturgica. Compito ingente per la sua portata, però di una necessità così grave e urgente da ben meritare lo sforzo.
Lo stesso documento dei vescovi tedeschi riconosce fin dall’inizio questa implicazione generale: «Ma è importante prendere sul serio l’osservazione critica di papa Francesco e considerare positivamente l’ampio dibattito che ne è derivato. È importante cogliere l’occasione per spiegare in maniera più approfondita il significato della domanda del Padre nostro in relazione con l’immagine cristiana di Dio e la comprensione cristiana del rapporto tra l’uomo e Dio». Di fatto, il documento termina segnalando con lucida onestà che, molto concretamente, il tema dell’orazione si riallaccia anche all’enorme problema del male. E afferma che «il Padre nostro non risponde al problema della teodicea: perché il dolore, il male e la tentazione? Perché Dio permette tutto ciò?».
Però, basta prestare attenzione all’ultima domanda per avvertire che, come indicavano i numerosi riferimenti precedenti, il documenta continua ad inquadrare il male in una lettura che suppone che Dio possa mandarlo o almeno che potrebbe evitarlo, se lo volesse. Per questo, benché abbia messo in guardia con preoccupazione pastorale che non si deve dire: “Sono tentato da Dio”, il documento prende alla lettera testi che parlano di «dure prove della fede a cui Dio sottopone gli uomini», tirando come conseguenza: «Proprio per questo c’è la preghiera di domanda». Idea che si ripete anche alla fine, alludendo «all’esperienza indecifrabile che Dio metta alla prova una persona oltre le sue forze».
Per questo è necessario formulare una visione che, conseguente con l’autonomia funzionale del mondo, esige di elaborare una “ponerologia”, cioè una scienza del male, che mostri il carattere inevitabile del male a causa della finitezza del mondo. Non per dire che Dio “non può” evitare il male (come tante persone e anche alcuni teologi sostengono in una visione disperata, per mancanza di una teodicea aggiornata), ma che, come aveva già avvertito san Tommaso, il «non può essere evitato» (cf. STh I,q.25,a.3c). Detto diversamente, ogni volta che si prega chiedendo che Dio eviti qualche conflitto, oppressione o sofferenza, si fa supporre che è Lui che manda il male o, almeno, colui che, potendolo, non vuole evitarlo. Dentro una nuova situazione culturale, il male continuerà ad essere la “roccia dell’ateismo”.
Per questo è motivo di gioia osservare come il buon istinto teologico del documento, concluda con una preziosa e feconda affermazione che, procedendo dal genuino substrato evangelico, apre la porta a un modo di pregare che, nonostante il mantenimento della parola “petizione”, smentisce il suo senso letterale e prescinde da essa, insegnando che il suo vero senso è la fiducia in Dio e la certezza del suo amore: «La domanda: “Non ci indurre in tentazione” non ha lo scopo di convincere Dio affinché si decida a non indurre l’orante in tentazione. Piuttosto unisce insieme il riconoscimento della propria debolezza, la fiducia nella guida di Dio e la ferma certezza che la sua guida non ci porta verso l’abisso».
Una domanda umile e piena di rispetto: non sarebbe meglio dirlo direttamente nella stessa preghiera del Padre nostro, che ha un grande influsso nella pietà e che è sempre nel cuore della nostra fede?




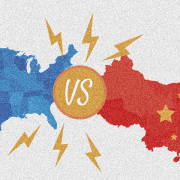

Non so nel tentativo di “ripulire” Dio da immagini troppo umanizzanti (Dio che in qualche modo manda il male) mi pare che si ritorni al vecchio motore immobile aristotelico, con il male che diventa casiale e nelle stesso tempo necessario.
Un passo avanti o uno indietro?
Le acute osservazioni di A.T. Queiruga date, forse, dalla sua grande cultura non solo filosofica ma anche teologica sono sempre “punzecchianti” al punto giusto.
Ormai, dalla conoscenza che io ho di alcuni suoi testi, è da anni che egli continua a mettere in guardia certa teologia affinché abbia il coraggio di mettere in “crisi” certi schemi del passato per entrare in dialogo con la Modernità e la post-Modernità. La teologia di Queiruga, infatti, nei diversi temi della trattazione da lui svolta continuamente ha messo al centro il verbo “ri-pensare” per ri-esporre i contenuti della fede cristiana in maniera “aggiornata” e “comprensibile”/”all’altezza” delle sfide insite nel pensiero contemporaneo.
La sua trattazione sul “Padre nostro” e la domanda a Dio di “non lasciarsi cadere/non indurci alla tentazione” è profondamente inserita all’interno della sua indagine ed esposizione teologica.
Ma sembra ancora che in “alcune” zone della Chiesa cattolica si sia ancora lontani…
ottimo.