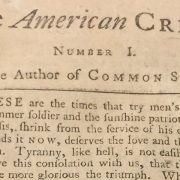“Non rubare” è un comandamento facile da capire, indicato nel Libro dell’Esodo tra le dieci prescrizioni dettate da YHWH a Mosè ai piedi del Monte Sinai, che diventeranno anche i nostri comandamenti. Il Vangelo di Matteo racconta di un tale che chiede a Gesù: «Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Gli rispose: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Gli chiese: Quali? Gesù rispose: Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso» (Mt 19, 16-19).
Quando si pensa al “non rubare”, l’immediata reazione è la paura dei ladri e degli scassinatori che, negli ultimi tempi, si sono moltiplicati e incattiviti contro persone, famiglie, artigiani, commercianti, industriali, tutti costretti a difendersi contro nemici violenti e – cosa più grave – spesso imprendibili.
La paura, giustamente, è forte ed è difficile perdonare chi ha forzato la porta di casa o si è introdotto furtivamente durante il sonno, malmenando addirittura, per rubare cose che non gli appartengono.
È facile dunque concludere che chi non ha mai commesso (né commetterà) tale delitto si senta rassicurato di non essere stato ladro.
La dottrina della Chiesa
In realtà, il “non rubare” si riferisce a tutto il mondo dell’economia che permea la nostra vita. Investe i problemi della proprietà, delle imprese, dello Stato, del lavoro, della finanza, dell’economia internazionale.
Lo schema primitivo del comandamento fa appello alla giustizia, chiamata – secondo la morale classica – giustizia commutativa. Ciò che è mio è mio, ciò che è tuo è tuo. A ognuno il suo. Nella nostra epoca il possesso dei beni è di una tale sacralità da identificare i beni che si posseggono con la propria storia. La stima delle famiglie passa anche dalla grandezza dei beni: genitori, figli, eredità compongono una lunghissima catena che supera le generazioni e può creare litigi, odi, rancori.
Per la verità, la storia del cristianesimo ha una visione un po’ diversa. Il Catechismo della Chiesa cattolica, voluto da Giovanni Paolo II e confermato da Benedetto XVI, scrive: «Il diritto alla proprietà privata, acquisita o ricevuta in giusto modo, non elimina l’originaria donazione della terra all’insieme dell’umanità. La destinazione universale dei beni rimane primaria, anche se la promozione del bene comune esige il rispetto della proprietà privata, del diritto ad essa e del suo esercizio» (n. 2403).
In parole più semplici, poco più sopra, il Catechismo dichiarava: «All’inizio, Dio ha affidato la terra e le sue risorse alla gestione comune dell’umanità, affinché se ne prendesse cura, la dominasse con il suo lavoro e ne godesse i frutti. I beni della creazione sono destinati a tutto il genere umano. Tuttavia la terra è suddivisa tra gli uomini, perché sia garantita la sicurezza della loro vita, esposta alla precarietà e minacciata dalla violenza. L’appropriazione dei beni è legittima al fine di garantire la libertà e la dignità delle persone, di aiutare ciascuno a soddisfare i propri bisogni fondamentali e i bisogni di coloro di cui ha la responsabilità. Tale appropriazione deve consentire che si manifesti una naturale solidarietà tra gli uomini» (n. 2402).
Si può rubare “legalmente”
Il settimo comandamento ha, dunque, una relazione stretta tra la propria ricchezza e il benessere di tutti. In genere, lo Stato interviene a equilibrare il benessere del proprio popolo. È chiamata giustizia distributiva. Per mezzo di leggi e regolamenti si garantiscono risorse per servizi essenziali che riguardano l’intera popolazione. È la politica dei tributi e delle imposte che hanno un rapporto diretto con la scelta dei governi che stabiliranno i termini di questa giustizia. Un lavoro difficile e interpretabile in maniera diversa.
La differenza tra le visioni politiche differenti si può riassumere – al di là delle parole – tra chi persegue il benessere di tutti e chi invece difende la tutela di pochi. Una dialettica difficile, perché nessuno mai dirà di voler difendere alcune categorie di persone a svantaggio di altre.
Di fatto, nella nostra epoca, è comune opinione che la libertà di ognuno permetta l’arricchimento senza confini.
La dialettica del progresso investe il grande problema del rapporto tra impresa e lavoro. Di fatto, nella politica economica prevalente, all’imprenditore (sia esso industriale manifattore o commerciale) non è preclusa nessuna operazione che faccia ottenere il maggior profitto per i beni che produce.
Il lavoro, indispensabile per ogni produzione e commercio, è regolato, almeno nelle democrazie evolute, dai cosiddetti contratti. Il rapporto tra benefici imprenditoriali e lavorativi è imposto dalle leggi, dalle consuetudini e dai rapporti di forza. Nessuno ha mai stabilito l’equilibrio che deve intercorrere tra chi fa impresa e chi collabora all’impresa.
Scandali recenti hanno dimostrato che la sperequazione tra azionisti, manager e semplici lavoratori aumenta costantemente fino ad arrivare a sproporzioni inimmaginabili.
La domanda è semplice e ingenua: qualcuno ruba (anche se legalmente)?
Lo sfruttamento
Altro capitolo che riguarda il “non rubare” è dato dal cercare presso paesi poveri materie prime, manodopera, lavorazioni pericolose, depositi illegali. Le grandi aziende, con enormi possibilità tecniche e finanziarie, si sentono libere di contrattare lavori e ricerche a proprio vantaggio, là dove l’arretratezza e la povertà non offrono sufficienti resistenze. Con parole esplicite di tratta di sfruttamento. È un peccato grave perché, se gli investimenti hanno costi e rischi, ci dovrà pur essere una linea che demarca il giusto dall’ingiusto. Lo conoscono bene coloro che hanno in mano le decisioni imprenditoriali.
 È un problema che riguarda l’intera umanità. Adeguati compensi possono diventare occasione di progresso per le popolazioni più arretrate alla sola condizione di lasciar loro spazio per un benessere reale.
È un problema che riguarda l’intera umanità. Adeguati compensi possono diventare occasione di progresso per le popolazioni più arretrate alla sola condizione di lasciar loro spazio per un benessere reale.
Purtroppo nessuna legge universale o locale riesce a delimitare gli spazi per un onesto investimento con conseguente onesta remunerazione.
La dottrina sociale della Chiesa da sempre ha enunciato principi morali di equità: non altrettanto le leggi civili, soggette a variabili politiche, economiche e sociali imponderabili. È l’accorato e continuo appello di papa Francesco per la giustizia e la salvaguardia del creato.
Infine, sono in crescita gli investimenti finanziari che se, teoricamente, servono a incrementare iniziative imprenditoriali (vedi la Borsa), sono diventati nel tempo un “gioco” di accumulo di ricchezza, movimentando in continuazione risorse monetarie.
La crisi economica, che è iniziata nel 2008 e dalla quale non siamo ancora usciti, è iniziata con il fallimento della banca americana Lehman Brothers Holdings Inc. fallita per oltre 600 miliardi di dollari.
La gestione dei risparmi e degli investimenti, in termini esclusivamente finanziari, aveva avuto un collasso che si è esteso a tutta l’economia mondiale.
Per la verità, già nel XIV secolo era iniziata la discussione se il denaro prestato dovesse essere remunerato. I moralisti francescani, che avevano inventato il Banco dei pegni, sostenevano che il prestito a interessi era usura, e per questo era peccato.
Le compagnie di navigazione veneziane e olandesi iniziarono a imporre tasse per i rischi (naufragi, pirati…) assicurativi dei loro commerci. La dottrina della Chiesa, per qualche decennio, continuò ad affermare si trattasse di usura, finché nel 1800 questo orientamento cessò.
Da quel momento i depositi, i prestiti e gli investimenti sono diventati legali, con conseguenze non gestibili, in quanto è prevalsa definitivamente la tendenza al massimo profitto, senza altra considerazione. In sintesi, l’attività finanziaria rischia di diventare un volano di arricchimento indebito.
Non c’è traccia nelle coscienze dei più che si tratti di violazione del settimo comandamento.
Per essere sinceri, sembra che, nonostante la dottrina sociale, gli orientamenti della cristianità, in economia, siano ambigui. La proprietà privata serve a dare libertà e dignità, ma nessuna forza morale ha fissato i criteri dell’arricchimento personale. Da qui le tragedie che investono gli ultimi e i penultimi.
Il Documento finale del Sinodo amazzonico insiste molto sulla conversione personale e pastorale. Il dubbio atroce è che i richiami solenni e partecipati di milioni di persone rimangano lettera morta nella tenaglia di una politica e di un’economia che continueranno a rubare: alla terra, alle popolazioni e, alla fin fine, alla dignità umana.
Vinicio Albanesi: I Comandamenti
Decimo, non desiderare la roba d’altri.