Vorrei rispondere qui, su Settimana News, a un articolo apparso su questa rivista (12 dicembre 2024), scritto da Paolo Trianni, in cui viene presentata una recente pubblicazione di Stefano Fenaroli dal titolo La teologia della Deep Incarnation. Si tratta di una dissertazione dottorale in teologia, pubblicata dalla casa editrice Queriniana. Paolo Trianni espone le caratteristiche principali di questa dissertazione, presentata alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, il cui relatore è stato il professor Alberto Cozzi.
In questa mia nota, mi concentrerò su quanto Stefano Fenaroli afferma nel sesto capitolo del suo libro: La teologia della Deep Incarnation. Indagine, dialogo e prospettive (Queriniana, Brescia 2024). In quelle pagine (pp. 353-426), l’autore vuole confrontarsi con il mio lavoro di ripensamento post-teista della fede cristiana, presentato nel mio recente volume, Deus DuepuntoZero (Gabrielli Editori, San Pietro in Cariano 2022).
L’intenzione «ambiziosa» del mio lavoro
Paolo Trianni, nella sua esposizione, richiama alcune delle fonti del mio pensiero, facendo riferimento alle opere che ho pubblicato in giovane età. In particolare, cita la mia dissertazione teologica del 1992, dedicata al tema dell’analogia nel pensiero del teologo luterano Eberhard Jüngel. In quel lavoro, seguendo la prospettiva di Jüngel, tentavo di elaborare un’analogia fidei ispirata a un modello di ontologia relazionale. Nel 2005 scrissi un manuale di cristologia, intitolato Questo Gesù. Pensare la singolarità di Gesù Cristo (EDB, Bologna 2005). Proseguendo la riflessione sulla singolarità di Gesù, ho cercato in quest’opera di approfondire ulteriormente l’ontologia relazionale attraverso un cammino storico-critico sulla figura di Gesù e una rilettura dei dogmi cristologici.
Desidero fare, innanzitutto, una precisazione importante: tra il 1992 e il 2022, anno di pubblicazione del mio libro Deus DuepuntoZero, trascorrono trent’anni. Sono un tempo lungo. In trent’anni, una persona cresce, matura. Il pensiero evolve, integra nuove prospettive, riconsidera aspetti trascurati in precedenza. Come ricorda papa Francesco, il pensiero è incompleto, e ciò vale ancor di più per quello teologico, segnato dalla fragilità e dall’autocritica davanti alla Parola del Mistero.
In particolare, due dimensioni hanno guidato la mia ricerca teologica in questi ultimi anni e mi hanno portato a «rivedere» il paradigma dell’identificazione escatologica così come elaborato da Eberhard Jüngel: il dialogo con le altre religioni e la dimensione cosmica della cristologia. Ne è scaturita una cristologia più inclusiva, capace di cogliere la singolarità di Gesù Cristo in rapporto al cosmo e alle altre tradizioni religiose.
Alterità di Dio e della creatura
A questo punto, voglio esaminare alcune delle obiezioni che mi sono state sollevate. La prima questione riguarda il modo di intendere il rapporto tra il finito e l’infinito, tra alterità divina e creatura.
Mi viene obiettato che la mia posizione teologica sia eccessivamente sbilanciata sull’identità di Dio, fino al punto di «annichilire» la creatura. Più volte, infatti, nell’opera Deus DuepuntoZero e in articoli precedenti (dal 1995 a oggi), ho utilizzato una particolare equazione per esprimere la tesi di fondo del Monismo Relativo: x = x + y. Con questa equazione voglio indicare che l’identità di Dio (rappresentato da «x», cioè l’incognito) si dà nella relazione con la creatura (indicata con «y»). Questa relazione non aggiunge nulla all’identità di Dio (x = x).
Perché ciò sia possibile, l’essere della creatura (y) deve essere compresa in termini di relazionalità. Senza questa relazionalità, la creatura «non è», non ha un’esistenza autonoma. Ciò che costituisce l’autonomia della creatura è proprio la sua relazionalità. Per esprimere che la creatura è nulla senza la relazionalità a Dio, utilizzo il simbolo: y = 0. Dire che la creatura in sé è «nulla», significa affermare che essa va compresa in praedicamento relationis, cioè che è nulla se si prescinde dalla sua relazionalità-a-Dio.
Il mio pensiero non intende affatto annichilire la creatura ma rilevarne la sua totale e radicale relazionalità.
Panenteismo e creaturalità
Paolo Trianni e Stefano Fenaroli fanno riferimento a una visione panenteistica entro cui comprendere Dio, il creato e la loro relazione. Questa è anche la prospettiva di molti esponenti del cosiddetto «Teismo personale», noto anche come «Teismo aperto» (Open Theism).
Vi sono sostenitori del panenteismo – come Gregersen, Edwards e altri – che giungono ad affermare che Dio si lascia muovere, com-muovere dalla creatura. Ma anche qui, niente di nuovo! Già lo diceva Jüngel. «[L’essere creato] muove dall’interno l’essere del Dio che crea»[1]. Questo lasciarsi muovere, tuttavia, non implica un mutamento nella natura divina. Sorprende che Fenaroli, nel sesto capitolo del suo libro (p. 409), non si accorga della «leggerezza» delle sue affermazioni. Da un lato, mi contesta che «[l’] evento dell’incarnazione […] non è qualcosa di “già presente” in un Dio ultimamente immutabile»; e, dall’altro, afferma un «divenire di Dio» senza precisare teoreticamente tale affermazione.
L’incarnazione è certamente il divenire «di Dio», ma non nel senso che da un Dio del prima dell’incarnazione (ἄσαρκος) si passi a un Dio del dopo (ἔνσαρκος) l’incarnazione, come se ci fosse una alter-azione di Dio (genitivo soggettivo). Come se ci fosse un prima e un dopo in Dio, per voler così affermare a tutti i costi una novità in Dio.
La risposta di Rahner è chiara. «Il Dio in sé stesso immutabile può, in un altro, essere mutevole, può cioè diventare uomo»[2]. Non è che Dio diventi altro, nel senso di alterarsi, ma Dio diventa «in» altro. Questo «altro», in cui Dio diventa mutabile, è l’uomo Gesù. Il divenire di Dio, dunque, significa che la storia di Gesù (nascita, vita e morte) appartengono, definiscono Dio. Gesù è la definizione di Dio, e, dato che il finito è essenzialmente «storico», Gesù è la storia di Dio.
Come predicare di Dio una novità che sia né un mutamento di Dio, né riferita solamente alla creatura? La vaghezza o leggerezza della posizione di Fenaroli non è capace di articolare coerentemente una risposta. Cosa invece che il punto di vista sub specie aeternitatis consente[3].
Singolarità di Gesù Cristo
Mi viene rivolta la critica che, nella mia teologia attuale, non sottolinei in modo sufficiente la differenza tra Gesù Cristo e l’umanità. Secondo alcuni, questa carenza comprometterebbe la comprensione della «singolarità» di Gesù Cristo. In questo senso, cadrei in contraddizione con quanto affermavo nel mio testo Questo Gesù. Pensare la singolarità di Gesù Cristo.
Rispondo dicendo che è stata la frequentazione con le teologie del pluralismo religioso, in particolare con i testi di Jacques Dupuis e Paul Knitter, che mi hanno portato a riconsiderare il rapporto tra la singolarità di Gesù Cristo e la storia della salvezza universale. Ritengo che l’evento dell’unione ipostatica sia certamente unico, ma non esclusivo.
Nel mio testo Deus DuepuntoZero comprendo l’unicità dell’incarnazione nell’orizzonte di ciò che Rahner chiama cristologia evolutiva. Per il teologo gesuita, l’incarnazione di Dio in Gesù Cristo costituisce il «caso supremo dell’attuazione essenziale della realtà umana, attuazione consistente nel fatto che l’uomo è colui che si abbandona al mistero che chiamiamo Dio»[4]. Si sente qui l’influenza di Teilhard de Chardin.
Secondo Rahner, l’unione ipostatica rappresenta l’evento fondativo di un movimento più ampio, in cui l’intero mondo viene compreso come orientato verso Dio, diretto verso il suo compimento escatologico[5]. L’incarnazione è «uno e un solo evento» non per l’identità del Verbo, ma perché unico è l’evento apicale, culmine e anticipazione dell’unione divino-umana.
Questo processo dinamico della unione tra divino e umano è compreso secondo una cristologia non solo evolutiva ma anche ispirata al calcedonismo cristologico. È importante sottolineare che Rahner ne segue la forma «pura» e non la sua variante neo-calcedonese.
In un suo saggio fondamentale, Rahner così riassume la sua prospettiva: «Gesù è un vero uomo, un genuino frammento di terra, proprio un momento interno del divenire biologico di questo mondo, un prodotto della storia naturale umana, in quanto è nato da una donna. È un uomo, il quale è, al pari di noi, un soggetto ricevente di quella autocomunicazione di Dio per via di grazia che noi affermiamo goduta da tutti gli uomini, e quindi anche dal cosmo come punto culminante dell’evoluzione, nel quale acme il mondo raggiunge in modo radicale sé stesso e la più stretta unione con Dio. Egli è colui il quale […] ha dato la più perfetta accoglienza della grazia donatagli da Dio e ottenuto il più perfetto accostamento con lui, realizzando così sino al massimo grado le caratteristiche umane da lui possedute»[6].
La singolarità dell’esperienza di Gesù non è un evento «meteora» isolato, ma costituisce un punto culminante all’interno di una storia evolutiva e culturale.
Eschaton e divinizzazione personalista
Un’altra critica che mi è stata rivolta riguarda la prospettiva escatologica della mia teologia. Secondo alcuni, la mancata affermazione dell’identificazione singolare ed esclusiva di Dio con l’evento di Gesù Cristo comporterebbe una perdita del carattere personale dell’evento finale escatologico, quando tutto sarà ricapitolato in Cristo (cf. Ef 1,10). Secondo questa interpretazione, la mia concezione della divinizzazione universale rischierebbe di dissolvere il creato in una vaga e amorfa unità con il divino, che annulla le individualità (cf. Deus DuepuntoZero, 461-464).
Quando affermo che l’io si perde nel Sé di Cristo (cf. Mc 8,34-35; Mt 16,24-26; Lc 9,23-25; Gv 12-23-25) non faccio altro che riferirmi a ciò che Teilhard de Chardin e Bede Griffiths sostengono. Nel saggio Cristianesimo e Panteismo, Teilhard sottolinea che nel «Punto Omega» l’unità e la molteplicità, la personalizzazione e l’unione, crescono in modo direttamente proporzionale[7].
Le singole personalità, nell’unità cristica, non si confondono, ma si comprendono in una nuova relazione nonduale, cioè non più separate le une dalle altre (cf. Ef 2,15-16). In tal senso viene in aiuto anche il monaco benedettino Bede Griffiths che nel suo Commento alla Bhagavad Gita, risponde alla questione di come unità e molteplicità si coniughino insieme nella identità divina, affermando che nel corpo mistico di Cristo, gli individui non sono più isole separate, ma persone pienamente realizzate in un «nuovo soggetto più grande»[8]. Unici nell’uni-cum[9].
Conclusioni
Spero di avere risposto alle critiche mosse da Stefano Fenaroli, e fatte proprie da Paolo Trianni. Queste critiche derivano principalmente da estrapolazioni non accurate di alcune affermazioni del mio testo; da una mancata comprensione dell’ontologia relazionale che assumo nel mio lavoro; da una scarsa considerazione del Monismo Relativo come base per la mia riflessione, una prospettiva più affine alle ricerche sul Panenteismo iniziate da Klaus Müller (Università di Münster, Germania) piuttosto che all’ontologia relazionale della Scuola Milanese.
Ciò che ho presentato qui è solo un abbozzo di riflessioni che avrò modo di articolare ulteriormente in altra sede. Spero che il dibattito intorno a questioni così essenziali per la fede cristiana e sui vari modelli di ontologia relazionale possa continuare ad animare la già vivace e feconda teologia italiana.
Mi auguro, inoltre, che il confronto possa svolgersi nello spirito della trans-disciplinarietà auspicata da papa Francesco, permettendo una crescita condivisa e una maggiore comprensione delle sfide che il pluralismo religioso e la visione cosmica della fede pongono alla teologia contemporanea.
[1] Eberhard Jüngel, Dio mistero del mondo, Queriniana, Brescia 1982, 59.
[2] Karl Rahner, Corso fondamentale sulla fede, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1990, 288.
[3] Cf. Giuseppe Barzaghi, «Anagogia e teoria del fondamento», in Divus Thomas, 119 (2016), 17-47, ivi 43.
[4] Ibidem, 285.
[5] Cf. Ibidem, 241.
[6] Karl Rahner, «La cristologia nel quadro di una concezione evolutivo del mondo», in Saggi di cristologia e di mariologia, Paoline, Roma 1965, 164.
[7] Cf. Teilhard de Chardin, «Panteismo e Cristianesimo», in Pierre Teilhard de Chardin, La mia fede. Scritti teologici, Queriniana, Brescia 1993, 77.
[8] Cf. Omelia del Sabato Santo di Epifanio di Salamina. Omelia di Papa Benedetto XVI della Veglia di Pasqua 2006.
[9] Bede Griffiths, Rivers of Compassion. A Christian Commentary on the Bhagavad Gita, Amity House, New York 1987, 171.
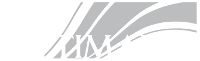





E’ lodevole tutta questa voglia di dialogare. Ma siamo sicuri che l’ l'”altro” ne abbia interesse? Ho scoperto che dialogo e egemonia viaggiano di pare passo. Tra l’agnello e il lupo al ruscello è possibile che l’agnello dica al lupo “io sono aperto al dialogo?” La missionologia ha sempre mostrato altre strade per comunicare il mistero di Cristo. Chi oggi potrebbe fare più di Matteo Ricci?
Paolo Gamberini è un vecchio amico, che ha sempre goduto e gode di tutta la mia stima non solo intellettuale, ma anzitutto umana. Forse la teologia è quello che lui fa, ma io ho sempre avuto difficoltà a seguirne l’andamento – non solo suo, dei teologi in genere – parendomi che se dobbiamo procedere per via di speculazione è difficile andare molto più in là di Hegel. In ogni caso, non mi permetto di affrontare il merito: la modestia dei miei mezzi me lo impedisce.
Ciò nonostante, mi sono assunto la fatica (ma anche il piacere) di leggere il suo Deus DuepuntoZero, perdendomi là dove si slancia in (per me troppo ardite) acrobazie teologico-concettuali e condividendone invece appieno il tentativo di sgombrare dalla comprensione cristiana della vita e del mondo ogni “retaggio mitologico” (ancora troppo pesante e insopportabile).
E’ proprio su questa strada che auspicherei un passo avanti, prendendo sul serio l’assoluta irrilevanza e insignificanza per il “sentire collettivo contemporaneo” (mi si scusi questa volgare generalizzazione) di tutto ciò che è cristianesimo. Per la maggior parte delle persone, le parole della tradizione cristiana sono scatole vuote e non manca assolutamente nulla quando manca Dio. Su questo, io credo, si devono concentrare energie, passione, pensiero, perché questo è il dramma della Chiesa (e della società) e da lì sorge il “de profundis” che le si sta intonando…
Per carità, la teologia è “quella cosa di concetti” che deve mettere insieme “fides” e “intellectus” e ha tutta la sua legittimità. Ma – sia detto con ogni rispetto verso l’amico Paolo e tanti altri illustri teologi – siamo sicuri che una tale “farmacia concettuale” specializzata nelle “questioni intime di Dio” parli all’indifferenza del nostro diffuso agnosticismo? Tra la speculazione teologica e il deserto del mondo si stabilisce una distanza mortale che rende asfittici e invivibili entrambi.
carissimo Giovanni, piacere di leggerti qui! Due rilievi. Gli slanci e le acrobazie teologico-concettuali (cf rivisitazione della dottrina dell’impeccabilità di Gesù, etc..) tentano di dire il “di qua” del mistero… non l’aldilà del mistero. Il linguaggio teologico, come quello del dogma, rimane e deve essere sempre convinto di essere solo un indice, non la luna indicata . Il “di qua” del mistero è fatto di carne, affetti, emozioni, pensieri, immagini che sono “feriti” dalla nostalgia del ritorno a casa (Ge-heimnis – Heim, cioè Mistero/Casa) e hanno bisogno di essere guariti (ecco la farmacia!). Anche la speculazione serve a guarire. L’etimologia della parola guarire è riconducibile all’antico germanico warjan = mettere al riparo, difendere, proteggere, a sua volta, dalla radice var- = guardare o anche coprire (entrambi nel senso di curare, proteggere). Identica radice si trova nell’inglese “to ware” = curare, proteggere, e “to be aware”, essere consapevoli. Il logos è ferito (il pensiero), così come le ferite dell’umanità hanno bisogno di essere curate (carità) . C’è bisogno sia dell’uno che dell’altro. Diffuso agnosticismo? Girando per l’Italia e all’estero, l’interesse della gente (cosiddetta “normale”, non “accademica”) mi rendo sempre più conto di quanta gente abbia fame e voglia di teologia. Fenaroli mi ha individuato (anche) per il fatto di essere presente nei social (FB, Blog). Ebbene, è proprio lì nei Social che incontro molte persone interessate a mettere in discussione ciò che chiami diffuso agnosticismo. Non è un caso che Papa Francesco abbia invitato le facoltà teologica ad aprire ai laici – di mezza età – le porte delle facoltà. Dovunque c’è ricerca di senso e vi sono ferite nella ricerca, c’è sempre una farmacia aperta.
Sempre un piacere rileggerti, Paolo. Mi permetto di lasciare, come provocazione comune (a tutti, non solo a noi due) quanto scriveva, ben 30 anni fa, la 34a Congregazione Generale della Compagnia di Gesù, Decreto 4.
“La linea di confine tra il Vangelo e la cultura moderna e postmoderna passa attraverso il cuore di ciascuno di noi. Ogni gesuita incontra l’impulso all’incredulità anzitutto in se stesso, e soltanto quando sappiamo confrontarci con questa dimensione in noi stessi, possiamo parlare agli altri della realtà di Dio. Di più, non possiamo parlare agli altri se il linguaggio religioso che usiamo è completamente estraneo a loro: la teologia che usiamo nel nostro ministero non può ignorare l’orizzonte delle questioni critiche moderne, entro il quale noi pure viviamo. Soltanto quando la nostra esperienza e comprensione di Dio producono senso, possiamo dire cose che hanno un senso per l’agnosticismo contemporaneo.
Questo è un ministero che non dovrebbe ignorare la tradizione mistica cristiana, la quale ripetutamente tratta dell’esperienza di Dio senza parole e senza immagini, al di là di ogni concetto: Si comprehendis, non est Deus, diceva Agostino. L’esperienza del silenzio che avvolge la natura di Dio può essere il punto di partenza per molti nostri contemporanei, ma ha luogo anche nel profondo della fede e dell’esperienza cristiana. Si ha una frammentazione della fede cristiana in Dio nella cultura postmoderna, in cui la spiritualità umana appare staccata da un’espressione esplicitamente religiosa. La vita spirituale delle persone non è morta: semplicemente si sta sviluppando fuori della Chiesa”.
Il rischio che questo richiamo possa risultare vuota petizione di principio è grande tanto quanto – non di meno, non di più – il rischio che una certa concettualizzazione e formalizzazione teologica sia semplicemente muta, incapace di dire alcunché a nessuno. Con tutta la buona volontà – che diamo per certa – di tutti.
Caro Fabio, ti inviterei a leggere i testi di cui qui si parla, poi possiamo iniziare a discuterne. Se hai letto già Sequeri, non sei a digiuno di tecnicismi … Buona lettura
Mi permetto di rimandare ad un mio modestissimo contributo (https://iltuttonelframmento.blogspot.com/2020/05/ascensione.html9 che certamente non è un libro né tantomeno una dissertazione dottorale, come quella del bravo (perché lo conosco) Fenaroli, sperando di non far storcere il naso a qualcuno. Auspico che esso nella sua simplicità e nella sua capacità sintetica permetta di inquadrare la questione dal giusto punto di vista e di farla comprendere anche ai noi adetti ai lavori. Con stima profonda!
Non conosco bene la proposta di Fenaroli e di Gamberini per non averle studiate con la dovuta attenzione. Tuttavia da quello che ho potuto leggere qui mi pare che ci sia una mancanza fondamentale che la teologia non riesce ben a inquadrare: un’ontokogia del corpo che consenta di dire, al di là di tanti tecnicismi (anche linguistici), la singolarità della vicenda di Gesù che è Dio. E a mio avviso si dovrebbe partire – seguendo Sequeri – dal mistero dell’Ascensione che ricapitola e sintetizza questo singolare evento.