
L’abito talare dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù è emblematico della polarità, della dualità o meglio forse della dialettica che il carisma dehoniano si porta dietro, nello stesso Dehon, fin da prima della fondazione della congregazione.
Vuole tenere insieme, nella talare nera, la sensibilità gesuitica – nella quale p. Dehon era stato formato – per la missione e la cultura, e insieme, nel cordone che la stringe, l’amore francescano per i poveri.
È una, non l’unica dialettica, che riscontriamo irrisolte nello spirito della fondazione e che sono passate nel patrimonio spirituale dell’eredità.
Spirituale e sociale
Mettiamone subito in evidenza un’altra, richiamata più volte da p. Yves Lédure nel suo Un prete con la penna in mano:
Se nella vita di Dehon ci sono delle frasi che evidenziano ora un aspetto, ora un altro, in profondità la vena è unica. Dehon respira unicamente un soffio, quello dell’amore divino che egli ripartisce secondo due grandi orientamenti: l’esigenza sociale culturale e la spiritualità di oblazione riparatrice. Egli stesso paragona la sua opera a due solchi che hanno la stessa origine: “Sono stato condotto dalla Provvidenza a scavare molti solchi, ma due soprattutto lasceranno una impronta profonda: l’azione sociale cristiana e la vita di amore, di riparazione e d’immolazione al Sacro Cuore di Gesù. I miei libri, tradotti in più lingue, portano ovunque questa duplice corrente, uscita dal Cuore di Gesù. Deo gratias!” (NQ, XXV/1910, 33) (p. 202).
È una confidenza preziosa da parte di un uomo che non ama autocompiacersi ed è tentato di addossarsi delle colpe anche quando non ne ha. Qui guarda con serenità, quasi soddisfatto e sicuro, alla sua opera. La vede alla convergenza di due fiumi di grazia o, meglio, l’emanazione di due percorsi di grazia da un’unica sorgente:
la preoccupazione degli uomini per l’impegno di realizzare il progetto globale di società e la vita di unione e di oblazione al suo Signore. L’originalità dehoniana consiste in questa articolazione che unisce l’amore per gli uomini e l’amore per Dio, o, come egli stesso scriverà: “l’azione sociale cattolica e il regno del Sacro Cuore” (NQ, XU1916, 68) (p. 203).
Letta da p. Dehon, la «devozione» al Sacro Cuore non si esaurisce né tanto meno si identifica con un insieme di pratiche e di riti. Porta anzi in se stessa una connotazione essenziale, costitutiva, di «incompiutezza»: fare proprio questo atteggiamento significa avviarsi lungo un itinerario spirituale, e per questo storico, che è compiuto solo nei termini dell’escatologia: già e non ancora. Dove il «non ancora» è esattamente il fondamento dell’opportunità data a noi, della nostra con-vocazione a partecipare al mistero di Cristo.
Le nostre Costituzioni riprendono, al n. 23: «Così noi intendiamo la riparazione: come accoglienza dello Spirito (cf. 1Ts 4,8), come una risposta all’amore di Cristo per noi, una comunione al suo amore per il Padre e una cooperazione alla sua opera di redenzione all’interno del mondo». E al n. 28: «Avidi dell’intimità del Signore, cerchiamo i segni della sua presenza nella vita degli uomini, dove opera il suo amore che salva».
Cosa ha detto e cosa dice alla mia vita questa lettura dehoniana del mistero di Gesù: che essere devoto del Sacro Cuore, essermi a lui consacrato significa consegnarmi, abbandonarmi, a questa condizione di incompiutezza. Accettare di non poter mai stendere lo striscione orgoglioso «missione compiuta». Permanere in questa vocazione di spola fra ricerca della fonte della grazia, l’Agape di Dio, e, senza trattenerla, trovare la strada per farne eucaristicamente dono quotidiano a coloro con i quali Dio mi ha dato di vivere questi giorni della mia vita.
Regno del Sacro Cuore nelle anime e nella società
Un secondo filone dialettico che innerva la vita della congregazione nascente, ma che segnerà in altri termini e secondo altre modalità la vita della congregazione, senz’altro della sua porzione italiana, è quello che vede maturare, per una lunga stagione che va dalla Rerum novarum alla prima metà del secolo scorso, una missione sociale e politica dalla saldatura fra la devozione al Sacro Cuore e la dottrina sociale che si viene sistematizzando sotto l’egida di Cristo Re.
«L’enciclica Annum sacrum di Leone XIII, del 25 maggio 1899, afferma che la devozione al Sacro Cuore ha la sua ragione teologica proprio nella regalità sociale di Cristo. Infatti, il coronamento del culto pubblico al Sacro Cuore fu l’istituzione della festa liturgica di Cristo Re» (Flavio Peloso). Il 1925 è anche l’anno della istituzione di questa festa, nel decennio che vede la costruzione a Roma della “nostra” Basilica del Sacro Cuore di Cristo Re. Interessanti in proposito gli studi di Fulvio De Giorgi e Daniele Menozzi. L’evoluzione frontista e rivendicativa di questo connubio arriva in Italia fino al Concordato; assumerà le forme del collateralismo negli anni della prima repubblica e si capovolgerà, dopo il Concilio, nel fondamento ecclesiologico e spirituale offerto dalla spiritualità del Sacro Cuore alle forme sociali della riparazione piuttosto che all’intransigentismo abbarbicato agli stendardi di Cristo Re.
Nel gennaio del 1889 – a cent’anni dalla Rivoluzione francese e a 200 dalla richiesta a Margherita Maria Alacoque di consacrare la Francia al Sacro Cuore – p. Dehon pubblica il primo numero di una rivista programmata come mensile dal titolo Le Règne du Coeur de Jésus dans les ames et dans les sociétés. Anime e società.
Il progetto risponde a un atteggiamento di riconquista cristiana, sul piano individuale e sociale. Nella presentazione, p. Dehon prende in prestito le parole da Margherita Maria per dire: “Io regnerò… Regnerò nonostante tutte le opposizioni”.
La pubblicazione raggiunge i 2.000 abbonati, soprattutto tra il clero. P. Dehon smentisce l’opinione diffusa secondo la quale si sarebbe trattato di una pubblicazione di spiritualità e quando nel 1903 si vedrà costretto a chiuderla scriverà: «“Essa era il banco di prova dei miei studi sociali, che scrivevo sulla rivista, prima di pubblicarli in un volume” (NQ, XVIII/1903, 122), aggiungendo che questo orientamento, tipico di un nuovo modo di presenza della Chiesa in una società in via di secolarizzazione, gli ha fatto perdere molti abbonati della prima ora. Vediamo così che, nello spirito di padre Dehon, Le Règne si integra esplicitamente nel suo intento di un “progetto globale di società”, fatto di impegno e di riflessione».
Questa prospettiva, questa preoccupazione definiscono lo scopo della rivista, come lascia trasparire una frase molto forte nella presentazione della stessa: «Il culto del Cuore di Gesù – scrive Dehon – per noi non è una semplice devozione, ma un vero rinnovamento di tutta la vita cristiana e l’avvenimento più importante dopo la redenzione. Questo pensiero guida tutti gli sforzi del nostro apostolato ed è, del resto, la ragion d’essere di questa rivista» (OSC, I, 7)
«L’originalità dehoniana consiste proprio in questa articolazione di campi che finora si ignoravano. Da questo punto di vista, Dehon appartiene alla generazione che assiste agli ultimi scricchiolii della cristianità prima del suo crollo. Conserva la devozione al Cuore di Cristo, sviluppatasi nel medioevo, ma che non potrebbe più esprimere l’omogeneità tra società e cristianesimo, come era stato dopo Margherita Maria. Non volendo farne né uno strumento reazionario né un ripiego impotente nell’interiorità soggettiva, gli conferisce un nuovo luogo di espressione, lo spazio della società. … Dehon milita per una presenza della Chiesa a livello della società. Al posto di uno scontro sterile e costoso con lo Stato, egli preconizza un’azione a livello della società civile» (pp. 155 e 159).
Nel suo (primo) libro di spiritualità, La retraite du Sacré-Coeur, pubblicato nel 1896, p. Dehon si rivolge a un immaginario partecipante al ritiro con queste parole messe sulla bocca di Gesù: «Lasciar regnare il mio cuore nella tua vita interiore e lavorare con la preghiera e l’azione al regno del mio Cuore nella società: questo dev’essere il proposito dei tuoi esercizi spirituali. (OSP, I, 233)».
La spiritualità del Sacro Cuore pensata e vissuta da p. Dehon unisce prospettiva mistica e progetto di società.
Ciò che al tempo di Dehon era percepito e vissuto come una semplice devozione, con Dehon diventa un processo di rinnovamento dello stesso cristianesimo e della società. Egli lotterà per far uscire la spiritualità del Sacro Cuore dalla sfera devozionale, persino intimista, nella quale si era rifugiata. Del resto, lavorerà con Leone Harmel per lo stesso tentativo nei confronti del Terz’Ordine francescano, al quale appartiene. In un caso come nell’altro, Dehon vuole articolare vita interiore e zelo apostolico in un senso ampio (p. 156).
La spiritualità del Sacro Cuore è il lievito di questo rinnovamento cristiano e sociale. Il binomio classico in Dehon amore-giustizia si riassume nell’espressione che ricorre costantemente nei suoi scritti: Il regno sociale del Sacro Cuore (la paternità di tale espressione non è dehoniana, ma dell’uruguayano Matovelle).
Siamo in presenza di un “bipolarismo imperfetto” – dove imperfetto è il tempo verbale che indica qualcosa di continuativo nel passato – che diventa “indicativo” e perfino “futuro” della ricchezza dinamica ereditata da p. Dehon.
A 150 anni dalla fondazione il bipolarismo, in tutte le sue espressioni, è ancora lì, e personalmente ritengo questa una grazia, che ci mantiene in tensione nella consapevolezza che non saremo mai pari e tuttavia siamo chiamati, in ogni nostro progetto apostolico, a tenere insieme filoni non sovrapponibili. Noi dehoniani siamo costitutivamente dei “dis-tratti”, dei “dis-adattati”…
La giustizia di cui siamo ministri non ha per simbolo una bilancia. Non si ispira a un codice di diritto. Si ispira al codice delle Beatitudini, è ampiamente asimmetrica. Se non lo fosse, non saremmo operai del Regno, anzi nemmeno ci entreremmo: «Se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei…».
E l’asimmetria della giustizia di cui siamo ministri è anche qui: stiamo dalla parte di chi ha fame, di chi ha torto, per quanto ci voglia un miracolo per rispondere a queste necessità. Ma è proprio nella debolezza del nostro operato che si può manifestare la potenza della grazia.
P. Dehon fa dire al Sacro Cuore: «Il regno del mio Cuore nella società è il regno della giustizia, della carità, della misericordia, della pietà per i piccoli, gli umili e quelli che soffrono. Vi chiedo di dedicarvi a tutte queste opere, di incoraggiarle, di aiutarle. Favorite tutte le istituzioni che devono contribuire al regno della giustizia sociale e che devono impedire l’oppressione dei deboli da parte dei potenti» (OSP, I, 233).
Formazione culturale e impegno sociale
Lo Studentato per le missioni, prima opera italiana strutturata, rispecchia nel suo progetto la prospettiva di una formazione spirituale incardinata sul “più prezioso dei tesori”, il Cuore di Gesù, e la tensione missionaria che gemmerà quasi “per natura” nel Villaggio del Fanciullo e nel Centro Dehoniano.
In questa duplice gemmazione si manifesta e si traduce storicamente un’altra dialettica rimasta generativamente irrisolta nel solco dell’espressione sociale della spiritualità del Sacro Cuore.
Villaggio del Fanciullo e Centro Dehoniano stanno a indicare la volontà di dar seguito alla dimensione sociale della spiritualità dehoniana intesa sia come azione direttamente solidale, sia come animazione culturale (il fascino francescano e gesuita vissuto dallo stesso fondatore).
«Il 6 luglio 1914, a San Quintino, in occasione di una riunione di sacerdoti ordinati nel 1870 [p. Dehon constata]: “La Francia ha due tipi di buoni preti: quelli che esercitano il loro ministero in modo regolare, con solennità, come se tutto andasse per il meglio. Essi sono convinti di essere ancora ai bei tempi. Gli altri, quelli che ricercano le pecorelle smarrite, che sono apostoli e missionari. Sono costoro che bisognerebbe moltiplicare” (NQ, XXXV/1914,77)».
Già da studente di diritto p. Dehon mette in evidenza il mediocre livello di formazione del clero. I progetti tentati per ovviare a questa carenza incontrano lo scarso entusiasmo dei vescovi francesi di allora perché «avevano paura della scienza e della modernità e non li incoraggiano» (p. 31).
Questa urgenza è tanto forte da costituire un dilemma vocazionale, nei suoi anni da studente. Nel 1871
gli si impone un duplice orientamento: la vita religiosa che derivava dalla sua evoluzione spirituale [e] un progetto di studi ecclesiastici che rientri nel rinnovamento dell’insegnamento e della formazione dei futuri chierici. “Da una parte – scrive – desideravo essere religioso; dall’altra, pensavo che per la Chiesa fosse giunto il momento di dedicarsi con nuova cura agli studi superiori per diffondere il suo influsso sulle intelligenze” (NHV, IX,3) (p. 59).
Quella tensione tra spirituale e culturale, che innerva senza risolversi la gestazione della vocazione di p. Dehon, noi l’abbiamo interiorizzata.
«Per sua natura, il nostro Istituto è un istituto apostolico: per questo ci mettiamo volentieri al servizio della Chiesa nei suoi diversi compiti pastorali. Benché non sia stato fondato in vista di un’opera determinata, esso ha ricevuto dal Fondatore degli orientamenti apostolici che caratterizzano la sua missione nella Chiesa» (Cst 30).
«Per Padre Dehon, a questa missione, in spirito di oblazione e di amore, appartiene l’adorazione eucaristica, come un autentico servizio della Chiesa (cf. NQ 1.3.1893), e il ministero dei piccoli e degli umili, degli operai e dei poveri (cf. Souvenirs, XV), per annunciare loro le imperscrutabili ricchezze del Cristo (cf. Ef 3,8).
In vista di questo ministero, Padre Dehon dà una grande importanza alla formazione dei sacerdoti e dei religiosi.
Sollecitudine per l’umano
In tutto questo, egli ha la sollecitudine costante che la comunità umana, santificata nello Spirito Santo, diventi oblazione gradita a Dio (cf. Rm 15,16)» (Cst 31).
La tensione tra spirituale e culturale l’abbiamo vista all’opera nella fondazione della rivista Le Règne du Coeur de Jésus dans les ames et dans les sociétés e la ritroviamo in azione al momento della nascita del periodico italiano che sarà Il Regno, frutto maturo ancorché anticipazione di un modello di rapporto tra Chiesa e società di lì a poco invocato dal Concilio Vaticano II.
Non sembri irriverente la citazione dell’aneddoto emblematico dei primi numeri de Il Regno, quando il solerte co-fondatore p. Giuseppe Albiero, nella copertina dei primi numeri (se ben ricordo) coprì con una nuvoletta il genitivo del titolo primitivo Il Regno del Sacro Cuore. Fu così che, non senza qualche protesta che permarrà a lungo, la rivista indirizzata inizialmente ai benefattori assunse il suo profilo culturale ed ecclesiale più originale, in grado di accompagnare la maturazione nella Chiesa italiana di un cristianesimo consapevole senza essere necessariamente “colto” in senso restrittivamente accademico.
Il Regno ha dato l’intonazione al progetto del Centro Editoriale Dehoniano, che si proporrà, nelle sue variegate proposte editoriali, di accompagnare insieme laici, operatori pastorali e ministri a maturità evangelica e sostenere un dialogo costruttivo e competente con le diverse agenzie sociali.
Il progetto del CED riproduce al suo interno le tensioni che hanno segnato gli inizi del progetto dehoniano. Senza ignorare i diversi emissari dell’intuizione di p. Dehon, il CED darà voce alla formazione ecclesiale con Il Regno, alla formazione culturale con le Edizioni Dehoniane Bologna e la Rivista di teologia morale, alla formazione del clero con Settimana e alla formazione religiosa con Testimoni.
Accompagnerà successivamente lo straordinario rinnovamento catechistico italiano con la rivista Evangelizzare, che metterà in campo un pioneristico protagonismo dei catechisti e delle Chiesa locali in collaborazione organica.
«Sappiamo che il mondo d’oggi è tormentato da un intenso sforzo di liberazione: liberazione da tutto ciò che ferisce la dignità dell’uomo e minaccia la realizzazione delle sue aspirazioni più profonde: la verità, la giustizia, l’amore, la libertà (cf. GS 26-27)» (Cst 36).
«Attraverso gli interrogativi e le ricerche, percepiamo l’attesa di una risposta che l’uomo spera, senza riuscire a formularla adeguatamente. Condividiamo queste aspirazioni dei nostri contemporanei, come possibile apertura all’avvento di un mondo più umano, anche se possono racchiudere il rischio di insuccesso e di degradazione» (Cst 37).
«Lungi dall’estraniarci dagli uomini, la nostra professione dei consigli evangelici ci rende maggiormente solidali con la loro vita. Nel nostro modo di essere e di agire, con la partecipazione alla costruzione della città terrestre e all’edificazione del Corpo di Cristo, dobbiamo testimoniare efficacemente che il Regno di Dio e la sua giustizia devono essere cercati prima di tutto e attraverso tutto (cf. Mt 6,33)» (Cst 38).
Agire a livello culturale si mantiene in dialettica, non in contrapposizione, con l’operare fattivamente per la giustizia sociale, imprimendovi due fondamentali dinamiche:
- arricchire di “pensiero” anche le più basilari forme di solidarietà sociale; quello che abbiamo chiamato «esercizio intelligente della carità», o «fare bene il bene», o «dare il pesce e insegnare a pescare»…
- mettersi in ascolto della domanda urgente di pane, ma anche di tutto ciò che viene dal cuore dell’uomo come domanda di vita, di senso, di amore – perdonate l’uso di questo termine, che ho sempre timore di banalizzare.
Nell’esperienza del CED si palesa, prima ancora di essere tematizzata, la convinzione che ogni ricerca umana, personale, sociale ed ecclesiale, in un continuum integrato, sia possibile solo tenendo insieme queste quattro dimensioni.
È significativo che il CED, prima ancora di essere progetto strutturato, sia nato dalla collaborazione di religiosi, sacerdoti e laici, a tal punto che non si riesce a pensarlo diversamente. La sua storia svilupperà ulteriormente questa sinergia, fino ad approdare alla consegna di punti nevralgici della sua attività redazionale e amministrativa alla competenza di laici.
Cent’anni dello Studentato, “cent’anni di gratitudine” perché la grazia delle origini, che rimonta alle origini della Grazia, non ha annullato le tensioni e anzi ci ha chiamati e abilitati a essere insieme ministri della grazia e della giustizia.
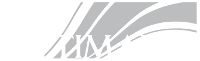





Bell’articolo. Però non ho mai visto in vita mia un Dehoniano con la talare cordonata che viene descritta all’inizio.